Glossario ecologista
LE PAROLE GIUSTE – GLOSSARIO ECOLOGISTA è un dizionario on line pensato per lə addettə dell’informazione. Obiettivo: individuare e declinare le parole necessarie a una radicale trasformazione ecologica e mettere a disposizione di chi lavora nel mondo della comunicazione strumenti, nozioni e concetti chiave

Edizioni Fandango
Il Glossario Ecologista di A Sud diventa un libro, edizioni Fandango
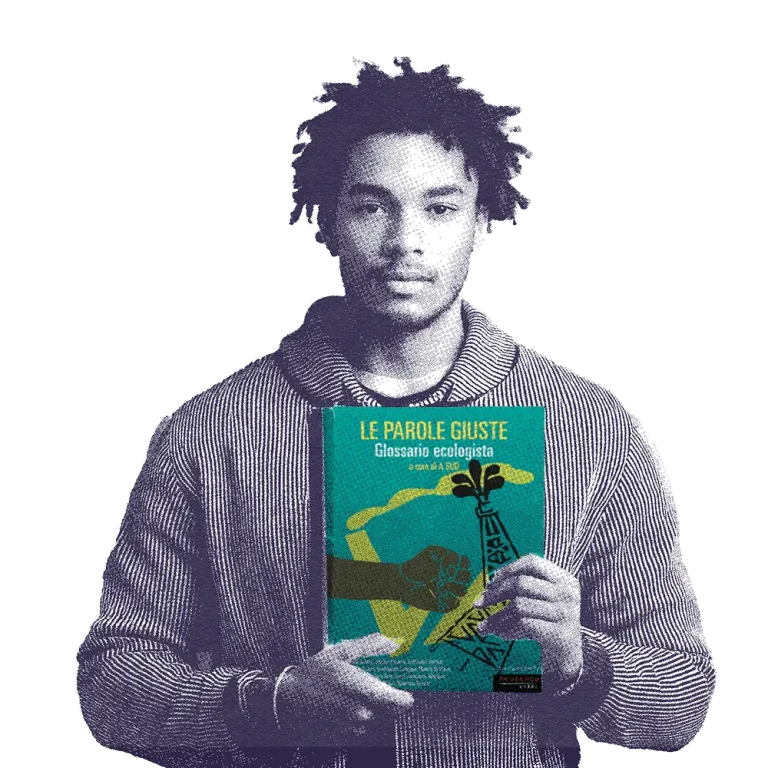
Adattamento
a cura di Marica Di Pierri – giornalista e ricercatrice, A Sud
L’azione climatica si divide in due macro ambiti di azione: la rimozione delle cause della crisi climatica (mitigazione, vedi voce di glossario dedicata) e l’attenuazione degli impatti (adattamento). Le politiche di adattamento rispondono all’esigenza di compensare, prevenire, attutire o correggere gli impatti del climate change, con interventi pianificati a livello territoriale che rafforzino la resilienza del territorio e delle comunità. Il concetto di adattamento fa implicito riferimento all’accettazione di un cambiamento in corso, di fronte al quale si agisce per minimizzare e per quanto possibile prevenire gli effetti avversi. Ciò è possibile in particolare modificando gli usi del territorio in funzione delle nuove caratteristiche ambientali dunque aumentandone la resistenza agli stress e agli schock climatici.
Mitigazione e adattamento si differenziano per taluni rilevanti aspetti. A differenza della mitigazione che ha bisogno di un ampio consenso internazionale e di un’azione ambiziosa e coordinata a livello sovranazionale per avere chance di efficacia, nel caso dell’adattamento le azioni si declinano principalmente a livello territoriale, di conseguenza le difficoltà esistenti sull’adattamento si giocano non tanto sulla difficoltà di trovare un ampio consenso internazionale quanto sui fondi necessari a sostenere gli interventi; in particolare sul trasferimento di tecnologie e risorse finanziarie che, in nome del principio di responsabilità comuni ma differenziate, i Paesi industrializzati dovrebbero versare nelle casse dei Paesi più vulnerabili per sostenere gli interventi di adattamento, oltre che le azioni di mitigazione.
Anche le misure territoriali di adattamento possono avere come conseguenza la violazione dei diritti umani; è il caso, ad esempio, di interventi adattivi che comportano lo sfollamento coatto di comunità locali o che ne stravolgono i costumi economici e sociali. Per evitarlo, è fondamentale progettare e implementare strategie di adattamento improntate alla tutela dei diritti umani mettendo le comunità locali al centro della pianificazione e pr4estando particolare attenzione ai bisogni delle fasce piu vulnerabili: donne, minori, anziani.
Ciò premesso, per quanto capillarmente diffuse e implementate, le sole azioni di adattamento non hanno tuttavia la possibilità di garantire sufficiente efficacia all’azione climatica in quanto i tempi e le dinamiche con cui gli impatti climatici vanno manifestandosi alle diverse latitudini e longitudini sono molto variabili, ben più incerti e senza la prospettiva di lungo termine che avrebbe un’azione globale volta alla rimozione delle cause della crisi climatica.
Per approfondire:
- MASE, Piano Nazionale Adattamento Cambiamenti Climatici, 2023.
- European Environmental Agency, Adattamento e mitigazione, 2023
Antispecismo
a cura di Irene De Marco – A Sud
L’antispecismo come movimento politico e filosofico si oppone alla discriminazione basata sulla specie e promuove l’uguaglianza e i diritti per tutti gli esseri viventi, indipendentemente dalla loro appartenenza biologica. Questo movimento critica l’antropocentrismo e propone una visione etica inclusiva e intersezionale, che riconosce la dignità intrinseca di ogni essere senziente. Il pensiero antispecista si basa sulla consapevolezza che le capacità di sentire, interagire con l’ambiente, manifestare volontà e intrattenere relazioni sociali non siano esclusive della specie umana. Pertanto, attribuire tali capacità agli animali non umani richiede un nuovo status etico che consideri moralmente rilevanti gli interessi di tutti gli esseri senzienti.
Jeremy Bentham, nel XVIII secolo, fu tra i primi a promuovere un approccio etico che include tutti gli animali nella stessa comunità morale, sebbene non abbia messo in discussione il diritto umano di sfruttare gli animali per scopi umani. Successivamente, Peter Singer e Tom Regan hanno sviluppato filosofie antispeciste distinte ma complementari, basate rispettivamente sull’approccio utilitarista e deontologico. Singer enfatizza la sensibilità degli esseri senzienti e il principio di uguaglianza degli interessi, mentre Regan si concentra sui diritti morali fondamentali degli animali non umani. Entrambi gli approcci mirano a sfidare la concezione degli animali come strumenti a disposizione dell’uomo e a promuovere una visione etica che trascende i confini della specie.
La discriminazione basata sulla specie (o specismo) è vista come parallela e intrecciata con altre forme di oppressione, come il sessismo, il razzismo e la discriminazione di genere. Un approccio intersezionale combatte tutte queste forme di oppressione contemporaneamente, riconoscendo che esse si rafforzano a vicenda. Ad esempio, il patriarcato non solo opprime le donne, ma sfrutta anche gli animali come simboli di debolezza e sottomissione, perpetuando una cultura di dominio e violenza.
Per approfondire:
- Singer P., Animal Liberation, HarperCollins, 1975 (Edizione italiana: Singer P., Liberazione animale, il Saggiatore, 2010)
- Regan T., I diritti animali, Garzanti, 1990.
- Adams C. J., The Sexual Politics of Meat, Bloomsbury, 1990.
- Spiegal M., The Dreaded Comparison – Human and Animal Slavery, Mirror Books IDEA, 1997.
- Colling S., Animali in rivolta Confini, resistenza e solidarietà umana, Mimesis edizioni, 2017.
- Maurizi M., Antispecismo politico. Scritti sulla liberazione animale, Ortica edizione, 2022.
Antropocene
a cura di Marica Di Pierri – giornalista e ricercatrice, A Sud
Il termine Antropocene, utilizzato per la prima volta dal biologo Eugene Stroermer negli anni ’80, si impose 20 anni dopo, quando il Premio Nobel per la chimica Paul Josef Crutzen lo portò alla ribalta nel saggio “Benvenuti nell’Antropocene”. Il termine sottolinea che i mutamenti prodotti dalle attività umane sul pianeta, a partire dalla rivoluzione industriale, hanno modificato in maniera così profonda e permanente la geologia e gli ecosistemi da determinare l’ingresso del sistema terra in una nuova fase geologica caratterizzata dall’impatto antropico.
Anche da un punto di vista geologico, l’Antropocene è caratterizzato da mutamenti nelle rocce e nei sedimenti terrestri destinati a rimanere visibili per milioni di anni. Esaminando marker come radionuclidi di origine antropica, plastica, carbonio e altri sedimenti si è osservato che i cicli di carbonio, azoto e fosforo risultano modificati e che innalzamento dei mari, perdita di specie e disequilibri ecologici e climatici di origine antropica appaiono rendono l’Antropocene distinto e dalle epoche precedenti. Da questa evidenza è nato, in seno all’Unione Internazionale delle Scienze Geologiche l’Anthropocene Working Group – AWG che dal 2009 ha lavorato alla possibilità di riconoscere una nuova unità di tempo geologica. Nel 2016 l’AWG ha presentato un documento preliminare, pubblicato anche su Science, in cui opinione maggioritaria vedeva con favore alla formalizzazione dell’Antropocene come era geologica. Nel 2019 l’AGW a schiacciante maggioranza ha votato a favore del riconoscimento della nuova era geologica ponendo le basi per una proposta formale da presentare alla Commissione internazionale di stratigrafia, che nel marzo 2024 ha però respinto la proposta.
Al di là dell’ipotesi scientifica il termine è largamente adottato non solo dagli studiosi: è divenuto di uso nel linguaggio comune, nella retorica politica e nel discorso mediatico. Nel 2012, la celebre Treccani ha inserito il lemma nella sezione Lessico del XXI Secolo e dell’enciclopedia. Il concetto ha dunque raggiunto un’ampia diffusione, a conferma di un’ormai generalizzata percezione del ruolo dell’essere umano come specie capace di modificare e metterne a rischio gli equilibri planetari.
Per una lettura critica della nozione di Antropocene, si veda anche il lemma “Capitalocene” del presente glossario.
Per approfondire:
- Crutzen P., Benvenuti nell’Antropocene. L’uomo ha cambiato il clima, la Terra entra in una nuova era, Mondadori, 2005.
- Anthropocene Working Group, sito web della Subcommission on Quaternary Stratigraphy.
- Waters C.N., Zalasiewicz J., et al, The Anthropocene is functionally and stratigraphically distinct from the Holocene, Science, 2016.
- Antropocene, Enciclopedia Treccani, in Lessico del XXI Secolo, 2012.
- Armiero M., De Angelis M., Anthropocene: Victims, Narrators, and Revolutionaries, in: South Atlantic Quarterly , Duke University Press, 2017.
Apartheid climatico
a cura di Marica Di Pierri – giornalista e ricercatrice, A Sud
La parola apartheid (letteralmente segregazione) è legata all’esperienza di discriminazione imposta in Sud Africa ai danni della comunità nera. Nel 2019 è stata declinata in ambito climatico dal ricercatore Philip Alston, esperto di diritto internazionale e Relatore Speciale per le Nazioni Unite su povertà estrema e diritti umani.
Il concetto di Apartheid climatico è stato utilizzato da Alston nel report Cambiamenti climatici e povertà, per evocare uno scenario distopico in cui mentre i ricchi potranno proteggersi dalle conseguenze più devastanti del riscaldamento globale, le popolazioni più vulnerabili si troveranno senza difese ed esposte a crisi alimentari, siccità, disastri climatici e alle malattie e ai conflitti che ne deriveranno. La crisi climatica rischia così di annullare gli ultimi 50 anni di progressi nello sviluppo, nella salute globale e nella riduzione della povertà.
La tesi si basa su uno studio dell’Università di Stanford, pubblicato sulla rivista dell’Accademia Americana delle Scienze che evidenzia il ruolo dei cambiamenti climatici sul divario tra paesi poveri e ricchi, minacciando non solo i diritti fondamentali ma anche democrazia e stato di diritto. Secondo lo studio, nel periodo 1961-2010 le disuguaglianze tra i Paesi si sono accentuate per effetto del riscaldamento globale, con la maggioranza dei Paesi ricchi più ricca di quanto sarebbe stata senza climate change, mentre la ricchezza pro capite nei paesi poveri si è ridotta nello stesso periodo di un ulteriore 17-30%.
Il report di Alston ha contribuito a leggere i cambiamenti climatici come fattore che esacerba le disuguaglianze economiche e sociali e come uno dei principali fattori di segregazione del XXI secolo. Secondo il report gli impatti climatici “potrebbero spingere entro il 2030 più di 120 milioni di persone in più sotto la soglia di povertà e avranno l’impatto più grave proprio nei Paesi poveri e nelle regioni e nei luoghi in cui i poveri vivono e lavorano”. Una delle conseguenze di questa evidenza à la necessità di evitare di privatizzare welfare e servizi essenziali per garantire accesso universale. In quest’ottica, la riduzione delle emissioni climalteranti è imprescindibile per garantire il rispetto dei diritti umani.
Per approfondire:
- UNHRC, United Nation Human Right Council, Climate change and poverty, Report of the Special Rapporteur on extreme poverty and human rights, 2019.
- Diffenbaugh N.S., Burke M., Global warming has increased global economic inequality, Proceedings of the National Academy of Sciences – PNAS, 2019.
Apprendimento esperienziale
A cura di Jessica Ferretti ― educatrice e formatrice, A Sud
Per apprendimento esperienziale si intende un processo di apprendimento che ha inizio attraverso esperienze che coinvolgono in prima persona il soggetto. David Kolb, educatore e pedagogista statunitense, ha proposto un modello per definire l’apprendimento esperienziale basato su 4 fasi: esperienza concreta, osservazione riflessiva, concettualizzazione astratta e sperimentazione attiva. L’esperienza diretta coinvolge la dimensione cognitiva, quanto quella motorio-percettiva ed emotivo-affettiva. Con osservazione riflessiva si intende la capacità di soffermarsi a pensare con attenzione su quanto vissuto. La concettualizzazione astratta rappresenta il momento dell’apprendimento in cui viene attivato il pensiero logico, dove i concetti vengono integrati con le precedenti osservazioni riflessive. La sperimentazione attiva prevede un agire che è una verifica di quanto si è vissuto, che ha generato il processo riflessivo e la consecutiva organizzazione in concetti.
È importante considerare che ciascuna fase di questo modello non va intesa in maniera netta e distinta, bensì una tappa i cui contorni sfumano tra quella precedente e quella successiva. Al termine di ogni ciclo di Kolb, un’ esperienza viene incorporata come apprendimento e il processo procede come una spirale senza fine, pertanto da una esperienza appresa si riparte per nuovi apprendimenti. È importante ricordare che l’idea di esperienza di Kolb si rifà al concetto di esperienza proposto dal filosofo e pedagogista statunitense, John Dewey.
Considerato il padre dell’attivismo pedagogico, Dewey valorizza il fare, l’azione e nei percorsi educativi assume un ruolo centrale l’esperienza, intesa come processo. Dewey specifica che non tutte le esperienze sono necessariamente significative per un individuo e solo se sono significative porteranno a un apprendimento, ovvero all’acquisizione di nuove conoscenze e di abilità. L’apprendimento esperienziale è riscontrabile in qualsiasi individuo senza distinzioni di età.
Per approfondire:
- Dewey J., Esperienza e educazione, Raffaello Cortina Editore, 2014.
Attribution Science
a cura di Salvatore Paolo De Rosa – ricercatore Università di Copenhagen
L’attribution science è una branca della scienza che isola gli effetti dell’influenza umana sul clima e sui relativi sistemi terrestri. Comprende un insieme di metodologie scientifiche per l’attribuzione degli eventi meteorologici estremi, dei cambiamenti climatologici persistenti e degli impatti a insorgenza lenta (come il ritiro dei ghiacciai o l’innalzamento del livello del mare) al riscaldamento globale di origine antropica. Progressi recenti consentono anche di stimare la percentuale di CO2 nell’atmosfera attribuibile a una singola azienda o paese, e in che misura quelle emissioni contribuiscono agli effetti complessivi dei cambiamenti climatici.
Le metodologie sviluppate per attribuire singoli eventi meteorologici estremi hanno rivoluzionato la scienza del clima, facilitando la quantificazione probabilistica della misura in cui tali eventi sono influenzati dalle emissioni di origine antropica. Gli eventi estremi sono il modo principale in cui le persone sperimentano i cambiamenti climatici. L’attribution science permette di collegare i processi scaturiti dall’accumulo storico di emissioni climalteranti con gli impatti che influenzano concretamente la vita sociale.
Nel sostenere le istanze sociali e le azioni legali promosse da movimenti sociali e ONG, l’attribution science potrebbe contribuire alle politiche di mitigazione e adattamento e alimentare le mobilitazioni dal basso delle comunità colpite o vulnerabili. Frequenza, entità e costi degli eventi estremi impongono l’urgenza di concentrarsi sulla vulnerabilità sociale e sulle interazioni tra vulnerabilità, rischi mutevoli e strutture di potere.
Per approfondire:
- World Weather Attribution, sito web.
- Carbon Brief, sito web.
- Lliuva L., Contenzioso climatico, Climate Change Litigation Database, 2015.
Biocarburanti
A cura di Andrea Turco ― giornalista, Economiacircolare.com
I biocarburanti sono «carburanti liquidi per il trasporto ricavati dalla biomassa» (definizione UE). Le biomasse che fungono da materie prime per i biocarburanti sono tante: si va dalle colture foraggere, come la palma e la soia, ai rifiuti e ai loro sottoprodotti, come gli oli esausti e i grassi animali. Vengono miscelati ai combustibili fossili e hanno l’obiettivo di contribuire a ridurre le emissioni di gas a effetto serra nel settore dei trasporti. Allo stesso tempo i biocarburanti contendono le materie prime di approvvigionamento ad altri settori, ad esempio i prodotti cosmetici e farmaceutici. Ciò ne influenza la disponibilità e i prezzi, ponendo inoltre questioni etiche riguardanti l’ordine di priorità tra beni alimentari e carburanti. Su spinta di Eni, che ha riconvertito le raffinerie di Porto Marghera (2014) e Gela (2019) alla produzione di biocarburanti, anche l’Italia punta molto su questi combustibili. Con l’obiettivo di proseguire l’uso delle auto a combustione termica.
Per approfondire
- Corte dei Conti UE, Il sostegno dell’UE ai biocarburanti sostenibili nei trasporti – Una strada incerta, ECA UE, dicembre 2023.
- ECCO, Biocarburanti: impatti e rischi per una strategia allineata a 1,5°C, dicembre 2023.
- Transport & Environment, Carburanti biologici e sintetici: tutto ciò che bisogna sapere, marzo 2023.
Biocidio
A cura di Rete Stop Biocidio e Marco Armiero ― storico dell’ambiente, ICREA/UAB
Il termine biocidio è direttamente collegato alla categoria di ecocidio, un concetto sviluppato nel contesto dell’opposizione all’intervento statunitense nel Vietnam (1965-1973). Quando iniziarono a trapelare le notizie sull’uso dell’agente Orange da parte dell’esercito statunitense diversi scienziati si mobilitarono denunciando le conseguenze sistemiche dell’impiego militare di quel diserbante tanto sugli umani che sui non umani. Il concetto di ecocidio legava dunque direttamente la riflessione scientifica e l’attivismo politico: gli scienziati si opponevano alla guerra e all’uso di armi chimiche nel conflitto, senza temere di essere accusati di mischiare scienza e politica. La storia del concetto di biocidio ugualmente vede una convergenza con l’attivismo ambientalista. Fu nel 2012 che una coalizione di gruppi ambientalisti campani iniziò a usare l’espressione biocidio per indicare la contaminazione da rifiuti tossici che interessava e ancora interessa le province di Napoli e Caserta.
Se i dizionari ci informano che il vocabolo biocidio dovrebbe significare “strage di animali”, le attiviste e gli attivisti campani hanno connesso quel termine alla sua radice profonda che rimanda all’uccisione della vita tout court. In questa accezione ampia il biocidio può essere definito come l’insieme di pratiche che influiscono sul sistema vivente producendo malattia e/o morte. Invece di interpretare la contaminazione da rifiuti tossici come un incidente o anche un crimine isolato, la categoria di biocidio ha consentito di darne una interpretazione sistemica e attiva, nel senso che è dotata di un soggetto che la attua.
Il biocidio rivela che la contaminazione non è un errore nel sistema e non accade per caso, ma è un sistema che subordina la difesa della vita al profitto di pochi. Dal punto di vista teorico, la genealogia del concetto di biocidio conferma quello che diversi studiosi ribadiscono, ovvero che i saperi non si generano solo in ambito accademico ma anche tra attivisti e nell’interazione tra questi ultimi e ricercatori.
Per approfondire:
- Conde M. Activism mobilising science, in: Ecological economics 105, 2014.
- De Rosa S. P., A political geography of ‘waste wars’ in Campania: Competing territorialisations and socio-environmental conflicts. in: Political Geography 67, 2018.
- Falcone P.M., et al. When all seemed lost. A social network analysis of the waste-related environmental movement in Campania, Italy, in: Political Geography 77, 2020.
- Zierler D.. The invention of ecocide: Agent Orange, Vietnam, and the scientists who changed the way we think about the environment. University of Georgia Press, 2011.
Biodiversity Offsets
A cura di Carlotta Indiano – giornalista
Le compensazioni di biodiversità o crediti di biodiversità sono attività di conservazione della biodiversità misurabili e concepite per compensare gli impatti negativi e inevitabili dei progetti, in aggiunta alle misure di prevenzione e mitigazione già attuate. Si ritengono appropriate solo per i progetti che hanno già applicato rigorosamente la gerarchia di mitigazione. Le compensazioni di biodiversità devono quindi essere una misura di ultima istanza. L’obiettivo delle compensazioni è quello di non ottenere una perdita netta (NNL, no net loss) e preferibilmente un guadagno netto (NG, net gain) di biodiversità quando i progetti vengono realizzati. Il raggiungimento di NNL/NG dipende da schemi di compensazione misurabili, adeguatamente implementati, monitorati, valutati e applicati.
Per approfondire:
- International Union for Conservation of Nature, Biodiversity Offsets Issues Brief, febbraio 2021.
- Carbon Brief, What are biodiversity offsets?, settembre 2023.
- Green Finance Observatory, The neoliberal fallacy of nature market, maggio 2023.
Biomateriali
A cura di Daniele Di Stefano – giornalista Economiacircolare.com
Quando si ragiona di sostenibilità ambientale, i biomateriali sono i materiali di origine biologica: da quelli più tradizionali come il legno o il cotone a quelli più innovativi come le bioplastiche derivate da prodotti vegetali o i prodotti chimici ottenuti sfruttando il metabolismo dei batteri
I biomateriali sono sostenibili? Non sempre. Il primo aspetto da valutare per giudicare della sostenibilità dei biomateriali (bioplastiche in primo luogo) è l’origine. La produzione di materia prima agricola per realizzarle può aumentare la pressione sugli ecosistemi: a causa degli agrofarmaci o alimentando i cambi di destinazione d’uso dei terreni a svantaggio di aree naturali. O può andare in competizione con prodotti che servono all’alimentazione (positivo invece il caso in cui derivano da scarti dell’agricoltura, della produzione agroalimentare o dai rifiuti organici domestici, creando materia prima mentre risolvono il problema della gestione dei rifiuti).
Ci sono poi caratteristiche intrinseche dei materiali da tenere in considerazione: non tutte le bioplastiche sono biodegradabili e compostabili. La stessa biodegradabilità di un materiale non lo rende sostenibile: il Programma delle nazioni unite per l’ambiente (UNEP) in uno studio ha affermato ad esempio che le bioplastiche sono sostenibili in alcuni contesti (dove sussistono buoni sistemi di raccolta e gestione dei rifiuti) mentre non lo sono in altri dove possono contaminare la raccolta differenziata della plastica fossile e comprometterne il riciclo. Spesso poi nei prodotti per il mercato finale i biomateriali sono combinati con materiali non biodegradabili che ne rendono impossibile il riciclo. Anche l’impiego che si fa delle bioplastiche incide sulla loro sostenibilità. Sempre l’UNEP afferma che la soluzione ‘facile’ della sostituzione degli imballaggi monouso in plastica col monouso di altro materiale, anche quando questo è biodegradabile, spesso “non rappresenta una soluzione”.
Per approfondire:
- Biomateriali, in: Glossario EconomiaCircolare.com
Capitalocene
a cura di Marica Di Pierri – giornalista e ricercatrice, A Sud
Il concetto di Capitalocene nasce dalla lettura critica della nozione di Antropocene (alla cui voce di glossario si rimanda per approfondimenti). Mentre l’Antropocene fa riferimento al ruolo delle attività umane tout-court considerate come causa della profonda e irreversibile modifica degli equilibri terrestri, il concetto di Capitalocene specifica questa riflessione evidenziando il ruolo del modello economico dominante nella produzione delle crisi planetarie.
Di particolare interesse appare in tal senso la ricostruzione operata dallo storico dell’ambiente Jason W. Moore. Nel saggio Antropocene o Capitalocene? Moore mette in evidenza, riprendendo il filone di ragionamento avviato da Andreas Malm, i limiti del concetto di Antropocene, individuabili nel non attribuire centralità al ruolo della storia economica e delle sue conseguenze ambientali. In altre parole, non sono le attività umane in quanto tali ad aver originato la crisi ecologica planetaria, che ì piuttosto da considerarsi come espressione specifica “dell’organizzazione economica capitalistica”.
Il concetto di Capitalocene si riferisce in altre parole alla necessità di analizzare la crisi ecologica attraverso la ricerca delle responsabilità storiche, individuando nel modello economico capitalista – cui insita caratteristica è la dominazione dell’umano sulla natura – il fattore scatenante del degrado ambientale globale complessivamente inteso.
Per approfondire:
- Moore J.W., Antropocene o Capitalocene. Scenari di ecologia-mondo nella crisi planetaria, Ombre Corte, 2017.
- Malm A., The Anthropocene Myth, Blaming all of humanity for climate change lets capitalism off the hook , in Jacobin, 2015.
- Armiero M., De Angelis M., Anthropocene: Victims, Narrators, and Revolutionaries, in: South Atlantic Quarterly , Duke University Press, 2017.
Carbon Budget
a cura di Lucie Greyl – antropologa, presidente CDCA
Partendo dal presupposto che l’aumento delle temperature e l’incalzare dei cambiamenti climatici sono direttamente legati alla quantità di gas serra emessi in atmosfera, uno dei principali strumenti messi a punto dalla scienza del clima per misurare la quantità di emissioni è rappresentato dal carbon budget.
Il Carbon budget è una metodologia di calcolo funzionale alla pianificazione e al monitoraggio delle politiche climatiche e al taglio delle emissioni di gas serra: permette di quantificare quante emissioni a livello globale o relative a un determinato soggetto (un paese, un insieme di paesi, ma può applicarsi anche a una singola impresa) ha emesso e quanto può ancora emettere in un determinato arco di tempo, al fine di limitare l’aumento delle temperature entro uno specifico livello. Per realizzare le operazioni necessarie a calcolare il carbon budget gli scienziati usano dati e sistemi di calcolo basati sulla miglior scienza disponibile in campo climatico.
Il carbon budget non è solo un indicatore della quantità di emissioni che sarebbe possibile rilasciare in atmosfera per centrare l’obiettivo di contenimento delle temperature previsto dall’Accordo di Parigi ma permette anche di monitorare quanto gli sforzi di mitigazioni messi in campo da uno o più attori siano sufficienti e allineato con i target di riduzione nazionali o sovranazionali e/o con gli impegni internazionali. In tal senso rappresenta un importante strumento politico.
Dal punto di vista metodologico, il carbon budget può variare in base agli indicatori presi in esame, a partire per esempio dalle soglie di aumento di temperatura previste dall’Accordo di Parigi e discusse negli ultimi anni dall’IPCC. I calcoli infatti cambieranno di molto se si considera un obiettivo di contenimento delle temperature medie a fine secolo entro +1.5°, 1,7°, o 2°C. Queste variazioni possono essere anche legate ai settori emissivi presi in esame, ai gas considerati e all’arco di tempo contemplato. Per quanto centrale nella scienza del clima e nelle raccomandazioni dell’IPCC ai policy makers, c’è ancora molta strada da fare rispetto all’utilizzo del carbon budget applicato al livello nazionale come strumento politico. L’Italia, ad esempio, non prevede il calcolo di un suo carbon budget come strumento di orientamento e indirizzo per le politiche di riduzione delle emissioni a livello nazionale e il metodo non trova alcun riferimento a livello normativo.
Per approfondire:
- IPCC, IPCC Sixth Assessment Report. Working Group 1. Climate Change 2021: The Physical Science Basis, 2021.
- IPCC Italia, Budget di carbonio, risorsa web.
- Carbon Tracker Explainer, What are Carbon Budgets & the Carbon Bubble? Carbon Tracker Explainer, 2018.
Carbon markets
A cura di Carlotta Indiano – giornalista
I mercati del carbonio sono sistemi di scambio o mercati finanziari specializzati in cui vengono venduti e acquistati crediti di carbonio. I crediti di carbonio sono essenzialmente permessi che consentono all’acquirente di emettere una certa quantità di anidride carbonica o di altri gas a effetto serra. Le aziende o i privati possono utilizzare i mercati del carbonio per compensare le proprie emissioni di gas serra acquistando crediti di carbonio da entità che eliminano o riducono le emissioni di gas serra.
Un credito di carbonio negoziabile equivale a una tonnellata di anidride carbonica o alla quantità equivalente di un altro gas serra ridotto, sequestrato o evitato. Quando un credito viene utilizzato per ridurre, sequestrare o evitare le emissioni, diventa una compensazione e non è più negoziabile.
Si tratta di uno strumento che, dalla sua istituzione nell’ambito del Protocollo di Kyoto, ha acquisito particolare centralità nell’ambito della governance climatica e nella realizzazione dell’obiettivo net zero di decarbonizzazione (si veda lemma dedicato). Molte sono le critiche mosse al meccanismo carbon market dalle organizzazioni ecologiste e dai movimenti per la giustizia climatica, considerato una misura di finanziarizzazione e dunque una falsa soluzione alla crisi climatica (si veda lemma dedicato). In quest’ottica i crediti di carbonio si traducono sostanzialmente in lasciapassare per continuare a rilasciare gas serra in atmosfera, fungendo da ostacolo all’adozione di misure reali di riduzione delle emissioni da combustione di fonti energetiche fossili.
Per approfondire:
- United Nation Development Program, What are carbon markets and why are they important?, maggio 2022.
- Survival International, Blood Carbon: how a carbon offset scheme makes millions from Indigenous land in Northern Kenya, marzo 2023.
CCS – Cattura e Sequestro del Carbonio
A cura di Carlotta Indiano ― giornalista
La CCS, carbon capture and storage, ovvero cattura e stoccaggio dell’anidride carbonica nasce circa 50 anni come tecnologia proposta delle industrie fossili allo scopo di riutilizzare la CO2 immettendola nei giacimenti esauriti di petrolio e di gas per consentire il recupero degli ultimi residui, mantenendo dunque una finalità estrattiva. Considerata attualmente una soluzione climatica di transizione è promossa dall’industria dell’’oil and gas come tecnologia di decarbonizzazione.
Per approfondire:
- Institute for Energy and Economics and Financial Analysis, The carbon capture crux: lesson learned, settembre 2022.
- International Energy Agency, Net Zero Roadmap: A Global Pathway to Keep the 1.5 °C Goal in Reach, settembre 2023.
- International Energy Agency, The Oil and Gas Industry in net zero transition, novembre 2023.
Citizen Science
Si rimanda alla voce del Glossario: “Open Science”
Climate litigation
a cura di Marica Di Pierri – giornalista e ricercatrice, A Sud
Con il termine climate litigation, o contenzioso climatico, ci si riferisce ad una categoria di azioni legali che vertono su questioni climatiche. La definizione adottata dalla UNEP include diversi tipi di azioni (civili, amministrative, costituzionali etc) intentate a livello internazionale, federale, statale o locale in cui si sollevano argomenti riguardanti i cambiamenti climatici, che possono riguardare cause, impatti, politiche pubbliche, condotte d’impresa, etc. Si tratta di un campo in rapida espansione: nel 2017 la UNEP censiva 884 azioni in 24 paesi; nel 2023 si contavano ben 2180 azioni in 65 giurisdizioni. Dopo la sigla nel 2015 dell’Accordo di Parigi i casi sono rapidamente aumentati. Il fenomeno ha assunto particolare rilievo divenendo una nuova frontiera dell’azione in ambito climatico e dimostrando di poter svolgere un importante ruolo di stimolo.
Sono possibili diverse classificazione delle climate litigation. Una delle più rilevanti riguarda la tipologia di convenuto: Stati, imprese o altre autorità. La maggior parte delle azioni riguarda gli Stati e chiama in giudizio direttamente le autorità statali contestandone l’inazione climatica, l’inadeguatezza delle politiche o il mancato rispetto dei target. Altra tipologia è rappresentata dalle cause contro imprese private, numericamente inferiori seppur in crescita. Queste cause sono rivolte a imprese climalteranti, ad esempio multinazionali dedite allo sfruttamento di combustibili fossili. Una prima importante vittoria è stata ottenuta nel 2021 in Olanda, con la condanna di Shell a ridurre le emissioni del 45% entro il 2030. La terza tipologia riguarda azioni contro progetti considerati incompatibili con l’azione climatica; si tratta anche in questo caso di azioni contro autorità pubbliche.
Tra i più significativi casi di contenzioso climatico si citano: Urgenda vs. Olanda; Neubauer et al. vs. Germania, Milieudefensie et al. vs. Royal Dutch Shell; Notre Affaire à Tous and Others vs. France; Held vs. Montana, A Sud et al vs. Italia. Per un’ampia casistica si rimanda al database on line curato dal Sabin Centre della Columbia University.
Per approfondire:
- Sabin Centre for Climate Change Law, Climate Change Litigation Database.
- Di Pierri M., Il contenzioso climatico, origine, prospettive e questioni giuridiche. Editoriale Scientifica, 2024.
- UNEP – United Nations Environment Programme. Global Climate Litigation Report: 2023 Status Review, 2023.
- Setzer J., Higham C., Global trends in climate change litigation: 2023 snapshot. London School of Economics and Political Science e Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment, 2023.
Colonialismo climatico
a cura di Maria Marano – esperta di Diritto Ambientale, A Sud
L’analisi della crisi climatica non può prescindere dal suo collegamento con le dinamiche predatorie instauratesi in epoca coloniale. In ambito climatico il colonialismo rimanda non solo alle responsabilità storiche dei Paesi del Nord del mondo sulla crisi climatica ma anche alla linea di continuità delle dinamiche di potere tra i Paesi ricchi e poveri.
Il colonialismo climatico (denominato anche CO2lonialismo, dalla formula chimica dell’anidride carbonica) si concretizza, come sostiene anche Farhana Sultana, tra le sue principali studiose, attraverso l’estrazione mineraria, l’accaparramento di terre e risorse idriche, le guerre per il petrolio, ma anche progetti (come i REDD+) per ridurre la CO2 derivata dalla distruzione delle foreste o la rivoluzione verde dell’agricoltura. Non ci si riferisce pertanto solo ad attività antropiche esplicitamente impattanti sul clima, ma paradossalmente anche a interventi per far fronte alla crisi climatica (si veda il lemma false soluzioni).
Negli anni il dibattito sul colonialismo climatico e sulle questioni correlate, come il risarcimento delle perdite e i danni (si veda il lemma Loss and Damage) e il riconoscimento delle responsabilità storiche da parte dei Paesi ricchi, si è rafforzato. Significativo, nel 2022, è l’uso del termine colonialismo da parte dell’IPCC, il panel di scienziati ONU sul clima, che ha affermato che le forme storiche e attuali di colonialismo hanno direttamente acuito la vulnerabilità di persone e luoghi specifici agli effetti dei cambiamenti climatici.
Per approfondire:
- IPCC, Summary for Policy Makers section of the 6th IPCC Report, 2022.
- Lewis A., What Is Climate Colonialism? What to Know About Why Climate Change and Colonialism Are Linked, Global Citizen, 2023.
- Sultana F., The unbearable heaviness of climate coloniality, in Political Geograph, Elsevier Ltd, 2022.
Compensazioni (Carbon offsetting)
a cura di Laura Greco – antropologa, presidente A Sud
L’IPCC ha definito il net zero (o zero netto), come uno stato in cui le emissioni di CO2 e gas a effetto serra di origine antropica sono bilanciate dalla CO2 che viene rimossa dall’uomo. Di fatto questo concetto risulta perà ad oggi legato a un meccanismo di compensazione del tutto economico che non ha nulla a che fare con un sistema di limitazione dell’azione umana che punti all’eliminazione dello sfruttamento delle risorse e delle energie. La compensazione di carbonio, infatti, avviene tramite il finanziamento di progetti di riforestazione o stoccaggio di carbonio, oppure tramite quello che viene chiamato il carbon market (vedi voce dedicata), il mercato di carbonio istituito con il Protocollo di Kyoto del 2005.
L’offsetting, o compensazione delle emissioni di carbonio, è dunque un sistema in cui le aziende acquistano crediti di carbonio per compensare le loro emissioni di gas serra. Questo meccanismo prevede che per ogni tonnellata di CO2 emessa, l’azienda finanzi progetti che riducono o assorbono una quantità equivalente di CO2 altrove, come la riforestazione o la promozione delle energie rinnovabili. Secondo stime del 2017, l’afforestazione rappresenta quasi la metà del potenziale di mitigazione climatica. Ma raggiungere questo potenziale richiederebbe di piantare alberi su un’area stimata di quasi 700 milioni di ettari – più o meno la dimensione dell’Australia. Questo sistema è stato fortemente criticato dai movimenti e le associazioni ambientaliste perché spesso funge da alibi per le grandi aziende del settore fossile per continuare a inquinare. In molti casi, i progetti finanziati dai crediti di carbonio non producono i risultati promessi, o peggio, non sono addizionali, ovvero sarebbero avvenuti comunque senza il finanziamento dei crediti. Questo crea una falsa sensazione di avanzamento nella lotta contro il cambiamento climatico, mentre le emissioni reali continuano a crescere.
Il sistema di compensazione delle emissioni rischia di essere una mera operazione di greenwashing e distoglie l’attenzione dalle soluzioni strutturali necessarie per affrontare il cambiamento climatico. Le aziende possono promuovere le Nature Based Solution, cioè le soluzioni basate sulla natura, progetti che consentono ad esempio ai programmi di conservazione di finanziarsi attraverso la vendita di crediti di carbonio alle aziende. Ciò avviene attraverso un calcolo di emissioni di CO2 nell’atmosfera stimate e alla capacità di impedirne la loro emissione attraverso la protezione o la creazione di nuova vegetazione. Tuttavia il concetto stesso di prevenzione è discutibile: non sappiamo cosa succederà a un pezzo di terra tra 10, 20 o 100 anni ed è molto facile creare una narrazione speculativa attorno a una foresta che ha buone probabilità di essere distrutta, anche per via dei cambiamenti climatici, il cui impatto non è considerato nella proiezione. Ciò che è avvenuto con lo scandalo Verra, uno dei più grandi enti certificatori del mercato volontario dei crediti di carbonio, ne è esempio diretto: i dati sulle proiezioni future sono stati gonfiati in modo da valutare positivamente i progetti di crediti di carbonio ma le aree interessate non sono state veramente protette, creando una vera e propria bolla speculativa. Oltre a questo i progetti di riforestazione, afforestazione e mantenimento delle foreste rischiano di impattare negativamente sui popoli indigeni che vi risiedono, obbligati spesso dalle attività conservazioniste ad abbandonare i loro stessi territori originari.
Il Carbon Removal Certification Framework (CRCF) dell’Unione Europea è il quadro legislativo che disciplinerà la generazione di certificati di rimozione del carbonio ed è ad oggi profondamente criticato dai movimenti ambientalisti per il suo impatto sulle filiere alimentari ed agricole.
I movimenti del sud del mondo chiedono di rivedere l’obiettivo delle politiche climatiche verso il real zero (o zero reale) di emissioni, con vere e drastiche riduzioni cui primo attore devono essere i paesi del Nord del mondo, principali emettitori. Il real zero emission implica lasciare le risorse fossili nel sottosuolo, come chiedono da almeno due decenni i movimenti per la giustizia climatica.
Per approfondire:
- Simon Counsell and Survival International. “Blood Carbon: how a carbon offset scheme makes millions from Indigenous land in Northern Kenya” (Marzo 2023)
- Real Zero Europe, “Carbon Offsetting: EU Carbon Removal Certification Framework proposal lends legitimacy to a discredited carbon offsetting approach,” (Novembre 2023)
- Sophie Scherge, “Unpacking the EU Carbon Removal Certification Framework: Implications for EU Climate and Agriculture Policy”( Maggio 2024)
Comunità educante
A cura di Alessandro Bernardini ― Educatore e formatore A Sud
La comunità educante è un tessuto di relazioni solidali e collaborazioni, costituito e sostenuto da tutte quelle realtà che vivono e operano in un territorio specifico e che riconoscono la responsabilità condivisa di abitarlo e che hanno come obiettivo primario la lotta alla povertà educativa e la crescita culturale, sociale ed educativa delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi e degli stessi adulti. Una rete formata da genitori, docenti, alunne e alunni, personale scolastico, organizzazioni non governative, istituzioni locali, associazioni culturali e sportive, religiose, fino ad arrivare ad alcune aziende.
La comunità educante è aperta, inclusiva, informale, costituita da processi di collaborazione di diversi soggetti locali in relazione tra loro, in un’ottica orizzontale, basata su un lavoro di rigenerazione delle relazioni. Si prende cura delle attività e delle risorse di cui dispone, promuove proposte e interventi trasformativi.
Il contrasto alla povertà educativa, quindi, nasce proprio dalla comunità educante che ruota attorno alle giovani e ai giovani e che non le/li relega ad essere solo le adulte e gli adulti di domani, ma agenti primari di cambiamento e che cresce con loro, che si fa educare da loro restando fortemente legata al fondamento che «Nessuno educa nessuno, nessuno si educa da solo, gli uomini ( e le donne, NdR.) si educano insieme, con la mediazione del mondo».
L’azione della comunità educante, con al centro il nucleo basilare della scuola, agisce mitigando fenomeni molto presenti in Italia come la dispersione scolastica e i NEET (Neither in Employment or in Education or Training) ragazze e ragazzi che non studiano e non lavorano.
Una comunità educante funzionante deve far parlare tutti i soggetti coinvolti e necessariamente, quindi, deve adottare forme ibride di comunicazione e relazioni che attuino un decentramento dei soggetti stessi in favore dell’obiettivo comune. Infatti la comunità educante così come il suo attore principale, la scuola, mette insieme diversità che non inficiano l’obiettivo finale dell’educazione e anzi, lo valorizzano.
Proprio grazie all’azione della Comunità educante si possono intraprendere percorsi di scienza partecipata e condivisa, per monitorare e scoprire qualità dell’aria, dei suoli, delle acque e della biodiversità, di outdoor education, di economia circolare, percorsi che hanno le scuole come centro della comunità, come calamita per gli altri soggetti del territorio: genitori, associazioni del Terzo Settore, istituzioni locali, istituti religiosi, associazioni sportive, spazi sociali. Le scuole che co – progettano insieme a questi soggetti percorsi di educazione, sensibilizzazione, studio, ma anche progetti pilota, come ad esempio la nascita delle comunità energetiche che condividono l’energia elettrica rinnovabile prodotta da impianti nella disponibilità di uno o più soggetti associatisi alla comunità.
La comunità educante è quindi il volano per trasformare la conoscenza sulle cause e sugli effetti delle crisi climatiche in azione duratura, è essenziale per coinvolgere direttamente le giovani generazioni, monitorando il cambiamento climatico nei loro territori attraverso una varietà di strumenti, dalla raccolta di storie legate alla memoria, alla partecipazione alla citizen science, fino alla mappatura degli eventi meteorologici estremi.
Per approfondire:
- Freire P., La pedagogia degli oppressi (1968), Edizioni Gruppo Abele, 2018.
- Save The Children, Che cos’è la povertà educativa: definizione e cause, 4 maggio 2022.
Comunità energetiche
A cura di Andrea Turco – giornalista ambientale
Le comunità energetiche rinnovabili (CER) sono costituite da un insieme di cittadini, piccole e medie imprese, enti territoriali e autorità locali, incluse le amministrazioni comunali, le cooperative, gli enti di ricerca, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale, che condividono l’energia elettrica rinnovabile prodotta da impianti nella disponibilità di uno o più soggetti associati alla comunità. Lo scopo è di costruire un sistema energetico alternativo: non più centralizzato, in cui a far profitto sono pochi produttori e distributori, ma a favore di un’energia diffusa e dal basso, in cui le persone non sono semplicemente consumatrici di un servizio ma protagoniste attive di un bene fondamentale come l’energia. Attraverso l’autoconsumo con le CER è possibile ottenere numerosi benefici ambientali, economici e sociali. In Italia le CER sono state introdotte nel 2019 e sono disciplinate dal decreto ministeriale n. 414 del 07 dicembre 2023, entrato in vigore il 24 gennaio 2024. Per la nascita e lo sviluppo delle CER sono previsti 5,7 miliardi di aiuti da parte del governo.
Per approfondire
- Marco Mariano (a cura di), Come si fa una comunità energetica, Altreconomia, 2021.
- Giuseppe Milano, Comunità energetiche, Pacini Editore, 2023.
- Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Decreto Ministeriale e FAQ sulle comunità energetiche, 2024.
- RES – Ricerca sul Sistema Energetico, CER e Autoconsumo collettivo: alcune simulazioni numeriche alla luce della nuova regolazione, 2023.
Conflitto ambientale
A cura di Laura Greco — presidente A Sud
Il conflitto ambientale è definibile come una controversia tra più parti, portatrici di posizioni, interessi o visioni differenti circa l’utilizzo dei territori e delle risorse naturali in essi presenti. I conflitti ambientali si generano in tutte quelle situazioni che vedono la concorrenza di due elementi:
- la riduzione qualitativa e quantitativa delle risorse naturali o beni comuni presenti su un dato territorio e la conseguente estrazione di valore da una comunità (terre coltivabili, acqua, biodiversità, flora o fauna, minerali o altre materie prime di carattere finito);
- la presenza di opposizione e resistenza da parte delle comunità coinvolte, organizzazioni sociali o ambientaliste, comitati locali, che si organizzano e si mobilitano in difesa dei propri diritti o del proprio territorio.
L’attuale panorama mondiale è stato caratterizzato negli ultimi decenni da una sempre maggiore diffusione dei conflitti ambientali, quale sintomatica manifestazione degli effetti che il modello di sviluppo centrato sull’estrattivismo e lo sfruttamento intensivo delle risorse produce in termini ambientali e sociali. I conflitti ambientali sono in continuo aumento a causa dell’esaurimento progressivo delle materie prime, dell’incalzare delle problematiche ambientali e dell’emergenza climatica, della diffusione dei conflitti armati come forma di controllo geopolitico strategico, della crisi del diritto internazionale, della corsa all’accaparramento di materie prime necessarie alla transizione ecologica capitalista. D’altro canto, la diffusione delle nuove tecnologie, la maggiore circolazione delle informazione e le possibilità di networking connesso hanno permesso al contempo una maggiore facilità di organizzazione degli attori sociali presenti sui territori colpiti da fattori di rischio ambientale.
Per approfondire:
- Di Pierri M., Introduzione: i nuovi conflitti ambientali come fenomeno globale, in: CDCA (a cura di) Conflitti ambientali, Edizioni Ambiente, 2011.
- Martinez-Alier J., L’Ecologia dei poveri, Jaca Book, 2009.
- Belardinelli S. e Distefano T., ,Intervista a Joan Martinez-Alier, IlBo Live, Università di Padova, 2022.
- Gobert J., Environmental Inequality, Encyclopedia of the Environment, 2019.
Consumo di suolo
A cura di Lorenzo Manni – geologo e geotecnico
Il suolo è una risorsa indispensabile per la vita sul pianeta, ma è una risorsa limitata e non rinnovabile.
Le trasformazioni del territorio legate all’espansione delle aree edificate e delle infrastrutture umane conducono a una perdita progressiva e spesso irreversibile di questa risorsa fondamentale. Il «consumo di suolo» esprime l’entità di questa perdita ed è definito come «la variazione da una copertura non artificiale (suolo non consumato) a una copertura artificiale del suolo (suolo consumato)». Può essere permanente o reversibile. Si definisce «consumo di suolo netto» la differenza tra le aree in cui sono presenti nuove coperture artificiali e le aree recuperate o rinaturalizzate. Il consumo di suolo netto esprime quindi la superficie di suolo perduta in un determinato periodo di tempo e si misura in ettari (ha) o chilometri quadrati (kmq). In Italia, nel 2022 il consumo di suolo netto è stato di 70,8 kmq corrispondenti a 2,2 metri quadri al secondo.
Per approfondire
- SNPA, Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale, Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici, 2023.
- ISPRA, Istituto Superiore per la Ricerca Ambientale, Atlante Nazionale del Consumo di Suolo, 2023.
Convenzione di Aarhus
A cura di Filippo Garelli – ricercatore Università La Sapienza
La Convenzione di Aarhus è un importante accordo internazionale che disciplina l’accesso all’informazione ambientale, la partecipazione del pubblico nei processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale. La convenzione è stata ratificato dall’Italia e dall’Unione Europea, pertanto, i diritti e gli obblighi definiti nel trattato sono giuridicamente rilevanti per queste Parti.
La Convenzione rappresenta uno strumento fondamentale per la promozione della democrazia ambientale e consente di coinvolgere tutte le parti sociali in modo sinergico per promuovere programmi, politiche e misure legislative in settori complessi e rilevanti per la protezione dell’ambiente o del clima (es. settore dell’energia). A livello strutturale, la Convenzione si divide in tre pilastri fondamentali: il diritto del pubblico di accedere alle informazioni ambientali, il diritto di partecipazione del pubblico e il diritto di accesso alla giustizia nei processi decisionali in materia ambientale. Di conseguenza, fin dall’inizio e durante tutte le fasi di un processo decisionale, ogni persona ha il diritto di consultare tempestivamente e adeguatamente tutte le informazioni rilevanti. Questo risultato può realizzarsi anche mediante l’uso di siti internet o altri strumenti in grado di garantire un quadro informativo chiaro, trasparente ed efficace. Inoltre, i cittadini, la società civile e il settore privato devono partecipare al procedimento decisionale avendo modo di esprimere adeguatamente le proprie osservazioni, affinchè le autorità pubbliche ne possano tenere conto all’interno della decisione finale. La partecipazione del pubblico può realizzarsi mediante consultazioni pubbliche, audizioni, consultazioni su progetti di sviluppo e altre forme di partecipazione democratica. Infine, il diritto di accesso alla giustizia deve realizzarsi in tutti quei casi in cui i processi decisionali non rispettano il diritto di informazione e partecipazione del pubblico. Ciò significa che i cittadini hanno il diritto di ricorrere ai tribunali o ad altre istanze giuridiche per contestare decisioni ambientali ritenute dannose per l’ambiente o per i loro interessi. I principi consacrati nella Convenzione sono fondamentali per garantire una gestione sostenibile dell’ambiente e per coinvolgere i cittadini nella protezione e nella conservazione delle risorse naturali.
In caso di violazione dei diritti tutelati dalla Convenzione, il Comitato di Controllo della Convenzione di Aarhus può ricevere comunicazioni provenienti da individui, associazioni o altre Parti contraenti e formulare raccomandazioni o osservazioni da indirizzare alle Parti inadempienti. In questo modo, attraverso un procedimento di natura non contenziosa, il Comitato è in grado di coinvolgere le parti in uno spirito di collaborazione e grazie alle raccomandazioni non vincolanti può indirizzate la condotta delle Parti, agevolando una risoluzione del caso portato alla sua attenzione.
Per approfondire
- Ryall A., A brave new world: The Aarhus Convention in tempestuous times, in Journal of Environmental Law, 2023.
- Tanzi A., Fasoli E., Iapichino L., La Convenzione di Aarhus e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, CEDAM, 2011.
- Morgera E., An Update on the Aarhus Convention and its Continued Global Relevance, in Review of European, Comparative & International Environmental Law, 14, 2, 2005 .
- Samve G., Non-Judicial, Advisory, Yet Impactful? The Aarhus Convention Compliance Committee as a Gateway to Environmental Justice, in Transnational Environmental Law, 9:2, 2020.
- Sands P., Peel J., Principles of international environmental law, Cambridge University Press, 2018.
Conversione ecologica
a cura di Raffaele Lupoli – Direttore Economiacircolare.com
L’utilizzo dell’espressione “conversione ecologica” non è semplicemente una questione di scelta lessicale: affonda le radici in un’idea profonda e radicale di cambiamento dell’economia e della società. E la differenza rispetto all’espressione “transizione ecologica” non si limita all’aspetto temporale e dunque alla maggiore gradualità con cui, chi aderisce a questa seconda opzione, intende realizzare il cambiamento necessario a rispondere all’emergenza ambientale che coinvolge il Pianeta.
Nell’ultimo decennio l’espressione conversione ecologica ha ripreso slancio anche grazie all’enciclica Laudato si’ sulla cura della casa comune voluta da papa Bergoglio. Secondo il pontefice la conversione ecologica richiede una conversione interiore che trasformi il nostro rapporto con la natura e gli altri esseri umani, riconoscendo la connessione intrinseca tra giustizia sociale e giustizia ambientale.
Sotto i riflettori ci sono dunque due aspetti fondamentali: da un lato la necessità di acquisire una visione ecocentrica della società e dell’economia, abbandonando quella eminentemente antropocentrica che ci ha condotto nell’era dell’emergenza climatica, del sovra sfruttamento indiscriminato delle risorse naturali e di una pericolosa perdita di biodiversità; dall’altro la consapevolezza che senza giustizia non solo non c’è pace ma viene meno anche la possibilità di riportare in equilibrio gli ecosistemi. “Non siamo padroni della Terra ma parte di essa” afferma il filosofo e teologo brasiliano Leonardo Boff, auspicando una modalità di relazionarsi con l’ambiente fondata sul rispetto e non più sul dominio.
L’intellettuale, politico, pacifista e ambientalista italiano Alexander Langer ha declinato, e in un certo senso esteso, questo concetto definendo la conversione ecologica come una prospettiva in grado di migliorare la qualità della vita e delle relazioni e di generare una società più equa e solidale. “Non esiste il colpo grosso, l’atto liberatorio tutto d’un pezzo che possa aprire la via verso la conversione ecologica, i passi dovranno essere molti, il lavoro di persuasione da compiere enorme e paziente” raccomanda Langer, peraltro molto critico anche nei confronti del concetto di sviluppo sostenibile. Egli ribadisce la necessità di “riequilibrare equilibri profondamente turbati” e propone di abbandonare il modello rappresentato dal motto olimpico citius, altius, fortius per adottare quello contrario del lentius, temperatius, levius, successivamente trasformato in lentius, profundius, suavius: più lentamente, più profondamente, più dolcemente. A lui dobbiamo anche l’intuizione per cui “la conversione ecologica potrà affermarsi soltanto se apparirà socialmente desiderabile” (colloqui di Dobbiaco, agosto 1994).
Da decenni ormai, ricerche scientifiche e rapporti di autorevoli istituzioni internazionali ribadiscono con nuove evidenze che l’attuale modello di produzione e consumo non è sostenibile. Gli sconvolgimenti ambientali sono tanti e diversi, soltanto una piccola frazione delle risorse che utilizziamo è recuperata, riciclata o rigenerata. L’ecoprogettazione, l’economia circolare, l’efficienza energetica, le ecoenergie rappresentano risposte valide e necessariamente da implementare, ma non saranno sufficienti se non si inquadreranno in un ripensamento più profondo e complessivo.
Per il filosofo norvegese Arne Næss, considerato il padre della deep ecology, non sarà l’ottimismo tecnologico che anima quella che lui definisce ecologia superficiale a salvare la specie umana. “La maggior forza trainante del movimento dell’ecologia profonda, se paragonato a tutta la restante parte del movimento ecologista, è l’identificazione e la solidarietà con tutta la vita” spiega Næss.
Sono tante e diverse ormai le teorie economiche che propongono di superate il paradigma della crescita infinita, ritenendo che l’intenzione di disaccoppiare crescita e sovrasfruttamento di risorse – alla base anche delle politiche che animano il cosiddetto Green Deal europeo – si stia rivelando velleitario. Si fa strada un movimento, fatto da esponenti del mondo accademico e della società civile, che propone di andare oltre la crescita per affrontare effettivamente ed efficacemente la crisi in atto.
Alcuni sostengono un’economia della sufficienza basata sulla qualità della vita anziché sulla quantità di beni posseduti o utilizzati, altri chiedono una riduzione controllata della produzione e del consumo per garantire una sostenibilità effettiva, ma tutti hanno in comune la necessità di superare un approccio meramente tecnologico e di affrontare la questione ecologica più in profondità. Nella consapevolezza che le soluzioni tecniche e politiche alla base della transizione ecologica sono soltanto un aspetto del cambiamento radicale dei valori, delle relazioni sociali e delle condotte che è alla base della conversione ecologica.
Per approfrondire:
- Papa Francesco. Laudato si’. Enciclica sulla cura della casa comune, 2015.
- Boff L. Grido della terra grido dei poveri. Per una ecologia cosmica. Cittadella editore, 1996.
- Langer A. (Rabini E., Adriano Sofri A., a cura di). Il viaggiatore leggero. Scritti 1961-1995. Sellerio 2011.
- Næss A. Ecosofia, Ecologia Società e Stili di Vita. Red Edizioni, 1994.
Cultura Sostenibile
A cura di Marta Lovato – Responsabile sostenibilità Santarcangelo Festival
Questo termine racchiude il doppio concetto di cultura della sostenibilità e sostenibilità della cultura, due aspetti intrinsecamente legati. La cultura è la base sulla quale si forma la nostra identità e si sviluppano le nostre storie, politiche e valori. Si riferisce a un insieme di pratiche quotidiane, conoscenze e atteggiamenti che coltivano e promuovono un certo stile di vita. La crisi climatica è quindi una crisi profondamente culturale, sorretta da tradizioni, pratiche e modi di vivere – specialmente nei luoghi industrializzati – connessi con i combustibili fossili e i sistemi estrattivi e coloniali che li supportano. È dunque necessaria una conversione culturale per invertire la rotta. Questa è la cultura della sostenibilità: un modo di pensare e vivere la società che mira a garantire la prosperità delle generazioni presenti senza compromettere le opportunità di quelle future, nella consapevolezza della limitatezza delle risorse della Terra e nella comprensione che lo sviluppo umano deve essere bilanciato per preservare l’equilibrio ambientale, sociale ed economico. Il settore culturale è il principale tramite espressivo della nostra cultura in senso più ampio e contribuisce fortemente alla sua formazione, diffusione e cambiamento. La comunità creativa e culturale gioca un ruolo chiave nell’influenzare il modo in cui le persone e i governi / policymaker rispondono all’emergenza climatica e nel diventare propulsore di una conversione ecologica attraverso l’adozione di pratiche e modelli sostenibili. Cultura sostenibile è l’insieme di tutto questo: un circolo virtuoso di evoluzione del settore culturale che alimenti la svolta verso la cultura della sostenibilità nel suo significato più ampio. Sempre più organizzazioni si stanno dedicando a questa riflessione e a queste pratiche, alcune vi lavorano da tempo svolgendo un prezioso lavoro, in particolare: Julie’s Bicycle, Creative Carbon Scotland, Climate Heritage Network.
Per approfondire:
- Tentori T., Primo congresso nazionale di scienze sociali, Studium 1956.
- CLIMATE HERITAGE NETWORK, The Climate Heritage Manifesto for COP27, 2022.
- Creative carbon scotland, sito web.
- Julie’s Bicycle, sito web.
Decarbonizzazione
a cura di Elio Lo Bello – A Sud
Con il termine decarbonizzazione, così come definito dall’IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change, ci si riferisce all’azione di riduzione delle emissioni di anidride carbonica derivanti dalle attività umane rilasciate in atmosfera. La decarbonizzazione è direttamente collegata agli sforzi per il contrasto ai cambiamenti climatici, tesi, nello specifico, a mantenere i livelli del riscaldamento globale entro 1,5 gradi di aumento delle temperature medie al 2100 rispetto ai livelli pre-industriali. La decarbonizzazione consiste dunque nella riduzione dei gas serra derivanti dalla combustione dei carburanti fossili, attraverso l’utilizzo di fonti di energie rinnovabili come quella solare, eolica, geotermica ed elettrificando più settori possibili e attraverso processi di efficientamento energetico ed elettrificazione.
Per rispettare gli obiettivi di decarbonizzazione cui si sono impegnati firmando l’Accordo di Parigi, molti Paesi a livello mondiale si sono posti l’obiettivo di raggiungere il cosiddetto net zero di emissioni entro il 2050.
Il termine Net Zero definisce una situazione in cui le emissioni di CO2 e gas a effetto serra di origine antropica sono bilanciate dalla CO2 che, pur essendo emessa, viene poi rimossa. L’Accordo di Parigi impegna i paesi a raggiungere questo equilibrio entro la metà del secolo, considerandolo su scala globale piuttosto che paese per paese o azienda per azienda. Tuttavia, questo processo è legato al meccanismo tutto economico delle compensazioni (si veda a tal proposito il lemma dedicato) che non è di fatto legato alla limitazione delle emissioni derivanti dalle attività umane. A ciò va aggiunto che la rimozione delle emissioni di gas serra è tutta spostata su un tempo futuro, con riferimento a meccanismi dall’impatto ancora incerto, come il carbon farming o la CCS, cattura e stoccaggio del carbonio (si veda lemma dedicato), finendo con il rallentare le necessarie azioni di mitigazione e dunque il taglio delle emissioni. Il concetto di Net Zero è fortemente criticato da molte organizzazione non governative, centri studi indipendenti e osservatori internazionali. Molte di esse sono riunite in una campagna europea di organizzazioni che lavorano su clima, ambiente, giustizia economica, diritti umani e sovranità alimentare, la Real Zero Europe campaing.
L’orientamento verso il Real Zero prevede al contrario la riduzione e infine l’eliminazione della produzione di combustibili fossili quale unica reale misura efficace al contenimento della crisi climatica, tenendo al centro il tema dell’equità. Ciò è possibile solo trasformando i sistemi energetici, garantendo pratiche forestali rispettose della natura, fornendo sostegno all’agroecologia contadina e ai piccoli agricoltori e consentendo una transizione giusta per gli agricoltori all’interno di un sistema agricolo industriale estrattivo. Il percorso verso il Real Zero che prevederebbe un phase-out ossia un percorso a tappe serrate che punta all’eliminazione delle fonti fossili, è stato più volte ostacolato a livello di governance climatica, ad esempio durante la COP 26 di Glasgow, quando i negoziatori di India e Cina fecero modificare il testo dell’accordo finale introducendo il concetto di phase-down, ossia riduzione graduale – e non già eliminazione – delle fonti fossili, che di fatto lascia maggiori margini di discrezionalità ai paesi ONU sulle modalità di esecuzione degli impegni assunti in sede internazionale.
Ulteriore tassello terminologico importante collegato alla roadmap di decarbonizzazione che costituisce annualmente tema centrale delle negoziazioni climatiche in seno alle Nazioni Unite sono i termini unabated (non abbattuto) o hard to abate (difficile da abbattere). Il primo indica i combustibili fossili prodotti e utilizzati senza interventi che permettono di ridurre sostanzialmente la quantità di emissioni di gas serra lungo l’intero ciclo di vita. Il secondo, hard to abate, si riferisce a quei settori industriali difficili da decarbonizzare o da riconvertire (ad esempio, acciaierie, raffinerie, cementifici etc.), in cui le emissioni di gas clima alteranti sono intrinseche al processo produttivo.
Per approfondire:
- Real Zero Europe, Analysis: Real Zero, net zero, and the European Commission’s proposal for a carbon removal certification framework, 2022.
- Unep, Emission Gap report, 2023.
- UNFCCC, Decarbonization Cannot Wait, 2022
Decrescita
a cura di Associazione per la Decrescita
La decrescita mette in discussione l’egemonia della crescita economica e si adopera per ridimensionare la produzione e il consumo nei paesi industrializzati, redistribuendo in modo democratico la ricchezza. Può essere considerata un vero e proprio paradigma economico e sociale che, attraverso la riduzione della produzione e del consumo di beni e merci, mira a raggiungere maggiori sostenibilità ambientale, giustizia sociale e benessere.
La decrescita si oppone all’idea di crescita economica illimitata, sostenendo che il benessere umano non è necessariamente legato all’aumento del PIL, ma piuttosto a un uso responsabile delle risorse, alla riduzione degli sprechi e a una vita più semplice e comunitaria. In una società della decrescita ogni aspetto dell’organizzazione economica e sociale (attività umane, modalità d’uso di energia e materia, relazioni, ruoli di genere, ripartizione del tempo tra lavoro retribuito e non retribuito e relazioni con il mondo non umano) sono concepiti in maniera diversa.
Obiettivo della decrescita, infatti, è promuovere un modello di società libera dall’economicismo: non raggiungere una “crescita diversa”, né un diverso sviluppo – sostenibile, sociale, equo – ma una società post-crescita, caratterizzata dall’abbondanza frugale e dalla prosperità senza crescita.
Benché la decrescita nasca anche dalla bioeconomia e dalla macroeconomia ecologica è un progetto non economico, ovvero non si configura come progetto economico alternativo, ma come un “abbandono dell’economia”: condivisione, semplicità, convivialità, cura e beni comuni sono i concetti primari in questa visione. Ovviamente per realizzarla occorre rientrare nei limiti biofisici imposti delle risorse naturali e dalla capacità di assorbimento degli ecosistemi riducendo il metabolismo sociale.
L’idea di decrescita si contrappone alla pervasività e onnipresenza delle relazioni di mercato, per limitare la presa che l’idea di crescita economica esercita sull’immaginario sociale dominante, riferendosi non solo alle relazioni economiche ma anche alla necessità di costruire democrazia radicale e società di pacifica convivenza, capaci al contempo di superare i problemi generati dalla tecnologia, operare un’equa ridistribuzione della ricchezza sia all’interno dei singoli paesi, sia a livello globale tra il Nord e il Sud, nonché tra le generazioni presenti e future.
Per approfondire:
- Kothari A., Salleh A., Escobar A., Demaria F., Alberto Acosta A., Pluriverso – Dizionario del post-sviluppo, Orthothes, 2021. (edizione italiana a cura di Maura Benegiamo, Alice Dal Gobbo, Emanuele Leonardi, Salvo Torre).
- Latouche S., Farewell to Growth, Polity, Cambridge 2009.
- Demaria F., Schneider F., Sekulova F., Martinez-Alier J., What Is Degrowth? From an Activist Slogan to a Social Movement, in: Environmental Values, 22, pp. 191-215, 2013.
- Degrowth blog, Analisi sulla decrescita come teoria e come movimento e Media Library. Risorse web. (https://www.degrowth.info/en/blog/) (https://www.degrowth.info/en/media-library/)
Diritto alla riparazione
A cura di Ugo Vallauri – Co-fondatore e responsabile policy di The Restart Project
Con diritto alla riparazione si intende il diritto delle persone a scegliere liberamente se riparare un prodotto invece di doverlo sostituire con un altro. Si riferisce prevalentemente a prodotti di consumo elettrici ed elettronici, in risposta al dilagante fenomeno dell’obsolescenza prematura e alla crescita dei rifiuti elettronici, che sono a livello globale il settore di rifiuti in maggior crescita.
Il termine è stato inizialmente utilizzato da attivisti statunitensi, interessati a colmare il divario tra le condizioni praticate dalle case produttrici ai riparatori loro affiliati, e quelle molto meno favorevoli praticate ai riparatori indipendenti e ai consumatori.
In Europa questi temi sono affrontati da un punto di vista olistico, che prende in considerazione l’effettiva riparabilità di un prodotto, cioè se un prodotto sia smontabile, oppure se siano disponibili pezzi di ricambio essenziali per effettuare una riparazione. Misure di questo genere sono affrontate all’interno di regolamenti “ecodesign” per specifiche categorie di prodotti, che riconoscono che l’efficienza e l’impatto nell’uso di materie prime sta diventando più importante dell’efficienza energetica durante la fase di uso di un prodotto. Per molti dispositivi, per esempio smartphones, computer e tablet, l’impatto climatico complessivo è prevalentemente causato dalle emissioni nella fase estrattiva e di produzione. La prima manifestazione a favore del diritto alla riparazione in Europa risale al dicembre 2018 davanti alla Commissione Europea, quando attivisti ottennero l’inclusione di un primo, limitato principio di riparabilità in grandi elettrodomestici e televisori.
Avere il diritto a riparare vuole anche dire che i prezzi devono essere abbordabili e che sia assicurata la trasparenza sulla disponibilità di pezzi di ricambio e manualistica. Questi aspetti sono per ora affrontati con successo solo da alcune iniziative nazionali, come il bonus per le riparazioni in Austria, con incentivi che coprono fino al 50% dei costi di una riparazione per i cittadini, e l’indice di riparabilità in Francia, che obbliga le case produttrici di alcune categorie di prodotti a informare i consumatori al momento dell’acquisto.
Il diritto alla riparazione è sempre più una questione di software, per due aspetti fondamentali: molti prodotti si connettono ad altri dispositivi e ad internet, e quindi necessitano di aggiornamenti di sistema operativo per mantenersi sicuri e in grado di comunicare con altri dispositivi. Spesso l’obsolescenza programmata dipende proprio dalla scelta strategica di case produttrici di interrompere il supporto a prodotti non più in commercio, spingendo così i consumatori a sostituirli anche se ancora funzionanti. Inoltre, è in crescita la pratica del parts-pairing, ovvero l’uso di software per “accoppiare” un pezzo di ricambio con una specifica unità di un dispositivo. Questa tecnica blocca arbitrariamente l’uso di pezzi di ricambio compatibili o usati, aumentando i costi di riparazione, per infondati motivi di sicurezza.
Il diritto alla riparazione vede convergere interessi di cittadini e gruppi senza fini di lucro – come gli organizzatori di migliaia di gruppi di riparazione comunitaria in Europa – con quelli di think tank ambientalisti, professionisti della riparazione e aziende di economia circolare, per esempio rivenditori di pezzi di ricambio, piattaforme per la vendita di prodotti di seconda mano e attori impegnati nel ricondizionare prodotti usati. La crescita di un’economia della riparazione e del riuso beneficiano direttamente da misure che rendano la riparazione e l’estensione della vita dei prodotti più semplici e a buon mercato.
Nonostante il forte consenso bi-partisan dell’opinione pubblica, sia in Europa che in Nord America, nei confronti di misure che obblighino le case produttrici di prodotti di consumo a rendere la riparazione più accessibile, i passi avanti a livello legislativo in questo settore sono molto lenti e osteggiati dai produttori, e coprono una minoranza esigua dei prodotti venduti in Europa.
Per approfondire
- RIGHT TO REPAIR EUROPE, Success stories of financial incentives to make repair affordable, 2023
- RIGHT TO REPAIR EUROPE, The price is not right, 2023
Diritto umano al clima
A cura di Michele Carducci – professore ordinario di Diritto Costituzionale Comparato e Diritto Climatico, Università del Salento
Per diritto umano al clima non si intende un nuovo diritto che si aggiunge ad altri. Il termine riflette le consolidate acquisizioni scientifiche sulla dipendenza della vita umana dalla stabilità del sistema climatico.
Dal punto di vista giuridico, esso trova consacrazione in diverse fonti, tra cui la Carta Mondiale della Natura dell’ONU del 1982, dove gli Stati riconoscono che «la specie umana è parte della natura e la vita dipende dal funzionamento ininterrotto dei sistemi naturali che sono fonti di energia e materia», e l’art. 2 della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico, con cui gli Stati si impegnano a escludere «qualsiasi pericolosa interferenza antropogenica sul sistema climatico».
Dal punto di vista filosofico, il concetto riflette i c.d. «comandamenti anonimi», enunciati da Hans Jonas nel suo Principio responsabilità, secondo i quali dalla natura derivano vincoli e obblighi che tutti devono rispettare.
A causa dell’inerzia politica nell’affrontare la degenerazione del sistema climatico, di diritto umano al clima stabile e sicuro si discute soprattutto davanti a Tribunali e Corti nazionali e internazionali, perché quella è l’unica sede in grado di accertare la responsabilità degli Stati.
Per approfondire:
- Jedge A.O., Arguing the Right to a Safe Climate under the UN Human Rights System, in International Human Rights Law Review, 2020.
- Jonas H., Il principio responsabilità, Einaudi, 2009.
- Pisanò A., Diritto al clima, in A. Tarantino, Enciclopedia di Bioetica e Scienza Giuridica. Aggiornamento I, Edizioni Scientifiche Italiane, 2022.
- Teubenr G., La matrice anonima, in Rivista critica del diritto privato, 2006.
- Vanderheiden S., Atmospheric Justice: A Political Theory of Climate Change, Oxford Academic, 2008.
Disastro ambientale
a cura di Marco Armiero ― storico dell’ambiente, ICREA/UAB
Se stessimo studiando una lingua straniera, potremmo definire il disastro ambientale come un “falso amico”, ovvero una di quella parola che ci sembra di conoscere e capire benissimo, anche se in realtà non è affatto detto che significhino per gli altri quello che noi intendiamo. Il concetto di disastro implica sempre la presenza umana; nessuno parlerebbe di un disastro per le eruzioni vulcaniche su un pianeta disabitato e non si parla di disastro per una tempesta in pieno oceano che non coinvolga una imbarcazione. Il disastro dunque si definisce soprattutto dai suoi effetti: un terremoto diventa un disastro quando distrugge beni immobili, infrastrutture e vite umane. Tuttavia, almeno di recente, l’antropocentrismo dell’accezione canonica di disastro sta progressivamente sfumando e così non è peregrino parlare di disastro a proposito dei grandi incendi forestali, anche quando questi non intaccano direttamente beni e vite umane. La questione più controversa quando si parla di disastri è quella delle cause: molti dizionari, ad esempio, sottolineano la differenza tra disastri di natura antropica e disastri naturali. Un terremoto appartiene alla seconda categoria mentre l’esplosione di una fabbrica evidentemente alla prima. Ma le cose sono forse meno nette di quello che possa sembrare. Se la percentuale di “natura” in un terremoto è senz’altro molto elevata, non possiamo tuttavia ignorare le condizioni antropiche che generano un disastro, come la cattiva qualità delle costruzioni o la mancanza di piani di evacuazione. Ancora più complesso distinguere tra naturale e antropico in presenza di disastri connessi al cambiamento climatico come eventi climatici estremi e incendi forestali. Più in generale la distinzione tra naturale e antropico sembra non reggere alla prova dei fatti, perché qualunque evento “naturale” si mescola con le strutture sociali che impatta. Non è possibile capire l’uragano Katrina di New Orleans senza considerare la storia di razzismo strutturale della società statunitense. Da questo punto di vista non solo la distinzione rigida tra naturale e antropico non convince, ma forse dovremmo ripensare anche la nozione di disastro antropico. Si dice che alcuni disastri sono causati dagli umani, come se fosse un umano indefinito a causarli, mentre sarebbe più corretto chiamare le cose con il loro nome.
Per approfondire:
- Huber et al., Beyond “Socially Constructed” Disasters: Re-politicizing the Debate on Large Dams through a Political Ecology of Risk, in Capitalism Nature Socialism, 28 (3), 48-6, 2017.
- Nixon, Slow Violence and the Environmentalism of the Poor, Harvard University Press, 2013
- Ruffino L., Gli infortuni sul lavoro in Italia in sette grafici, Pagella Politica, 2023.
- WHO, World Health Organization, Cancer Fact-sheets, 2022.
Ecoansia
A cura di Matteo Innocenti – neuropsicologo, Italian Climate Change Anxiety Association e Giulia Dockerty – psicologa e ricercatrice
L’eco-ansia è una profonda paura che qualcosa di dannoso stia minando irrimediabilmente l’integrità ecologica del pianeta senza dare la possibilità di controllarlo e prevederlo. Di conseguenza, questa viene anche concepita da alcuni come una emozione adattiva e pragmatica che aiuta a prepararsi ad una nuova sfida. E’ importante non concepirla come una malattia, bensì come una ragionevole reazione emotiva di fronte alla condizione di pericolo in cui si trova il pianeta. La popolazione più soggetta è quella giovanile, in quanto è consapevole di dover affrontare le conseguenze della crisi climatica nel futuro.
Quando essa viene sperimentata a bassi livelli risulta essere più funzionale. Infatti, una sana preoccupazione potrebbe orientare a mettere in atto atteggiamenti di problem solving. Quando invece si sperimenta ad alti livelli potrebbe venire a mancare la sua funzionalità adattiva, sperimentando una mancanza di motivazione e di speranza, che potrebbe sfociare in quadri psicopatologici più gravi.
Chi prova eco-ansia è più incline ad assumere “comportamenti pro-ambientali”, ovvero azioni volte a minimizzare l’impatto sul mondo naturale. E’ inoltre dimostrato che questi comportamenti riducono i livelli di eco-ansia. Tra i principali citiamo: il passaggio ad una dieta a base vegetale, la riduzione dei comportamenti consumistici, l’utilizzo di mezzi di trasporto più sostenibili. In aumento, vi è anche la rinuncia a procreare, in quanto mettere alla luce un* figli* è molto impattante in quanto a emissioni di CO2. L’“eco paralisi” è uno stato di immobilità e disillusione nei confronti della crisi climatica a cui è possibile andare incontro, scaturito da una convinzione che i propri sforzi siano inutili, perchè coloro che detengono il reale potere di avere un impatto positivo, non agiscono adeguatamente.
Alcuni consigli per gestirla sono: assumere comportamenti pro-ambientali, per lenire i sensi di colpa e aumentare il senso di autoefficacia, riunirsi in gruppo facendo rete e approfondire il proprio contatto con la natura, riconoscerne la bellezza e i benefici sulla salute.
Per approfondire:
- Innocenti M., Ecoansia: I cambiamenti climatici tra attivismo e paura, Erickson, 2022.
- Pearson H., The rise of eco-anxiety: scientists wake up to the mental-health toll of climate change, Nature, 2024.
Ecodesign
A cura di Paola Sposato – Ricercatrice ENEA
Per ecodesign si intende una progettazione di prodotti basata sull’efficienza delle risorse, la riduzione degli impatti ambientali legati alla produzione e la riduzione dei rifiuti.
La progettazione ecocompatibile implica, inoltre, l’integrazione di valutazioni ambientali all’interno del processo di sviluppo dei prodotti, con l’obiettivo di concepire manufatti non usa e getta e con il minimo impatto ambientale durante l’intero arco del loro ciclo di vita.
Le strategie di prevenzione agiscono sulle fasi del ciclo di vita della pre-manifattura e manifattura (estrazione delle materie prime, produzione e distribuzione,) attraverso la scelta di materiali a basso impatto ambientale (ad esempio compostabili, biodegradabili riciclabili in relazione alle tecnologie disponibili e/o poco energivori) ma anche pensando all’architettura dei prodotti in modo che necessitino della minor quantità di materiale possibile (ad esempio attraverso la miniaturizzazione a pari funzionalità), riducendo i processi produttivi necessari e/o scegliendo tecnologie di produzione “pulite”. Anche il packaging e la riduzione del peso e degli ingombri nella fase di trasporto rientrano in queste strategie.
Spostandosi nella fase d’uso e consumo le strategie di allungamento della vita utile riguardano tutte quelle azioni progettuali che mirano a concepire i prodotti in modo che siano facilmente riutilizzabili, rigenerabili, riparabili e/o aggiornabili così da aumentarne il tasso di utilizzo dei prodotti, favorendo una nuova generazione di beni più durevoli, evitando le conseguenze dell’obsolescenza programmata e garantendo il diritto alla riparazione.
Allungarne la vita utile evita la produzione di nuovi prodotti a causa della loro obsolescenza tecnico-funzionale. In questo modo i materiali, l’acqua e l’energia impiegati per produrre il prodotto saranno conservati e mantenuti il più a lungo possibile massimizzando quella che viene definita la produttività delle risorse.
In tale ottica sempre più si rivelano cruciali le innovazioni di consumo che passano dalla attuale concezione del possesso del bene a quella dell’accesso. Si parla in questi casi di “prodotto-servizio” in cui il consumatore paga per accedere alla funzione del bene per soddisfare un bisogno senza per questo esserne il proprietario per poi condividerlo con altri consumatori e/o ridarlo indietro quando il bisogno è cessato o mutato. Un prodotto pensato sin da principio per essere condiviso o ritirato dal produttore deve pertanto essere progettato adeguatamente con l’obiettivo di essere facilmente aggiornabile e/o riutilizzabile e/o riciclabile dall’azienda che lo gestisce e ritira così da poter essere ridesinato a nuovi mercati o rivalorizzato (integralmente o in parte) per la produzione di nuovi prodotti.
Abbiamo infine le strategie per il fine-vita. Queste mirano a concepire il prodotto in modo che le parti, le componenti e infine i materiali di cui è composto possano essere riciclate/rivalorizzate a fine vita. Fondamentale, pertanto, è il design per il disassemblaggio e la scelta dei materiali di cui è composto il prodotto favorendo per esempio e dove possibile l’uso di un solo materiale – omomatericità- o di più materiali appartenenti alla stessa tipologia – monomatericità – coerentemente con il sistema tecnologico di recupero cui sono destinati. È infatti indispensabile che il prodotto sia progettato sin da principio in modo che, una volta dismesso, possa essere facilmente separato in parti, componenti e materiali che opportunamente trattati, possano essere reimmessi in nuovi cicli produttivi evitando l’utilizzo di altre risorse vergini o critiche.
Per approfondire
- ICESP, L’Eco-design, sfide e opportunità, 2003.
- ECONOMIACIRCOLARE.COM, Ecodesign. Ovvero, come superare un errore di sistema
- PARLAMENTO EUROPEO, Progettazione eco-compatibile: regole per garantire prodotti sostenibili sul mercato europeo
Ecoenergie (energie rinnovabili)
a cura di Raffaele Lupoli – direttore Economiacircolare.com
La capacità di rinnovarsi e quindi di tornare ad essere reperibili in tempi più o meno lunghi è alla base della distinzione tra fonti energetiche rinnovabili e fonti energetiche non rinnovabili. Le energie rinnovabili sono tendenzialmente disponibili all’infinito, mentre le energie non rinnovabili impiegano tempi lunghi per essere disponibili e non sono presenti in maniera omogenea e diffusa sul pianeta come invece avviene per le rinnovabili. Queste ultime sono anche definite “ecoenergie” perché per produrle e utilizzarle non si creano impatti elevati sull’ambiente e sulla salute umana, mentre le fonti non rinnovabili producono inquinamento e sono la principale causa del surriscaldamento del Pianeta e della crisi climatica che stiamo vivendo.
Le principali fonti energetiche rinnovabili sono l’energia solare e quella eolica, ma ci sono altre fonti rinnovabili come l’idroelettrico, il geotermico e le biomasse.
- Energia solare – L’energia solare è un’energia pulita e inesauribile, di cui disponiamo grazie all’irradiazione solare. Proprio perché il sole non è disponibile continuamente su tutta la superficie terreste, questo tipo di energia si considera intermittente e variabile, ma per garantire la continuità dell’approvvigionamento disponiamo di tecnologie come le cosiddette reti intelligenti, in grado di distribuire l’energia prodotta quando e dove serve, e l’accumulo tramite batterie, anch’esse utili a stoccare l’energia nei momenti di sovrapproduzione per poi rilasciarla nei momenti in cui l’irraggiamento solare è minore o assente. L’energia solare è resa disponibile in diverse modalità di applicazione: la produzione di calore a bassa temperatura, la produzione di calore ad alta temperatura e la conversione fotovoltaica.
- Energia eolica – L’energia eolica si ottiene utilizzando le correnti d’area, cioè il vento. La macchina che trasforma l’energia del vento in energia elettrica è il generatore eolico o aerogeneratore. Più aerogeneratori collegati insieme formano le “wind farm” (fattorie del vento), vere e proprie centrali elettriche che possono essere “on shore”, cioè sulla terraferma (in genere su alture e crinali, dove le correnti sono maggiori) o “off shore”, cioè in mare a diversi chilometri dalla costa. Se il problema del disturbo alla fauna selvatica sembra superato per la maggiore silenziosità dei generatori più moderni, resta il dubbio sull’opportunità di installare questi impianti industriali in aree protette o in territori a rischio di dissesto idrogeologico.
- Energia idroelettrica – L’energia idroelettrica è la fonte rinnovabile più antica e utilizza la forza dei corsi d’acqua, delle cascate e delle dighe per produrre energia. Le attuali tecnologie consentono di trasformare in elettricità il 90% circa dell’energia dell’acqua, al punto che i cinque impianti rinnovabili che nel mondo producono più energia sono idroelettrici.
- Energia geotermica – La geotermia sfrutta il calore presente nella crosta terrestre: la temperatura del suolo aumenta di 3 gradi centigradi ogni 100 metri man mano che si scende in profondità. L’energia geotermica si ricava proprio da questo calore e in particolare da quello delle acque sotterranee, che a contatto con le rocce ad alte temperature si trasformano in vapore.
- Energia da biomasse – L’energia da biomassa utilizza materiali di scarto già presenti in natura (si parla di biomasse vegetali, animali e microbiche) e attraverso processi termici, gassosi o chimici produce energia elettrica o calore. La biomassa per eccellenza è il legno. Durante la crescita delle biomasse viene assorbita una quantità di anidride carbonica pari a quella rilasciata a seguito della loro combustione e questo garantisce un equilibrio nel ciclo del carbonio e dunque, secondo l’opinione prevalente, la sostenibilità di questa opzione. Ci sono però alcune avvertenza: in primis l’inquinamento legato alla combustione delle biomasse legnose, poi il rischio che non si brucino soltanto gli scarti ma boschi e foreste ancora in grado di produrre ossigeno e assorbire anidride carbonica, infine i costi elevati e il basso rendimento di questa fonte energetica.
Ecologia Politica
a cura di Marica Di Pierri – giornalista e ricercatrice, A Sud
L’ecologia politica è una campo di ricerca accademica interdisciplinare, appartenente al campo delle scienze sociali, che analizza i nessi tra fenomeni ambientali e ricadute socio-economiche e politiche. Più nello specifico, oggetto d’indagine dell’Ecologia politica è la connessione tra le modifiche dell’ambiente e i fattori economici, politici e sociali che, da un lato, ne sono causa e, dall’altro, ne vengono influenzati. La distanza di questa branca teorica dagli studi ambientali apolitici risiede nella politicizzazione di questa relazione, mirata all’esame degli effetti derivanti dalle alterazioni ecologiche in termini di mutazioni delle condizioni politiche ed economiche.
Centrali nell’approccio dell’ecologia politica risultano l’osservazione e l’analisi della diseguale distribuzione di costi e benefici dei cambiamenti ambientali e delle implicazioni in termini di rapporti di forza tra Stati, comunità, individui. La disciplina mutua concetti dal campo della sociologia, delle scienze politiche, dell’ecologia culturale, dell’economia, della geografia dello sviluppo, per mettere in luce le dinamiche alla base delle disuguaglianze socio economiche, delle crisi e dei conflitti ambientali e il ruolo del protagonismo sociale nel processi di cambiamento.
Per approfondire:
- Bryant R.L., Bailey S., Third World Political Ecology , Routledge, 1997.
- De Luca S., Il Movimento ecologista. Conservazionismo, ecologia politica e ambientalismo. InStoria – Rivista di storia e informazione, n.25, 2007.
Ecomafia
A cura di Antonio Pergolizzi – giornalista
Neologismo coniato da Legambiente nel 1994 per indicare le attività criminali poste in essere dalla varie consorterie mafiose ai danni dell’ambiente, dallo sfruttamento di biodiversità e di risorse ambientali all’abusivismo edilizio, dai traffici dei rifiuti ai furti e gas ozono lesivi alle opere d’arte e beni archeologici, dai ai reati legati al settore agroalimentare agli incendi di superfici boschive e così via.
Il termine ecomafia fece la sua comparsa ufficiale nel primo Rapporto Ecomafia di Legambiente, pubblicato in quella occasione con il titolo “Le ecomafie – il ruolo della criminalità organizzata nell’illegalità ambientale”, scritto in collaborazione con l’Arma dei carabinieri e l’Eurispes.
I clan finora censiti da Legambiente ammontano a 375 (Ecomafia 2023).
A differenza del termine ecoreato, quindi, E. prende in considerazione solo le attività ecocriminali realizzate grazie al contributo delle mafie. Come emerge dalla oramai sterminata letteratura giudiziaria e processuale, il ruolo delle ecomafie nelle attività di aggressione ambientale non si svolge quasi mai in maniera esclusiva ma attraverso il contributo di altri attori, ovvero imprenditori, funzionari pubblici, professionisti e faccendieri.
Sia per i ricorrenti fatti di cronaca giudiziaria che per le ripetute emergenze ambientali causate dalla gestione illegale dei ciclo dei rifiuti il termine E. è spesso associato alla Campania, in particolare ai clan originari delle province di Napoli e Caserta, che in quelle due province hanno dato vita al peggiore sistema ecomafioso realizzatosi in un territorio.
La peculiarità del modus operandi dei clan campani è stata di rivolgere il proprio interesse principalmente alla gestione dei rifiuti speciali (provenienti dal mondo economico/produttivo e costituenti più dell’80% del totale dei rifiuti generati ogni anno), in gran parte prodotti nelle aree industriali del Centro e del Nord Italia, offrendo dietro lauto compenso le aree agricole e marginali delle due province per gli sversamenti illegali (economicamente più convenienti dei trattamenti a norma di legge). Sversamenti che sono avvenuti ininterrottamente dalla metà degli anni Novanti fino alla prima decade degli anni Duemila, anche se continuano a manifestarsi ancora oggi, sebbene con minore intensità. Dopo gli sversamenti illegali, i siti venivano regolarmente incendiati dalla manovalanza dei clan per far sparire le tracce dei traffici e liberare altro spazio per i futuri sversamenti, da qui il triste epiteto dato da Legambiente all’area a cavallo delle due province campane di “Terra dei fuochi”.
Il ruolo dei clan campani ha comunque riguardato anche alla gestione illegale dei ciclo dei rifiuti urbani, controllando i trasporti, le raccolte e persino la gestione dei terreni dove stoccare la famose ecoballe, ossia i rifiuti indifferenziati che venivano semplicemente triturati e cellofanati per un improbabile avvio a termovalorizzazione. Improbabile perché le ecoballe prodotte, privi di alcuna forma di differenziazione a monte (quindi contenenti anche rifiuti organici non stabilizzati e d’altro tipo, quindi con tassi di umidità troppo elevati e potenzialmente dannosi per la salute pubblica) non rispettavano i parametri di legge per poter essere considerati combustibile derivato dai rifiuti (CDR), rimanendo quindi rifiuti indifferenziati tout court. Anomalia che serviva ai clan per poter continuare a svolgere un ruolo attivo nelle ricorrenti emergenze, diventate, quest’ultime, il tratto tipico dell’ecomafia più affarista e spregiudicata. Ancora oggi, anno 2024, di ecoballe ne rimangono da smaltire circa 3,5 milioni di tonnellate.
Nel 1995 è stata istituita la “Commissione parlamentare d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti”, che sin dall’inizio è stata denominata “Commissione Ecomafia”, proprio a sottolineare l’interesse dei commissari a investigare il ruolo delle mafie nel ciclo dei rifiuti. La Commissione d’inchiesta è stata rinnovata in tutte le legislature successive, fino all’attuale XIX, che ha allargato la sua area d’interesse, come emerge dalla nuova denominazione “Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecita connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentare”, presieduta dal deputato Jacopo Morrone.
Nelle indagini contro le ecomafie non sono mancate le vittime, come la giornalista Ilaria Alpi insieme all’operatore Miran Hrovatin, uccisi a Mogadiscio nel marzo del 1994, il capitano di corvetta Natale De Grazie, probabilmente avvelenato nel dicembre del 1995 mentre era in missione nell’ambito di una indagine sulle cosiddette Navi dei Veleni e ancora, solo per citare i nomi più noti, don Cesare Boschin, Domenico Beneventano, Renata Fonte, Marcello Torre, Angelo Vassallo e Pasquale Cappuccio.
Per approfondire
- LEGAMBIENTE, Rapporto Ecomafia
- https://www.ilariaalpi.it/
Economia Circolare
a cura di Alessandra De Santis, EconomiaCircolare.com
L’economia circolare è un modello economico alternativo a quello lineare “usa e getta”, basato sull’utilizzo intensivo delle risorse naturali, che ha caratterizzato il sistema di produzione e consumo degli ultimi 70 anni. Questo approccio, che si discosta dal funzionamento del mondo naturale, non è adeguato ad un contesto dove la disponibilità di risorse è sempre più limitata e l’impatto ambientale delle attività umane sta spingendo gli ecosistemi al limite delle loro capacità biologiche. Nell’economia lineare la maggior parte delle risorse trasformate in prodotti giacciono inutilizzate per la maggior parte della loro vita o vengono usate per un tempo ridotto prima di diventare rifiuti, senza essere ulteriormente valorizzate.
Al contrario, l’economia circolare punta a ottimizzare l’uso di materiali ed energia, minimizzando gli sprechi e lavorando per ridurre impatto ambientale ed emissioni. Secondo la definizione della Ellen MacArthur Foundation, «l’economia circolare è un sistema in cui i materiali non diventano mai rifiuti e ciò che viene dalla natura viene rigenerato. I prodotti e i materiali vengono mantenuti in circolazione grazie alla manutenzione, al riuso, alla rimessa a nuovo, al riciclaggio e al compostaggio. In questo sistema, i flussi di materiali sono di due tipi: quelli biologici, in grado di essere reintegrati nella biosfera, e quelli tecnici, destinati ad essere rivalorizzati senza entrare nella biosfera». Questo paradigma non si concentra solo sulla sostenibilità ambientale ma anche sul benessere sociale e sul valore umano, in linea con i principi su cui si fonda quella che Kate Raworth definisce l’economia della ciambella. La ciambella rappresenta un equilibrio tra le necessità umane e i confini ecologici del pianeta e propone un modello di sviluppo in cui ogni persona può vivere con dignità e senso di comunità senza superare i limiti delle risorse che il pianeta ci mette a disposizione.
L’integrazione di questi principi richiede un cambiamento di mentalità a livello globale, coinvolgendo non solo le aziende, ma anche i consumatori e i decisori politici. Serve un cambiamento culturale in grado di guidare e sostenere una revisione completa di tutte le fasi del ciclo di vita di un bene, dalla progettazione al fine vita, e al modo in cui viene acquistano e utilizzato.
Diversi elementi concorrono a questo cambiamento di sistema.
A partire dalla gerarchia dei rifiuti (vedi lemma dedicato) e dal paradigma delle 9 strategie R – rifiuta, riduci, riutilizza, ripara, ristruttura/ricondiziona, rigenera, ripensa, ricicla e recupera – si deduce che per prolungare la vita utile degli oggetti e ridurre la necessità di nuove risorse, non è possibile affidarsi solo al riciclo o alla sostituzione dei materiali senza sorpassare un modello di consumo usa e getta.
L’eco progettazione (o ecodesign, vedi lemma dedicato), di prodotto e/o di servizio è il primo passo per ripensare gli oggetti in ottica più sostenibile, attraverso la modularità e la versatilità che li rende adattabili a diverse esigenze e condizioni nel tempo, aumentando la loro durata e utilità. Questo permette ai beni di essere riutilizzati, attraverso il passaggio di proprietà (second hand, pre-loved), l’uso condiviso, la riparazione il ricondizionamento. Inoltre, facilita il recupero delle componenti e dei materiali da avviare a riciclo quando un oggetto arriva a fine vita.
La differenza fra materie prime vergini e materie prime seconde (o secondarie) è un altro elemento da considerare. Le materie prime vergini vengono estratte direttamente dalla terra per essere utilizzate nei processi industriali, con una pressione significativa sull’ambiente. Le materie prime seconde invece derivano dal recupero e dal riciclo dei rifiuti e a parità di possono essere usate in sostituzione di quelle vergini. Va sottolineato che il riciclo è un processo industriale che comporta comunque utilizzo di energia ed emissioni; inoltre non può essere applicato con la stessa efficienza a tutti i materiali. Alcuni materiali posso essere rigenerati all’infinito perché mantengo le proprietà delle materie prime vergini. Molti altri, invece, subiscono un processo di downcycling, perdendo le loro proprietà originali e riducendo la loro qualità fino a non poter essere più reimmessi nella catena del valore.
L’approccio ecosistemico, è un ulteriore pilastro fondamentale dell’economia circolare, poiché invita a considerare l’intero sistema, tenendo conto delle interazioni tra le diverse componenti e delle conseguenze a lungo termine delle azioni intraprese.
Ultimo punto, non per importanza, in un sistema rigenerativo come quello circolare, è promuovere la transizione dell’approvvigionamento energetico dai combustibili fossili alle energie rinnovabili.
Per approfondire:
- EconomiaCircolare.com, Cos’è l’economia circolare. risorsa web.
- Ellen MacArthur Foundation, What is circular economy, risorsa web.
- K. Raworth, L’economia della ciambella. Sette mosse per pensare come un economista del XXI secolo, Edizioni Ambiente, 2017.
- Kirchherr, J., Reike, D., & Hekkert, M.. Conceptualizing the circular economy: An analysis of 114 definitions. Resources, conservation and recycling, 221-232, Science Direct, 2017.
Ecoreato
A cura di Antonio Pergolizzi – giornalista
Sostantivo maschile (plureale Ecoreati), termine generico, mutuato dal più famoso lemma “ecomafia”, con il quale si indica l’intero spettro dei reati ambientali, ovvero illeciti di varia natura che hanno comportato danni – o pericolo di danni – alle matrici ambientali, alla biodiversità e alla inviolabilità del territorio e del paesaggio naturale, includendo – ai sensi del trattato sull’Unione europea (TUE) – tutte le risorse naturali, fra cui aria, acqua, suolo, ecosistemi, compresi i servizi e le funzioni ecosistemici, fauna e flora selvatiche, compresi gli habitat, e tutti i servizi forniti dalle risorse naturali.
In senso strettamente giuridico, invece, e con declinazione prevalentemente al plurale, indica il novero dei delitti ambientali inseriti nel Codice Penale grazie alla legge n.68 del 2015, che ha introdotto nello stesso il nuovo Titolo VI-bis – “Dei delitti contro l’ambiente”. Provvedimento normativo, quest’ultimo, che ha previsto cinque nuovi delitti (più una serie di aggravanti e misure cautelative e di prevenzione): inquinamento ambientale (art. 452 bis), disastro ambientale (art. 452 quater), traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies), impedimento del controllo (art. 452 setpies) e omessa bonifica (art. 452 terdecies). In tal senso, gli E. nella loro inedita veste di delitti si distinguono dal resto degli illeciti penali che rimangono di natura meramente contravvenzionale, la gran parte dei quali previsti dal Dlgs 152 del 2006, meglio noto come Testo Unico Ambientale.
La caratteristica degli illeciti ambientali di essere classificati prevalentemente – e fino al 2001 esclusivamente, poiché solo quell’anno entra in vigore il primo delitto ambientale, ovvero di “traffico organizzato di rifiuti” (attualmente rubricato nel Codice Penale all’art. 452 quaterdecies) – come illeciti contravvenzionali (e non delittuosi) ha guidato e motivato la grande spinta sociale per ottenere dal Parlamento l’introduzione nell’ordinamento di nuove fattispecie delittuose per tutelare l’ambiente, come sono diventati solo nel 2015 gli ecoreati di cui sopra. Riforma necessaria anche alla luce della ratio della Direttiva UE 98/2008, che prevede che tutti i paesi membri dispongano nel proprio ordinamento penale di leggi di tutela ambientale con sanzioni “proporzionate, efficaci e dissuasive”.
Ogni anno l’associazione ambientalista Legambiente aggiorna i dati sull’attività repressiva posta in essere dalle forze dell’ordine e dagli altri organi di polizia giudiziaria, sia sul fronte dei delitti che delle contravvenzioni ambientali. Come riporta l’ultimo Rapporto ecomafia 2023, i reati contri l’ambiente restano ben saldi sopra la soglia dei 30.000, esattamente sono 30.686, in lieve crescita rispetto al 2021 (+0,3%), alla media di 84 reati al giorno, 3,5 ogni ora.
Per approfondire
- SENATO DELLA REPUBBLICA, Trattato sull’Unione Europea
- GAZZETTA UFFICIALE, legge 22 maggio 2015, n. 68
Ecotransfemminismo
A cura di Sara Vegni – Advocacy Officer A Sud
L’ecofemminismo è una prospettiva teorica e un movimento che esplora le interconnessioni tra il dominio patriarcale sui corpi delle donne e lo sfruttamento della natura. Indaga i parallelismi tra le gerarchie ideologiche dualistiche che permettono una giustificazione sistematica del dominio perpetrato da soggetti o gruppi classificati in categorie di rango superiore sui soggetti classificati di rango inferiore (ad esempio: dell’uomo sulla donna, della cultura sulla natura, degli umani sui non umani).
Sulla natura del dualismo si è soffermata Val Plumwood in Feminism and the Mastery of Nature. “Ogni dualismo – scrive la filosofa australiana – è connesso agli altri in modo da formare un labirinto di nessi oppressivi legati dalla struttura logica caratterizzata dall’esclusione e dalla negazione (…)”.
L’ecofemminismo, al contrario, ponendo l’enfasi sull’interconnessione di tutte le forme di vita, offre una teoria etica basata non sulla separazione o sull’individualismo astratto, ma sui valori dell’inclusione, delle relazioni, sulla valorizzazione della conservazione della vita, partendo dalla consapevolezza della vulnerabilità di ciascuno.
L’origine del termine si deve all’attivista e scrittrice francese Francoise d’Eubonne, nel suo libro del 1974 Le féminisme ou la mort. Ma le origini del movimento sono da rintracciarsi nelle espressioni pacifiste e antimilitariste degli anni ’60, quando si iniziano a tracciare le connessioni tra il sessismo, le discriminazioni verso gli animali non umani e l’ambiente, considerati proprietà o risorse da sfruttare.
Nel 1973 prendeva avvio il movimento chipko in difesa delle foreste dell’Himalaya e dell’economia di sussistenza portata avanti dalle donne. Nel 1977 Wangari Maathai dava inizio al progetto di riforestazione in Kenya The Green Belt Movement tra i cui obiettivi principali c’erano la promozione dei diritti delle donne e della loro autonomia.
Una tesi centrale dell’ecofemminismo è che il patriarcato e il capitalismo innescano una spirale di discriminazioni dovuta allo sfruttamento delle risorse naturali e umane. Nell’evoluzione del pensiero ecofemminista si ravvedono due correnti principali: l’ecofemminismo essenzialista, o classico, che si concentra sulle connessioni tra le donne e la natura evidenziandone la capacità riproduttiva e la presunta attitudine alla cura, e l’ecofemminismo materialista o costruttivista che invece respinge il legame donna-natura.
Per approfondire
- Germogli – Pratiche ecofemministe DWF, 2021
- Plumwood V., Feminism and the Mastery of Nature, Routledge, London-New York 1993
- Pulcini E., La cura del mondo: paura e responsabilità nell’età globale, Bollati Boringhieri, Torino 2009.
- D’Eaubonne F., Le féminisme ou la mort, Pierre Horay, Paris 1974
- Pathak S., The Chipko Movement, Permanent Black, 2020
- Maathai W., The Green Belt Movement: Sharing the Approach and the Experience, Lantern Books; Revised edition, 2004
- Mercant C., La morte della natura, Editrice Bibliografica 2022
Educazione depositaria
A cura di Jessica Ferretti ― educatrice e formatrice, A Sud
Paulo Freire, pedagogista brasiliano, parla di educazione depositaria o bancaria intendendo con questa espressione le pratiche educative in cui le persone educande sono considerate vasi vuoti da riempire di contenuti nozionistici. Si tratta di un’ educazione che non intende sviluppare né pensiero critico né creatività nel singolo individuo, anzi mira a generare passività e indifferenza. Per Freire questo approccio educativo rappresenta uno strumento di oppressione, che addomestica gli individui alle regole degli oppressori, rendendoli insensibili di percepire e riconoscere la propria condizione di oppressi. La figura dell’educatore si identifica con quella di chi addestra, ovvero colui che deposita contenuti tecnici e specializzati, da non discutere, quindi inevitabilmente statici e conservatori. In opposizione all’educazione depositaria, Freire propone l’educazione cosiddetta problematizzante, un’educazione concepita nella sua azione trasformativa all’interno di processo sia sociale che politico. Questo approccio educativo basato sul dialogo prevede coinvolgimento, partecipazione attiva e responsabilità. Il concetto di “problematizzazione” porta con sé il dubbio, l’incertezza, necessari per costruire una nuova razionalità non separata dalle emozioni. Freire parla di processo di “coscientizzazione”, con cui intende la pratica educativa di liberazione.
Come per gli altri settori della formazione sia formale, sia informale il concetto di educazione problematizzante, quindi, può essere il fondamento dei percorsi di educazione in natura attraverso il coinvolgimento, la partecipazione e la responsabilizzazione di tutti gli agenti educativi.
Per approfondire:
- Freire P., La pedagogia degli oppressi, Edizioni Gruppo Abele, 2011.
Educazione ecologista
A cura di Nicole Marcellini ― educatrice e formatrice, A Sud
L’educazione ecologista pone al centro della pratica educativa le relazioni socio-ambientali: ogni individuo non è un’unità isolata e disgiunta dal resto ma parte integrante di un eco-sistema umano e non umano. Si tratta di concepire la società come una rete complessa in cui le varie forme di ingiustizie presenti (vulnerabilità ambientali e climatiche, economiche, sociali, culturali, di genere e di razza, la povertà educativa, la salute e il lavoro) non possono essere considerate separate tra loro. L’educazione ecologista ha l’obiettivo di tener conto di questa complessità per riflettere insieme a tutte le soggettività coinvolte su come percepiamo l’ambiente circostante, su quali relazioni sono responsabili del cambiamento climatico e della crisi ambientale, ma anche quali relazioni di cura e consapevolezza vogliamo per costruire insieme un mondo dove non esiste sfruttamento dell’ambiente e delle forme di vita che lo abitano.
L’educazione ecologista promuove giustizia ambientale e climatica affrontando il tema delle responsabilità sistemiche e delle soluzioni collettive e comunitarie e comportando per questo un ribaltamento del paradigma dell’educazione alla sostenibilità ambientale e allo sviluppo sostenibile . Questo ribaltamento colloca l’educazione ecologista su un piano più politico che ha l’obiettivo di mettere in luce le implicazioni sociali che stanno dietro alla logica di sfruttamento del sistema e di evidenziare i rapporti di causa-effetto che hanno portato il sistema politico-economico a creare ingiustizie sociali e ambientali oggi non più tollerabili.
Per approfondire:
- Hooks B., Insegnare a trasgredire. L’educazione come pratica della libertà, Meltemi, 2020.
- Dolci D., Palpitare di nessi, Mesogea, 2012.
- Macy J., Johnstone C., Speranza attiva, Terra Nuova edizioni, 2021.
- Scosse.org,sito web.
- Wilson E.O., Biophilia, Harvard University Press, 1984.
- Raith, A. & Lude, A., Startkapital Natur. Wie Naturerfahrung die kindliche eentwicklung fӧrdert, München, Oekom, 2014.
- Louv R., L’ultimo bambino nei boschi, Rizzoli, 2006.
Efficienza energetica
A cura di Letizia Palmisano – giornalista e comunicatrice ambientale
Con la locuzione “efficienza energetica” si fa riferimento all’utilizzo ottimale dell’energia in termini di riduzione dei consumi senza compromettere la qualità del prodotto o servizio fornito.
L’efficienza energetica differisce, quindi, dal più ampio concetto di risparmio energetico che, invece, consiste in una riduzione assoluta del consumo energetico perseguibile anche tramite la diminuzione dell’impiego di dispositivi o attrezzature energetiche.
Un esempio concreto di efficientamento energetico è la sostituzione di un impianto di illuminazione di classe energetica G con uno di classe A, mentre la riduzione dell’uso dei dispositivi di illuminazione o dell’orario di accensione rappresenta un intervento di risparmio energetico.
Le sfide della politica energetica europea oggi riguardano gli obiettivi di decarbonizzazione, la riduzione delle emissioni climalteranti, la limitazione dalle importazioni. Tra le diverse misure adottate, un ruolo rilevante è rivestito dall’efficienza energetica nei diversi settori di applicazione.
Questo concetto è un punto centrale delle politiche di sostenibilità e delle strategie di riduzione dell’impatto ambientale, poiché l’energia che consumiamo all’interno degli edifici (in primis per il riscaldamento e il raffreddamento), per il trasporto e nell’industria è spesso prodotta utilizzando fonti fossili che contribuiscono al cambiamento climatico e all’inquinamento atmosferico. Gli investimenti in efficienza energetica consentono – oltre al conseguimento di una forte riduzione delle emissioni climalteranti e al miglioramento della sicurezza e dell’indipendenza energetica – anche di ottenere una sensibile diminuzione dei costi operativi.
Attualmente, l’efficienza energetica si persegue nei settori con elevati consumi energetici. A tal fine, nel corso degli anni, sono state emanate disposizioni normative che stabiliscono standard minimi di efficienza e incentivi economici per superare ostacoli come il costo iniziale degli interventi e la resistenza al cambiamento.
Nel settore dell’edilizia si interviene sia sulle nuove costruzioni – le quali devono tutte essere a fabbisogno di energia quasi zero (nZEB – near Zero Energy Building) – sia sugli edifici oggetto di ristrutturazione per migliorare l’isolamento termico, far sostituire impianti vetusti con quelli di riscaldamento, ventilazione e aria condizionata (HVAC) efficienti e l’implementazione di tecnologie intelligenti per la gestione dell’energia.
Altro ambito chiave è quello dei trasporti che prevede l’adozione di veicoli a basso consumo, elettrici, ibridi nonché il miglioramento della logistica e la promozione della mobilità sostenibile come il car sharing, il trasporto pubblico e l’uso della bicicletta in città.
Nel comparto industriale si promuovono l’ottimizzazione dei processi produttivi con la progettazione di impianti a basso impatto, l’utilizzo di sistemi di recupero del calore di scarto, la manutenzione efficiente dell’attrezzatura e la sostituzione di macchinari obsoleti con tecnologie moderne ed efficienti.
Nonostante i numerosi vantaggi, gli incentivi ed una maggiore consapevolezza sull’importanza ambientale ed economica dell’efficienza energetica, in alcuni casi potrebbe verificarsi un effetto rebound caratterizzato dal fatto che il risparmio energetico ottenuto porti a un aumento del consumo complessivo a causa di una maggiore accessibilità o comfort percettivo (ad es. l’acquisto di un frigorifero più grande di classe energetica A può consumare di più rispetto al modello sostituito di classe energetica C ma di dimensioni più contenute).
Per ottenere risultati concreti e duraturi in termini di efficienza energetica, oltre alle tecnologie, sono quindi necessarie campagne di educazione e informazione dedicate all’energia e all’uso consapevole.
Per approfondire
- Nardi, L. Palmisano, 10 idee per salvare il pianeta prima che sparisca il cioccolato, Città Nuova, 2021
- Nardi, L. Palmisano, 10 idee per salvare il pianeta prima che sparisca il cioccolato, Città Nuova, 2021
- Ciucci, Efficienza energetica, 2023, https://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/sheet/69/efficienza-energetica
Epidemiologia ambientale
a cura di A Sud
L’epidemiologia ambientale è una disciplina scientifica che studia come i fattori ambientali influenzano la salute umana, analizzando la relazione tra l’esposizione agli agenti ambientali (tra cui inquinanti chimici, fisici e biologici) e le condizioni di salute, inclusa l’insorgenza di patologie acute o croniche. Si tratta di un campo di studio cruciale per comprendere e prevenire gli effetti negativi dell’ambiente sulla salute umana.
Gli epidemiologi ambientali utilizzano metodi statistici e di sorveglianza per identificare associazioni tra esposizioni ambientali e problemi di salute. Ad esempio, possono studiare l’impatto dell’inquinamento atmosferico sulla frequenza di malattie respiratorie o valutare come l’esposizione a sostanze tossiche nell’acqua potabile possa influenzare l’incidenza di tumori. Questi studi forniscono evidenze scientifiche fondamentali per lo sviluppo di politiche e regolamenti che mirano a ridurre i rischi ambientali e proteggere la salute pubblica.
Un aspetto chiave dell’epidemiologia ambientale è la valutazione del rischio, che implica la quantificazione del rischio di malattia associato a specifiche esposizioni ambientali. L’epidemiologia ambientale lavora spesso in sinergia con altre discipline, come la tossicologia, la medicina del lavoro e la scienza dei dati, per sviluppare un quadro completo dei rischi ambientali e delle loro implicazioni per la salute.
In Italia dal 2006 l’Istituto Superiore di Sanità promuove il progetto SENTIERI, un sistema nazionale di sorveglianza epidemiologica permanente delle comunità che risiedono in prossimità delle principali aree inquinate sul territorio italiano, i cosiddetti SIN, Siti di interesse nazionale per le bonifiche (si veda la voce di glossario dedicata). SENTIERI fornisce evidenze per identificare le priorità nella gestione dei rischi che riguardano gli interventi di salute pubblica, le bonifiche e la comunicazione con i portatori d’interesse.
Il progetto SENTIERI è coordinato dall’Istituto superiore di sanità e finanziato dal Ministero della Salute. Dal 2014 il Progetto fa parte del Programma statistico nazionale, nel settore Ambiente e territorio.
Per approfondire:
- Istituto Superiore di Sanità, SENTIERI – Studio Epidemiologico Nazionale dei Territori e Insediamenti Esposti a Rischio di Inquinamento, pagina web del progetto.
- Epidemiologia ambientale, associazione italiana di epidemiologia.
EPR – Responsabilità estesa del produttore
A cura di Danilo Bonato ― ingegnere esperto economia circolare, Erion Weee
I regimi di Responsabilità Estesa o EPR (Extended Producer Responsibility) hanno acquistato una certa rilevanza da quando la Commissione Europea li ha messi al centro delle politiche di transizione verso l’economia circolare dell’Unione. Del resto, la vigorosa crescita delle quantità di rifiuti generati dalle famiglie e dalle attività produttive richiama alla mente i pesanti impatti di natura ambientale e sanitaria ad essa associati ma allo stesso tempo ci fa riflettere sulle perdite economiche determinate dal mancato riciclo di preziose materie prime seconde. Per tali ragioni, i produttori che progettano, fabbricano e commercializzano beni offerti al mercato sono chiamati ad organizzare il loro impegno ambientale in forme collettive, note appunto come “sistemi EPR”, al fine di organizzare e finanziare la gestione del fine vita dei suddetti beni.
I principi fondanti della responsabilità estesa del produttore furono introdotti negli anni Novanta dal professore svedese Thomas Lindhqvist, con l’obiettivo di responsabilizzare l’industria sulla gestione dell’intero ciclo di vita del prodotto. Le ricerche di Lindhqvist si sono sviluppate nell’ambito delle discipline dell’ecologia industriale, per identificare modalità organizzative atte a migliorare l’efficienza delle risorse e per rispondere alle criticità che gli enti locali svedesi iniziavano a sperimentare nella gestione di quantità di rifiuti in forte crescita.
Lindhqvist ha definito la responsabilità estesa del produttore come un principio ispiratore di politiche atte a promuovere miglioramenti sull’intero ciclo di vita del prodotto, estendendo la responsabilità del produttore a tutte le sue fasi.
Queste politiche non sono limitate alla gestione dei rifiuti, perché il vero obiettivo dell’Unione Europea è una profonda trasformazione degli attuali modelli socioeconomici basata su una visione sistemica e su un approccio rigenerativo all’uso delle risorse e dei sistemi naturali del pianeta.
Per approfondire:
- OECD: Extended Producer Responsibility: Updated Guidance for Efficient Waste Management, OECD Publishing, 2016.
- Lindhqvist T. Extended Producer Responsibility in Cleaner Production: Policy Principle to Promote Environmental Improvements of Product Systems, Lunds University Press, 2000.
Estrattivismo
a cura di A Sud
Con il termine estrattivismo si fa riferimento a un modello economico basato sull’estrazione e lo sfruttamento (e spesso l’esportazione) su larga scala di risorse naturali, come minerali, petrolio, gas, legname e prodotti agricoli. Questo approccio si concentra sull’uso intensivo delle risorse naturali per soddisfare la domanda globale di materie prime, spesso a scapito dell’ambiente e delle comunità locali.
Il concetto di estrattivismo è storicamente legato alle dinamiche di sviluppo dei paesi in via di sviluppo, dove l’economia dipende fortemente dalle esportazioni di risorse naturali. L’estrattivismo ha pesanti impatti non solo in termini socio-economici ma anche ambientali, legati alla distruzione degli ecosistemi, all’inquinamento, alla perdita di biodiversità e al degrado del suolo. Le comunità locali sono soggette inoltre a impatti negativi come lo sfollamento, la violazione dei diritti umani e la perdita di mezzi di sussistenza tradizionali. L’estrattivismo è strettamente connesso a questioni di giustizia sociale ed ambientale. Spesso, i benefici economici derivanti dall’estrazione delle risorse non vengono equamente distribuiti, con profitti che vanno principalmente a multinazionali e governi, mentre le comunità locali ne risultano impoverite e marginalizzate. In risposta ai problemi causati dall’estrattivismo, sono emerse varie forme di resistenza da parte delle comunità locali, organizzazioni non governative e movimenti sociali, le cui richieste riguardano sia la maggiore partecipazione nei processi decisionali, che la gestione sostenibile delle risorse e la tutela dell’ambiente e dei diritti umani.
Dal punto di vista teorico, la critica all’estrattivismo ha portato all’affermazione del concetto di post-estrattivismo (si veda voce di glossario dedicata).
Per approfondire:
- Gudynas E., Extractivism and neoextractivism: Two sides of the same curse, 2013.
- Svampa M., The New Extractivism in Latin America, 2013.
- Houtart F.J., From Extractivism to a Post-Extractivist Economy, From, University of Helsinki 2012.
Fair Share
a cura di Lucie Greyl – antropologa e presidente CDCA
Ancora poco dibattuto in Italia, l’approccio cosiddetto del Fair Share (o quota equa) relativo alla riduzione delle emissioni di gas serra rimanda ad una lettura degli accordi internazionali sul cambiamento climatico basata sull’equità fra gli Stati. Intrinsecamente connesso al carbon budget (si veda lemma dedicato), in quanto legato alla sua misurazione, il Fair Share mira a determinare quale livello di sforzo di riduzione delle emissioni da parte di un determinato stato è da considerarsi equo.
Tale carattere di equità è determinato dalla presa in considerazione di diversi elementi:
- La responsabilità storica emissiva di un determinato Paese: quanto ha emesso in passato definirà in parte l’impegno futuro partendo dal principio che chi ha inquinata di più storicamente dovrà fare maggiori sforzi nella mitigazione delle emissioni di gas serra;
- La capacità finanziaria e tecnologica di un determinato Paese: lo sforzo di mitigazione si declina sulle capacità finanziarie e tecnologiche di un determinato paese. Più un paese sarà finanziariamente agiato e tecnologicamente avanzato più il taglio delle sue emissioni dovrà essere importante.
Un altro elemento da considerare è quello del diritto di un paese a svilupparsi in modo sostenibile. Così concepito, il fair Share permette quindi di orientare il calcolo del carbon budget, e i target di riduzione delle emissioni e/o le politiche di mitigazione di uno Stato in un’ottica di equità.
Partendo da questi presupposti, la maggior parte dei paesi del Sud globale mostrano un minor responsabilità storica e capacità di mitigazione mentre la maggior parte dei paesi del Nord globale ha una maggior responsabilità storica ed una maggior capacità. Secondo l’approccio del Fair Share, i paesi del Nord globale dovrebbero non solo ridurre maggiormente le loro emissioni ma anche supportare i paesi del Sud globale in una trasformazione giusta e sostenibile delle loro economie.
Il calcolo del Fair Share mostra una varietà di metodologie che incrociano scienza del clima e diritto internazionale e possono variare a secondo del peso assegnato ai criteri di valutazione e agli indicatori scelti, come ad esempio il peso della responsabilità storica rispetto alla capacità finanziaria. Condividono però l’intento di definire in modo giusto lo sforzo per la riduzione delle emissioni e di indirizzare l’azione politica. In effetti, il Fair Share, permette non solo di proiettare obiettivi da raggiungere in futuro ma anche di confrontare gli sforzi effettivamente in campo rispetto a quello che servirebbe sia fatto in modo equo per limitare l’aumento delle temperature. Mette quindi in luce il gap tra gli sforzi messi in gap e il livello di sforzo necessario, sottolineando l’obbligo morale di fare di più, a secondo delle proprie responsabilità e capacità.
Il Fair Share si lega strettamente ai principi fondanti del diritto climatico, che informa gli accordi internazionali per il clima, il principio di equità e il principio delle responsabilità comuni ma differenziate.
Per approfondire:
- Climate Action Tracker project, Fair Share, risorsa web.
- Climate Action Tracker project, CAT data explorer, risorsa web.
- Climate Equity Reference project, Climate Equity Reference Calculator, risorsa web.
- Friends of the Earth International, Climate Fair Shares, risorsa web.
False soluzioni
a cura di Alessia Tisci – A Sud
Con l’espressione “false soluzioni” si fa riferimento all’insieme delle soluzioni alla crisi climatica non basate sul taglio delle emissioni di gas serra che ne sono causa ma su meccanismi di mercato o altre tecnologie di tipologia diversa che non mettono in discussione il modello energetico basato sulla combustione di fonti energetiche fossili, ovvero petrolio, gas e carbone. Il concetto deriva da una prospettiva bottom-up, a partire dai Forum Sociali Mondiali dei primi anni 2000. Emerge dalle battaglie sociali e dai movimenti ecologisti, contadini e indigeni, che criticano sin da principio l’introduzione, a livello di governance climatica, di misure che presentano l’evidente limite di non agire in maniera strutturale e sistemica sulle cause della crisi climatica, rappresentando piuttosto strategie che rispondono a logiche di mercato a vantaggio dei grandi player economici nazionali ed internazionali.
Tra le false soluzioni si trovano ad esempio i sistemi di compravendita di crediti di carbonio come Carbon Markets, Cap and Trade, Cap and Invest, gli strumenti di compensazione climatica, i meccanismi REDD e REDD+, le tecnologie come la CCS – Carbon Capture and Storage e la CCUS – Carbon Capture, Utilization and Storage, le monocolture destinate alla produzione di biocarburanti, invariabilmente legate a pratiche di deforestazione selvaggia, la geoingegneria climatica, la Climate smart agriculture e così via.
In relazione all’aggravamento della crisi climatica, che impone agli Stati rapidi percorsi di decarbonizzazione (vedi lemma dedicato), questo tipo di soluzioni non risultano adeguate a rimuovere o almeno a contenere le cause dell’innalzamento della temperatura globale. Al contrario, nella pratica esse concorrono al rallentamento del processo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, impegno che gli Stati hanno assunto attraverso la ratifica dell’Accordo di Parigi.
Per approfondire:
- Friends of the Earth, False Climate Solutions Archive, risorsa web.
- A Sud / CDCA, La decarbonizzazione secondo Eni. CCS e false soluzioni alla crisi climatica, Osservatorio Eni, 2023.
- A Sud / CDCA, La decarbonizzazione secondo Eni. Biocarburanti, una partita italiana, Osservatorio Eni, 2024.
- Leonardi Emanuele, Carbon Trading Dogma, Presupposti teorici e implicazioni pratiche dei mercati globali di emissioni di gas climalteranti, Jura gentium, 2019.
- Paniè Francesco, Il lato oscuro del mercato del carbonio, Il Tascabile, 2020.
Finanza climatica
a cura di Filippo Garelli – giurista, La Sapienza Università Di Roma
Non esiste una definizione univoca di “finanza per il clima” anche se è possibile individuare alcuni cluster utili a inquadrare questa materia, ad esempio, le aree di riferimento, gli attori coinvolti e gli strumenti utilizzati. Accogliendo questo approccio, la finanza per il clima è l’insieme degli sforzi e delle strategie di investimento promosse da attori pubblici e privati per fornire e mobilitare risorse finanziarie, specialmente a favore dei Paesi in via di sviluppo o di quelli più vulnerabili, al fine di ridurre le emissioni nette di gas serra e rafforzare la resilienza dei sistemi umani ed ecologici in relazione all’impatto del cambiamento climatico. Di conseguenza, la finanza per il clima può supportare la realizzazione di progetti o tecnologie per ridurre le emissioni mediante l’uso di energia rinnovabile (solare, eolica, idroelettrica o comunque a basse emissioni di carbonio) oppure la realizzazione di infrastrutture resilienti all’impatto dei cambiamenti climatici nei Paesi più vulnerabili. Nel complesso, queste azioni possono essere realizzate mediante l’impiego di diversi strumenti: sovvenzioni, prestiti agevolati, garanzie, obbligazioni verdi, l’introduzione di una carbon tax o di sistemi di scambio delle quote di emissioni (c.d. emissions trading systems). A livello internazionale e sul piano giuridico, dopo l’adozione della Convenzione delle Nazioni Unite sul Cambiamento Climatico del 1992 e del Protocollo di Kyoto del 1997, il supporto finanziario per il clima trova ulteriore sviluppo nell’Accordo di Parigi. Oggi questo trattato rappresenta il principale strumento sulla governance per il clima. Inoltre, anche l’Agenda 2030 dedica gran parte dell’obiettivo n. 13 al supporto finanziario nel contesto della lotta al cambiamento climatico. Nel complesso, la finanza per il clima coinvolge una vasta gamma di attori, come Stati, istituzioni finanziarie, imprese, ONG e individui che adottano politiche, legislazioni, strumenti finanziari e strategie di investimento per promuovere lo sviluppo sostenibile e per contribuire alla lotta al cambiamento climatico a livello nazionale e internazionale.
Per approfondire:
- Bodansky D., Brunnée J., Rajamani L., International Climate Change Law, Oxford University Press, 2017.
- Green Climate Fund, sito web.
- Gastelumendi J., Gnittke I., Climate Finance in The Paris Agreement on Climate Change. Analysis and Commentary, Klein D., Doelle M., (a cura di) Oxford University Press, 2017.
- Mehling H. Article 9. Finance, in The Paris Agreement on climate change. A commentary, Calster G.V., Reins L (a cura di), Edward Elgar, 2021.
Gentrificazione
a cura di A Sud
La gentrificazione è un processo urbano in cui aree precedentemente caratterizzate da basse rendite immobiliari e condizioni economiche svantaggiate vengono trasformate attraverso l’afflusso di nuovi investimenti e residenti più abbienti. Come conseguenza, la gentrificazione porta alla dislocazione delle comunità locali: le popolazioni a basso reddito, spesso composte da minoranze etniche e culturali, vengono costrette a lasciare i loro quartieri a causa dell’aumento degli affitti e del costo della vita. Questo processo non solo interrompe le reti sociali e comunitarie esistenti, ma comporta anche una perdita di identità culturale e storica per le aree urbane coinvolte. Non si tratta cioè di una trasformazione solo fisica dello spazio urbano, ma di un processo di sostituzione sociale che amplifica le disuguaglianze esistenti e mina la giustizia sociale ed economica nelle città. In tal senso, la gentrificazione rappresenta un fenomeno di esclusione sociale e ingiustizia economica, che vedono la città come opportunità di profitto piuttosto che come luoghi di residenza e socialità.
Le politiche di sviluppo urbano, incentivando investimenti privati e progetti di riqualificazione, finiscono con il favorire gli interessi di speculatori immobiliari e grandi sviluppatori a discapito delle esigenze delle comunità, perpetuando un ciclo di marginalizzazione. Contro questo processo, cui caratteristica centrale è la disparità di potere e risorse, sempre più spesso le organizzazioni di base e i gruppi di attivisti si attivano per ottenere politiche più inclusive e per il diritto alla città, cercando di preservare abitazioni a prezzi accessibili e spazi pubblici e servizi per tutti i residenti.
Per approfondire:
- Barile A., Brollo B., et al, Dopo la gentrificazione, Derive e Approdi, 2023.
- Gainsforth S., Airbnb città merce. Storie di resistenza alla gentrificazione, Derive e Approdi, 2019.
- Gainsforth S., Chi usa le città non sempre paga per farle funzionare, Internazionale, 2023.
Gerarchia dei rifiuti
A cura di Daniele Di Stefano — giornalista, EconomiaCircolare.com
La gerarchia dei rifiuti è la pietra angolare delle politiche e della legislazione sui rifiuti dell’Unione Europea. Stabilita dall’articolo 4 della direttiva quadro dell’Unione sui rifiuti (Direttiva 2008/98/CE) prescrive un ordine di priorità nella prevenzione e gestione dei rifiuti:
- prevenzione (o riduzione a monte);
- preparazione per il riutilizzo (o riuso);
- riciclaggio (o riciclo);
- recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
- smaltimento.
La prevenzione riduce la quantità di rifiuti. Strategie tipiche per la riduzione sono il riutilizzo dei prodotti da parte di più soggetti successivi, l’estensione della loro durata di vita, la condivisione tra soggetti diversi (che riduce il totale di beni in circolazione e ne ottimizza l’impiego).
Secondo livello della gerarchia, subito dopo la prevenzione e subito dopo che un bene è diventato rifiuto, è la preparazione per il riutilizzo.
Dopo la prevenzione e il riuso, arriva il riciclaggio (incluso il trattamento di materiale organico, come il compostaggio).
Quando un prodotto non si può riutilizzare né riciclare, la gerarchia ammette il recupero: qualsiasi altra operazione differente dal riciclo «il cui risultato principale è un rifiuto che serve a uno scopo utile sostituendo altri materiali». La principale forma di recupero è quella energetica, ma solo se la combustione viene usata anche per produrre energia sopra una certa soglia di efficienza.
Se i rifiuti non possono neanche essere inceneriti (per ragioni intrinseche o per la mancata convenienza economica) non resta che lo smaltimento in discarica. Si tratta quindi di un’opzione residuale, tanto che con la Direttiva 2018/850/ UE, parte del pacchetto sull’economia circolare, è stato introdotto un limite (il 10%) alla quota di rifiuti urbani che possono essere conferiti in discarica.
Una volta enunciata la gerarchia, la direttiva presenta le possibili eccezioni: «Può essere necessario che flussi di rifiuti specifici si discostino dalla gerarchia laddove ciò sia giustificato dall’impostazione in termini di ciclo di vita in relazione agli impatti complessivi della produzione e della gestione di tali rifiuti».
Per approfondire:
- Normativa Unione europea sulla gestione dei rifiuti, Direttiva 2008/98/CE
Giustizia ambientale
a cura di Marica Di Pierri – giornalista e ricercatrice, A Sud
La Giustizia ambientale è un principio politico-filosofico che considera i fattori ambientali come elementi capaci di incidere su equità e giustizia sociale. Il concetto pone l’accento sull’iniqua distribuzione di fattori di rischio ambientale derivanti da attività antropiche su Stati, comunità, individui, generazioni. Da un lato ne denuncia il carico di ingiustizia, dall’altro lato chiede pari protezione da tali rischi. Si tratta di una nozione che ha assunto particolare rilievo a livello accademico ma la cui origine va ricercata nei fenomeni di attivazione popolare, cui deve il forte carattere rivendicativo.
Il concetto di Giustizia ambientale si sviluppa infatti negli Stati Uniti a partire dagli anni ’80, muovendo dall’osservazione dell’iniqua distruzione di costi e benefici ambientali sulle diverse comunità locali. Nel 1982, nella Contea di Warren (in North Carolina) si osserva maggiore concentrazione di impianti tossici in prossimità di insediamenti di comunità afrodiscendenti, ovvero minoranze etniche o comunità a basso reddito, che porta a teorizzare l’uso dell’elemento razziale come criterio discriminatorio applicato per l’adozione di politiche ambientali. Tale osservazione scatena una forte ondata di mobilitazioni dando vita al primo nucleo di ciò che diverrà nei decenni successivi un multiforme Movimento per la Giustizia Ambientale, diffuso a livello internazionale. La giustizia ambientale ha dunque una chiara connotazione intersezionale e unisce istanze provenienti da portati socio-politici diversi: movimenti per i diritti civili, movimento operaio, movimenti indigeni, ambientalismo.
Nel 1990 il sociologo Robert Bullard, considerato il padre della Giustizia Ambientale, pubblica “Dumping in Dixie”, primo di una lunga serie di saggi sul tema, considerato testo chiave per l’affermazione del concetto a livello accademico oltre che politico-mediatico. Nel 1991, nel corso del 1° National People of Color Environmental Leadership Summit vengono redatti i 17 principi di giustizia ambientale, ancora oggi punto di riferimento. Il focus sulla razza si allarga successivamente a discriminazioni su altre basi, a partire da quella socio-economica e di genere. L’avvento della Giustizia Ambientale crea una frattura con le correnti tradizionali dell’ambientalismo, in cui l’ambiente è un valore astratto e non socialmente caratterizzato.
L’istanza contenuta nel concetto di Giustizia ambientale, centrata sulla rivendicazione di una condizione di pari accesso ai benefici e pari protezione dai costi ambientali (dimensione distributiva); riguarda anche altri due aspetti di grande rilevanza: la garanzia di effettiva ed equa partecipazione ai processi decisionali da parte dei soggetti che hanno maggiori probabilità di essere danneggiati dai cambiamenti ambientali (dimensione procedurale) e la garanzia di accesso alla giustizia ovvero a strumenti di compensazione, risarcimento o altri rimedi da parte di coloro che risultano effettivamente colpiti dalle modifiche ecologiche (dimensione correttiva/riparativa).
Per approfondire:
- Bullard R., (a cura di) The quest for environmental justice. Human Rights and the politics of pollution, Sierra Club Books. San Francisco, 2005
- Bullard R., Dumping in Dixie: Race, Class and the Environmental Quality. Westview Press Boulder San Francisco, 1990.
- EJAtlas – Environmental Justice Atlas, sito web.
- Taylor D.E., The rise of the Environmental Justice Paradigm: injustice Framing and the social construction of Environmental discourses , in American Behovioral Scientist, 43(4), 508-580, 2000.
- 17 Principi di Giustizia Ambientale. First National People of Color Environmental Leadership Summit , 1991.
Giustizia climatica
a cura di Marica Di Pierri – giornalista e ricercatrice, A Sud
La giustizia climatica è un concetto politico-filosofico che si riferisce ad una concezione dei cambiamenti climatici non come mero fenomeno biosifico ma come questione che presenta profonde implicazioni etiche, sociali e politiche. Come nel caso della Giustizia ambientale (si veda lemma dedicato), il concetto è adottato in ambito accademico tuttavia la sua origine è legata ai percorsi di attivazione sociale ed in particolare al portato dei movimenti ambientalisti di base e ai movimenti indigeni.
L’iniquità cui si riferisce la nozione è duplice: da un lato, ineguale è il contributo fornito alla crisi climatica e dunque differenti sono le responsabilità imputabili a Stati, comunità, individui e generazioni, dall’altro iniqua è la distribuzione degli impatti climatici tra Stati, comunità, individui e generazioni. Elemento centrale nella costruzione della nozione di giustizia climatica è la messa a fuoco del rapporto inverso tra responsabilità e vulnerabilità: le popolazioni e gli Stati più vulnerabili e che subiscono le conseguenze più gravi del cambiamento climatico sono coloro che hanno contribuito in misura minore a emettere in atmosfera gas clima alteranti. Ciò porta a collegare gli impatti del cambiamento climatico ai concetti di giustizia, in particolare di giustizia ambientale e di giustizia sociale, valutandone gli effetti in termini di uguaglianza e tutela dei diritti umani. La disparità riguarda non solo la dimensione spaziale – geografica ma anche quella temporale, interessando le disparità di vulnerabilità anche le generazioni presente e future. La Giustizia climatica può quindi e intragenerazionale o intergenerazionale.
Obiettivi della giustizia climatica sono: il riconoscimento del contributo storico emissivo tra Paesi per il varo di politiche climatiche eque; la denuncia della sproporzione nella distribuzione degli impatti su comunità, Stati e generazioni e messa in campo di strumenti di tutela e protezione; la garanzia di processi decisionali inclusivi e partecipativi, liberi dalle pressioni dei gruppi industriali e capaci di riconoscere la pluralità di approcci culturali; la garanzia di accesso a meccanismi di riparazione / ripristino / risarcimento per danni e perdite già causate dalla crisi climatica.
Per approfondire:
- International Climate Justice Network, Principi di Giustizia climatica di Bali , 2002.
- Schlosberg D., Collins L.B., From environmental to climate justice: climate change and the discourse of environmental justice. WIREs Climate Change, 2014.
- Baxi U., Towards a climate change justice theory? Journal of Human Rights and the Environment, Vol. 7, 2016.
- Carducci M., La ricerca dei caratteri differenziali della “giustizia climatica”. DPCE Online, rivista giuridica online, Vol.43 No. 2, 2020.
Governance climatica
a cura di Marica Di Pierri – giornalista e ricercatrice, A Sud
L’espressione “governance climatica” indica l’insieme dei meccanismi di discussione e decisione – in una parola: di governo – con cui una pluralità di attori appartenenti a diversi settori (istituzionali, sociali, economici; pubblici o privati) – sono chiamati a discutere e agire in maniera coordinata per rispondere a specifiche questioni o problematiche rilevanti, in questo caso: il contrasto alla crisi climatica. Si tratta di un sistema poli-centrico, multi-attoriale e multi-livello, il cui carattere non è limitato ai soli attori governativi ma coinvolge enti regionali, agenzie governative, governi sub-nazionali, ong e imprese e la cui finalità è guidare il processo verso il conseguimento degli obiettivi concordati.
Nonostante esistano diversi livelli di governance climatica, in genere l’espressione è riferita alla governance globale intergovernativa, ovvero ai negoziati tra Stati svolti negli ultimi decenni nell’ambito delle Nazioni Unite, che rappresentano il foro internazionale dotato di maggior inclusività e capacità di incidenza a livello globale, pur con i limiti di efficacia che i trend emissivi continuano ad evidenziare. Le negoziazioni internazionali in ambito climatico sono focalizzate su due macro ambiti di azione, riguardanti uno la rimozione delle cause della crisi, l’altro l’attenuazione degli impatti, ovvero la mitigazione e l’adattamento. Guardando a ritroso i quasi tre decenni di negoziazioni climatiche appare chiaro che i meccanismi che ne caratterizzano il funzionamento hanno contribuito a generare stalli e impasse impedendo più volte di giungere all’adozione di misure risolutive. La responsabilità va individuata, tra gli altri fattori, nella mancanza di una volontà politica forte e condivisa.
L’organismo incaricato di studiare l’andamento dei cambiamenti climatici è il foro scientifico IPCC – Intergovernamental Panel on Climate Change (si veda la voce di glossario dedicata). Lo strumento internazionale normativo di riferimento per la governance climatica è l’UNFCCC, la Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (si veda la voce di glossario dedicata), siglata nel 1992 e ratificata da 197 parti, cui trattato attuativo è l’Accordo di Parigi firmato nel 2015, che ha sostituito il Protocollo di Kyoto del 1997. Ogni anno i paesi che hanno ratificato la Convenzione quadro si riuniscono nelle COP (Conference of Parties, organo della Convenzione) per valutare l’andamento nelle politiche di contrasto ai cambiamenti climatici e lavorare per un avanzamento.
Pur considerando i deludenti risultati in termini di efficacia dell’azione climatica raggiunti nel corso delle ultime COP e il calo progressivo della fiducia posta nelle istituzioni multilaterali, è opinione maggioritaria (comunità scientifica inclusa) che l’ambito rappresentato dalle Nazioni Unite sia la via maestra se non l’unica opzione in campo per elaborare risposte globali attraverso l’adozione di un framework efficace di impegni internazionali vincolanti, ambiziosi e coordinati in ambito climatico.
Per approfondire:
Greenwashing
A cura di Sivia Santucci ― giornalista EconomiaCircolare.com
Strategia di comunicazione o manovra di marketing messa in atto da aziende, enti, istituzioni, per dimostrare a possibili utenti o consumatori di garantire un servizio o un prodotto il più possibile sostenibile, nascondendone il reale impatto ambientale. In base al tipo di azione intrapresa, il greenwashing può assumere forme diverse e insidiose.
Una delle più comuni è quella del greenlighting. Si verifica quando un’azienda, attraverso pubblicità o comunicazione, mette in evidenza un aspetto, per quanto piccolo, legato ad un prodotto o un’azione che presuppone un certo grado di sostenibilità al fine di distogliere l’attenzione da attività dannose per l’ambiente condotte in altre aree.
Anche il greenlabelling, che si può tradurre come etichettatura verde, è una pratica di marketing piuttosto comune. Prevede che un prodotto o un servizio venga promosso o pubblicizzato come verde, sostenibile, bio, naturale, ecologico, senza effettivamente esserlo o essendolo solo in parte. In generale, una narrazione pubblica di un’azienda non coerente con gli impegni presi in campo ambientale è segno di greenwashing in quanto il consumatore è indotto a presumere che le azioni intraprese siano in linea con quanto messo in luce attraverso la strategia comunicativa.
Per appronfondire:
- Willis J., Bofiliou T., Manili A., Reynolds I., Koszowski N., Greenwashing Hydra, Planet Traker, 2023.
- Supran D., Hickey C., Dowling K., Richards R., Guide for the user of environmental marketing claims, Greenpeace, 2022.
Hot Spot Climatico
A cura di Paola Mercogliano – Climatologa e ricercatrice CMCC
Anche se una definizione univoca di hot spot climatico non esiste, con questa espressione ci si riferisce, in generale, è una regione geografica del pianeta in cui i cambiamenti climatici, in conseguenza dell’interazione con fattori fisici geografici e sociali, generano impatti più significativi che altrove su ecosistemi e società umane. Queste aree possono manifestare, ad esempio, un rapido aumento della temperatura media, cambiamenti nell’andamento delle precipitazioni o altre variazioni climatiche che fanno registrare valori estremi, con cambiamenti più intensi e severi rispetto alle regioni circostanti. Tali aree sono spesso individuate attraverso lo studio di serie storiche di dati climatici, che possono essere di vario tipo, quali misure in sito rilevate da stazioni meteorologiche o, negli ultimi decenni, misure ricavate da dati satellitari. È importante sottolineare che l’esistenza di molte piattaforme diverse per la rilevazione dei dati climatici e per la misurazione degli indicatori ad essi connessi, consente un’accurata valutazione delle caratteristiche del clima e del cambiamento climatico nelle varie aree della terra, consentendo quindi l’identificazione delle regioni che possono essere definite come hot spot.
Tra queste, anche l’Europa, in particolare il Mediterraneo, è considerata un hot spot della crisi climatica. Nel 2022, la temperatura media nel Vecchio Continente è stata di 2,3°C superiore al valore medio dell’età preindustriale (gli ultimi decenni del XIX secolo). Il tasso di riscaldamento dovuto alle attività umane è stato di circa il doppio rispetto alla media globale. Inoltre, nel corso degli ultimi quattro decenni, l’Europa ha sperimentato un aumento dell’intensità e della frequenza delle ondate di calore da 3 a 4 volte maggiore rispetto al resto del mondo.
Gli hot spot climatici, inoltre, possono essere caratterizzati non solo da significative variazioni climatiche, ma anche da condizioni di vulnerabilità sociale ed economica. In questi casi, cambiamenti climatici non particolarmente intensi possono causare impatti negativi molto rilevanti nei confronti, ad esempio, di comunità dotate di infrastrutture carenti, con bassi livelli di sviluppo economico, con ecosistemi particolarmente fragili e con fasce di popolazioni fragili.
Quando si definiscono strategie di adattamento al cambiamento climatico, è fondamentale considerare sia il pericolo climatico derivante dalle variazioni climatiche stesse, sia la vulnerabilità sociale ed economica delle comunità interessate. Solo affrontando entrambi questi fattori si possono sviluppare strategie di adattamento efficaci per ridurre gli impatti dei cambiamenti climatici e promuovere la resilienza delle comunità.
Sulla base di queste considerazioni, una definizione più completa e utile del concetto di hot spot del cambiamento climatico dovrebbe includere sia fattori climatici che socio-economici. Ciò consentirebbe di identificare specifiche aree in cui gli effetti del cambiamento climatico si riflettono in modo particolarmente intenso sugli ecosistemi naturali e sulle società umane.
Per approfondire:
IPCC Special report, Intergovernameltal Panel on Climate change, 2018
Innovazione sociale
A cura di Daniele Di Stefano — giornalista Economiacircolare.com
Le riflessioni sulla definizione e sul perimetro dell’innovazione sociale non sono ancora giunte ad un accordo sufficientemente ampio. Qui utilizzeremo questo etichetta nel senso di “innovazione che parte dalla comunità e ha come obiettivo e risultato il bene della comunità e della società con vantaggi per la salute dell’ecosistema”. Importa non solo il cosa ma anche il come: l’innovazione sociale deriva da processi reticolari, partecipati, inclusivi, collaborativi piuttosto che verticistici. E insieme alimenta questi processi, mostrando nelle sue premesse di aver raggiunto già l’obiettivo dell’empowerment delle persone e del rafforzamento delle comunità e delle relazioni sociali.
Secondo Raghuram Rajan, ex capo economista del Fondo monetario internazionale ed ex governatore della Banca centrale indiana, lo sviluppo va ridisegnato affiancando a Stato e mercato, i due pilastri considerati finora come protagonisti quasi esclusivi, la comunità. La comunità, afferma, ha un ruolo propulsivo che le va riconosciuto.
L’attenzione al ruolo centrale dell’innovazione sociale sta crescendo. Nell’aprile del 2023 l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione “Promuovere l’economia sociale e solidale per lo sviluppo sostenibile”, che mira al riconoscimento internazionale dell’Economia Sociale e Solidale (ESS) come strumento per contribuire al raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs), attraverso l’innovazione sociale e inclusiva. Nel lavoro “Urban Planet. Knowledge towards Sustainable Cities” (2018) realizzato da ricercatori dei maggiori centri di ricerca mondiali si può leggere che «le iniziative locali della società civile possono fare da pioniere e modellare nuove pratiche che possono poi essere riprese da altri attori (ad esempio, i responsabili politici), portando infine a cambiamenti incrementali o radicali nelle nostre pratiche e nei nostri modi di organizzare le cose».
Per approfondire:
- Raghuram G. Rajan, Il terzo pilastro. La comunità dimenticata da stato e mercati, Università Bocconi editore, 2019.
- Elmqvist T, Bai X, Frantzeskaki N, et al., eds. Urban Planet: Knowledge towards Sustainable Cities, Cambridge University Press; 2018.
Inquinanti atmosferici
A cura di Marco Cervino ─ fisico dell’atmosfera Cnr
«Inquinamento atmosferico: ogni modificazione dell’aria atmosferica, dovuta all’introduzione nella stessa di una o di più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da ledere o da costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità dell’ambiente oppure tali da ledere i beni materiali o compromettere gli usi legittimi dell’ambiente». Questa definizione è presente all’art.268 del Testo Unico Ambientale, che mantiene aggiornato il D.Lgs 152 del 2006 in fatto di norme in materia ambientale. L’ambito di applicazione è ristretto «agli impianti, (…) ed alle attività che producono emissioni in atmosfera e stabilisce i valori di emissione, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi delle emissioni ed i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite.» Questo deriva dal recepimento della Direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento, che fornisce la seguente definizione: «inquinamento: l’introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, (…), che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell’ambiente, causare il deterioramento dei beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell’ambiente o ad altri suoi legittimi usi; ». Si noti come il “potrebbero nuocere” diventi nella versione italiana “ledere o da costituire un pericolo”: anche nell’ultima forma, meno ampia, per preoccuparsi dell’inquinamento atmosferico non è necessaria la dimostrazione causa-effetto caso per caso, basta la possibilità o il pericolo di un nocumento.
Nel caso dell’inquinamento atmosferico, le sostanze in gioco sono molte. L’allegato I alla parte V D.Lgs 152/06 ne elenca tantissime, e individua una soglia di rilevanza e una concentrazione ammessa (sulla base del concetto di soglia sotto la quale non ci sarebbero effetti, si vedano i lemma principio di precauzione e procedimenti autorizzativi a proposito). Sul pericolo per la salute umana, l’Organizzazione Mondiale della Sanità aggiorna periodicamente le proprie linee guida, su CO, NO2, SO2, O3, e particelle di diametro inferiore a 10 e inferiore a 2.5 micrometri. Nell’ultima versione (2021) si prospetta l’approfondimento dell’impatto di particelle ultrafini, di diametro inferiore a 0.1 micrometri. La legislazione italiana per la tutela della salute umana non è aggiornata a queste linee guida, ma è ferma al D.Lgs 155 del 2010.
Nella categoria particelle, l’OMS considera presenti nel particolato una miscela complessa di altre sostanze inquinanti. In effetti il particolato è una miscela di particelle solide e liquide, costituite da elementi quali carbonio organico, inorganico, solfati, nitrati, metalli pesanti, idrocarburi policiclici aromatici, diossine e furani, e componenti naturali come spray marino, sabbia, ecc. Il particolato originato dalle attività umane è primario se immesso in atmosfera dalle sorgenti, o secondario se si forma successivamente, in seguito a trasformazioni chimico-fisiche di altre sostanze (dai gas NO2, SO2 e ammoniaca si formano ad es. i solfati e nitrati in forma solida).
Per approfondire:
Organizzazione Mondiale della Sanità, WHO global air quality guidelines: particulate matter (PM2.5 and PM10), ozone, nitrogen dioxide, sulfur dioxide and carbon monoxide. (2021).
Intersezionalità
A cura di Scosse ― Soluzioni Comunicative Studi Servizi Editoriali
Con il termine “intersezionalità” si intende la condizione per cui molteplici e differenti caratteristiche (il genere, la razza/etnia, la classe, l’orientamento sessuale, la cittadinanza, la (dis)abilità e molte altre) connotano, descrivono e identificano una stessa persona, rendendola portatrice di privilegi ma anche soggetta a oppressioni, e ponendola in posizioni diverse all’interno della gerarchia sociale del contesto politico, economico e socio-culturale che abita. Tali caratteristiche incidono nella vita quotidiana posizionando individu3 ed eventi in un sistema di relazioni di potere determinato dall’intersezione di diversi assi.
Al contempo l’intersezionalità è la prospettiva teorica e metodologica che permette di analizzare o osservare una situazione, un evento, un prodotto culturale o una dinamica sociale tenendo in considerazione il modo in cui diversi assi di oppressione intervengono simultaneamente e determinano condizioni diverse per 3 soggett3 coinvolt3. È una lente che consente di guardare a una persona come portatrice di una serie di caratteristiche, ognuna delle quali la rende, in misura maggiore o minore, soggetta a stigma e discriminazioni o piuttosto la colloca in una posizione privilegiata.
Tali assi operano simultaneamente, pertanto ogni persona, diversamente da un’altra, vive situazioni differenti in base all’interazione di tutti gli assi che la connotano e quindi in base a come è collocata all’interno delle scale gerarchiche, alle limitazioni che incontra nell’accesso ai diritti, alle discriminazioni cui è soggetta, agli stereotipi che vengono a essa associati. Le esperienze materiali saranno diverse, per esempio, per una donna bianca, eterosessuale e benestante, rispetto a una donna nera, disabile, ed economicamente svantaggiata.
Il tema delle differenze situate e delle intersezioni dei sistemi di oppressione che incidono sulle vite reali di donne differenti, in carne e ossa, nasce come pratica politica all’interno del femminismo Africano Americano e si diffonde a partire dal manifesto del Combahee River Collective (1977), un collettivo di donne nere e lesbiche di Boston che per primo denuncia l’azione simultanea dell’oppressione razziale, sessuale, eterosessuale e di classe a cui il capitalismo le sottopone, e che le differenzia dalle donne bianche.
È l’avvocata e studiosa femminista nera nordamericana Kimberlé Williams Crenshaw a coniare il termine nel 1989 in ambito giuridico, spiegandolo attraverso una metafora estremamente efficace: possiamo immaginare le discriminazioni come diverse strade che si incontrano in un incrocio, dove un incidente tra i veicoli può essere causato da stigmi che riguardano il genere e l’orientamento sessuale, ma anche l’etnia, il colore della pelle, la religione, la cultura familiare o dei paesi di provenienza, l’eventuale esperienza migratoria, la classe sociale, un corpo non conforme, le abilità fisiche e cognitive, l’età, e così via.
Assumere una prospettiva intersezionale impone di guardare a individu3 ed eventi come legat3 e reciprocamente condizionati. Vuol dire avere consapevolezza del fatto che strategie e soluzioni non sono valide ed efficaci per ogni persona, così come diversi sono i bisogni, le oppressioni e le esperienze vissute. Questo non avviene neutralizzando o rendendo invisibili le differenze fin qui nominate, che esistono e pesano sui vissuti di ciascun3, oltre a rappresentarne la ricchezza.
Per approfondire:
- Colette G., Sesso, razza e pratica del potere. L’idea di natura, Ombre Corte, 2020.
- Davis A., Donne, razza e classe, Alegre, 2018.
- Crenshaw K., Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence Against Women of Color, Standford Law Review, 1995.
- Hooks B., Ain’t I A Woman? Black Women and Feminism, South End Press, 1981.
- Taylor K. Y., “How we get free: Black feminism and the Combahee River Collective”, Haymarket Books, 2017.
IPCC – Intergovernamental Panel on Climate Change
a cura di Marica Di Pierri – giornalista e ricercatrice, A Sud
IPCC è l’acronimo di Intergovernamental Panel on Climate Change (in italiano panel intergovernativo sui cambiamenti climatici) e rappresenta il principale foro scientifico esistente a livello mondiale sulle questioni climatiche. L’IPCC è stato istituito nel 1998 dall’UNEP – Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente e dal WMO – Organizzazione Meteorologica Mondiale. L’IPCC si compone di ricercatori provenienti da tutto il mondo che contribuiscono alle attività su base volontaria. Si tratta di un organismo consultivo di natura tecnica, incaricato di analizzare dati tecnico-scientifici in tema di cambiamenti climatici, valutarne l’impatto ambientale e sociale e fornire indicazioni ai decisori politici circa policy e strategie di intervento.
Migliaia di scienziati e reviewers partecipano alla redazione dei rapporti; gli esperti sono nominati dai 195 governi membri e selezionati da un bureau di scienziati eletti dai governi per la durata di un ciclo di valutazione. Il processo di revisione – cui partecipano anche i 195 governi membri – assicura l’intersezione tra diversi approcci e la valutazione completa e obiettiva delle informazioni raccolte. Partecipano inoltre ai lavori le principali organizzazioni internazionali, governative e non. I report di valutazione pubblicati dall’IPCC costituiscono riferimento scientifico per i negoziati internazionali sul clima. Ad oggi sono stati elaborati e diffusi sei rapporti di valutazione, pubblicati con cadenza di 5-6 anni. Nel 1990 è stato pubblicato il First Assessment Report mentre l’ultimo, il Sesto (AR6), è stato pubblicato nel 2023.
L’IPCC ha avuto un enorme impatto sul modo in cui è percepito il cambiamento climatico a livello globale, sia dalla società civile che dai media e dalle istituzioni politiche nazionali ed internazionali.
Per approfondire:
- IPCC, sito web istituzionale.
- AR6, Sixth Assessment Report, Sintesi, 2023.
Isola di calore
a cura di Elio Lo Bello – A Sud
Le isole di calore urbano (in inglese Urban Heat Island) sono aree urbanizzate che registrano temperature più elevate rispetto ad altre aree periferiche, ad esempio rurali. Le temperature più elevate sono dovute al fatto che strade, edifici, parcheggi o altre infrastrutture urbane assorbono ed emettono il calore solare in misura maggiore rispetto ai paesaggi naturali. Le isole di calore sono dunque dovute alla scarsità di aree verdi che determina la carenza di zone d’ombra e di umido contribuendo al surriscaldamento. L’Agenzia Europea per l’Ambiente definisce questo fenomeno come soil sealing ossia impermeabilizzazione del suolo con materiali come cemento e pietra, a seguito di nuove costruzioni, strade, parcheggi ma anche altri spazi pubblici e privati. A seconda della sua entità, l’impermeabilizzazione del suolo riduce, se non impedisce completamente le funzioni naturali del suolo e i servizi ecosistemici nell’area interessata. Inoltre, poiché il rilascio del calore prosegue durante tutta la giornata, questo fa in modo che l’escursione termica fra il giorno e la notte sia minima nelle aree urbane in confronto ad aree più decentrate. Nei grandi centri urbani la presenza di edifici molto alti genera un altro fenomeno collegato a quello delle isole di calore, ossia quello dei canyon urbani rappresentati da strutture molto alte e ravvicinate che determinano grandi masse termiche che non permettono la dissipazione del calore.
La rete C40 che riunisce i sindaci delle principali città del mondo uniti nell’azione climatica calcola che sono circa 200 milioni gli abitanti che, in più di 350 città (che diventeranno 970 città nel 2050), vivono con temperature estive superiori ai 35 °C. Le ondate di calore estremo, cui effetti nel contesto di aree urbane è maggiore che altrove, rappresenta uno degli effetti più drammatici dei cambiamenti climatici sulla salute delle comunità umane e sono tra gli impatti climatici che causa maggior numero di decessi l’anno. L’innalzamento delle temperature non è l’unico effetto delle isole di calore, che incidono anche sulla qualità dell’aria tramite l’immissione di maggiori quantità di inquinanti. Inoltre, le acque che dalle isole di calore si immettono nei copri idrici ne determinano l’innalzamento della temperatura con potenziali danni su flora e fauna. Soluzioni possibili per contrastare le isole urbane di calore sono le cosiddette nature-based solutions: azioni mirate a proteggere, gestire in modo sostenibile e ripristinare gli ecosistemi naturali e quelli modificati in modo da garantire benessere per gli esseri umani e benefici per la biodiversità.
Concretamente le nature-based solutions consistono nell’aumento, miglioramento e valorizzazione di aree verdi, al fine di generare una serie di benefici e di servizi ecosistemici, ad esempio il miglioramento della qualità dell’aria, la regolazione del microclima urbano, la regolazione dei flussi idrici meteorici, la conservazione della biodiversità, l’offerta di opportunità di svago/ricreazione alle comunità residenti nelle zone maggiormente interessate, etc. Proprio alle nature-based solutions si lega la Nature Restoration Law europea approvata nel giugno 2024 che stabilisce obiettivi e obblighi specifici e giuridicamente vincolanti per il ripristino della natura negli ecosistemi terrestri, marini, d’acqua dolce, forestali, agricoli e urbani. Misure specifiche includono la protezione degli impollinatori e delle farfalle delle praterie, la protezione degli spazi verdi urbani e la piantumazione di almeno tre miliardi di alberi aggiuntivi entro il 2030 a livello dell’UE.
Per approfondire:
- https://www.cmcc.it/it/articolo/una-mappa-dettagliata-delle-urban-heat-islands
- https://www.eea.europa.eu/articles/urban-soil-sealing-in-europe
- https://www.reteclima.it/nature-based-solutions-nbs/
- https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2024/06/17/nature-restoration-law-council-gives-final-green-light/
- https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/env/2024/06/17/
Land Grabbing
a cura di A Sud
Il termine Land grabbing si riferisce all’acquisizione su larga scala di terreni agricoli, forestali o altre aree da parte di investitori privati, multinazionali, governi stranieri o altre entità. Questo fenomeno è particolarmente diffuso nei paesi in via di sviluppo e si è intensificato a partire dall’inizio del XXI secolo. Le ragioni dietro tali acquisizioni possono variare, ma comunemente includono l’espansione delle produzioni agricole destinate all’esportazione, la produzione di biocarburanti, la speculazione finanziaria, e l’accesso a risorse naturali come acqua e minerali. Uno degli aspetti più controversi del land grabbing è l’impatto che ha sulle comunità locali e sugli ecosistemi. Spesso, le terre acquisite sono già occupate o utilizzate da popolazioni indigene e agricoltori locali, che possono essere sfrattati senza un’adeguata compensazione o senza il loro consenso informato. Questo processo può portare a violazioni dei diritti umani, perdita di mezzi di sussistenza e disgregazione sociale. Il land grabbing può provocare significativi danni ambientali, inclusa la deforestazione, la perdita di biodiversità e l’erosione del suolo. Il fenomeno è strettamente legato alla globalizzazione e alla crescente domanda globale di cibo, energia e risorse naturali.
Dal punto di vista legale, il land grabbing solleva numerose questioni riguardanti la trasparenza delle transazioni, la giustizia sociale e la protezione dei diritti delle comunità indigene. In molti casi, i contratti di acquisizione di terre sono stipulati senza un’adeguata consultazione delle comunità locali e mancano di clausole che garantiscano il rispetto degli standard internazionali sui diritti umani e ambientali.
Per affrontare il problema del land grabbing, sono stati proposti vari strumenti e iniziative a livello internazionale. Ad esempio, le Linee guida volontarie per la gestione responsabile della terra, della pesca e delle foreste nel contesto della sicurezza alimentare nazionale, sviluppate dalla FAO.
Per approfondire:
- Liberti S., Land Grabbing. Come il mercato delle terre crea il nuovo colonialismo, Minimum Fax, 2015.
- Rullia M.C., Savioria A., D’Odorico P., Global Land and Water Grabbing, Proceedings of the National Academy of Sciences 110, no. 3, 2013.
Life Cycle Thinking
A cura di Carlo Proserpio ― LCA expert e docente Dipartimento di Design, Politecnico di Milano
Il Life Cycle Thinking – LCT è uno specifico approccio ai temi di sostenibilità che considera tutte le fasi del ciclo di vita di un prodotto e/o di un servizio: dall’estrazione dei materiali fino ai processi di trattamento del fine vita. Si tratta di un approccio spesso ribattezzato dalla culla alla tomba in cui sono identificate cinque fasi:
- Pre-produzione: comprende l’estrazione delle materie prime e delle risorse naturali.
- Produzione: comprende i processi di lavorazione delle materie prime.
- Distribuzione e trasporto: comprende le operazioni per rendere il prodotto o il servizio accessibile al consumatore.
- Uso e manutenzione: comprende l’uso del prodotto e le relative operazioni di manutenzione, aggiornamento e riparazione.
- Fine vita: comprende la gestione e il trattamento del prodotto dopo la sua dismissione attraverso il riciclaggio, il recupero energetico, il compostaggio e la discarica.
Nel corso degli anni si sono consolidati e diffusi, anche con il supporto di specifici standard ISO, gli approcci analitici al ciclo di vita:
- Life Cycle Assesment – LCA per la valutazione degli impatti ambientali dove, i più recenti metodi di valutazione, come l’Environmental Footprint promosso dalla Commissione Europea, arrivano a considerare 18 differenti indicatori quali, ad esempio, effetto serra, eutrofizzazione e scarsità d’acqua.
- Life Cycle Costing – LCC per la valutazione degli aspetti economici generati nelle diverse fasi del ciclo di vita considerando i costi di acquisto, di manutenzione, di riparazione, di sostituzione, di consumo delle risorse e di smaltimento
- Life Cycle Social Assessment – S-LCA per la valutazione degli aspetti sociali inerenti alle relazioni tra le organizzazioni coinvolte nel ciclo di vita e i relativi stakeholder.
L’insieme delle valutazioni ambientali, economiche e sociali è definita dall’UNEP come Life Cycle Sustainability Assessment – LSCA in quanto costituisce di fatto una valutazione su tutti gli aspetti della sostenibilità. Le metodologie di valutazione degli aspetti ambientali, economici e sociali rappresentano un elemento fondamentale nella transizione verso modelli di produzione e di consumo sostenibili in quanto permettono di supportare i processi decisionali attraverso robusti elementi analitici.
Per approfondire:
- Gestione ambientale – Valutazione del ciclo di vita – Principi e quadro di riferimento, UNI EN ISO 14040:2006.
- Raccomandazione della Commissione 2021/2279/UE, sito Anie Federazione imprese elettrotecniche ed elettroniche.
- UNEP, sito web.
- SETAC, sito web.
- Life Cycle Initiative, sito web.
Loss & Damage
A cura di Filippo Garelli – Ricercatore Università La Sapienza
Negli ultimi decenni, i cambiamenti climatici hanno portato a fenomeni meteorologici estremi sempre più frequenti e intensi. Inondazioni, siccità prolungate, tempeste tropicali, innalzamento del livello del mare, acidificazione degli oceani hanno causano perdite e danni significativi a comunità, ecosistemi e infrastrutture in tutto il mondo (Loss & Damage o L&D). In generale, si parla di perdite e danni economici quando interessano risorse, beni e servizi comunemente scambiati sui mercati, come nel caso dei danni alle infrastrutture o alle proprietà oppure nei casi di interruzioni della catena di approvvigionamento di beni, e quindi, danni suscettibili di riparazione. Le perdite e i danni non economici possono essere tra i più devastanti, come la perdita di vite umane, biodiversità, patrimonio o identità culturale oppure i casi migrazione forzata indotta dai cambiamenti climatici, spesso non facilmente suscettibili di valutazione economica.
A livello internazionale, il concetto di L&D emerge per la prima volta durante i negoziati del 1992 per l’adozione della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), tuttavia, una prima codificazione esplicita di questa materia si trova nel Bali Action Plan del 2007 e poi negli Accordi di Cancun del 2010. Inoltre, nel 2013, la COP decide di istituire il Meccanismo internazionale di Varsavia (WIM) per migliorare la conoscenza e la comprensione dei rischi connessi alle perdite e ai danni dovuti al cambiamento climatico. Il WIM contribuisce a rafforzare il coordinamento e le sinergie tra le parti coinvolte, nonché le azioni, le capacità e le risorse finanziarie a sostegno dei Paesi più vulnerabili. Il WIM è supportato anche da un comitato esecutivo (ExCom) che contribuisce a implementarne le relative funzioni.
Anche l’Accordo di Parigi dedica attenzione a questa materia e lo fa nell’art. 8, una disposizione che riconosce l’importanza di scongiurare, minimizzare e affrontare le perdite e i danni associati agli effetti negativi dei cambiamenti climatici, compresi gli eventi meteorologici estremi e quelli a lenta insorgenza. Inoltre, l’Accordo di Parigi individua alcune aree in cui gli Stati devono rafforzare la cooperazione per migliorare la comprensione, l’azione e il supporto di fronte alle perdite e ai danni provocati dal cambiamento climatico: la predisposizione di sistemi di allarme rapido; la preparazione di fronte a emergenze e l’incremento della resilienza delle comunità e degli ecosistemi; gli eventi a insorgenza lenta o che possono comportare perdite e danni irreversibili e permanenti; la valutazione e la gestione del rischio, insieme alle possibili soluzioni assicurative; le citate perdite non economiche. Questo settore è stato rafforzato notevolmente negli ultimi anni. In particolare, recentemente, la COP ha istituito e rafforzato il Network di Santiago, utile a catalizzare l’assistenza tecnica offerta nell’area L&D da diversi attori (organizzazioni internazionali, ONG, Agenzie, ecc.). In aggiunta, durante la COP27, le Parti hanno trovato l’accordo per l’istituzione di un fondo per fronteggiare le perdite e i danni, reso operativo nella successiva conferenza sul clima del 2023. Questi progressi potrebbero rivelarsi fondamentali, tenendo conto che soltanto tra il 2000 e il 2019, il mondo ha subito circa 2.800 miliardi di dollari in perdite e danni dovuti al cambiamento climatico, quasi 16 milioni di dollari all’ora. A fronte di questi dati allarmanti, durante l’ultima conferenza sul clima, alcuni Stati hanno espresso la loro volontà di destinare circa 792 miliardi di dollari a supporto delle perdite e dei danni. Si tratta di una somma ancora insufficiente, ma rappresenta un primo passo verso la realizzazione di sforzi più consistenti.
Per approfondire:
- Calliari E., Vanhala L. et al, Article 8. Loss and damage, in The Paris Agreement on climate change. A commentary, Geert Van Calster & Leonie Reins (a cura di), Edward Elgar, 2021.
- Linnéa Nordlander, Human Rights and Climate Change The Law on Loss and Damage, Routledge, 2024
- Reinhard Mechler, Laurens M. Bouwer, Thomas Schinko, Swenja Surminski & JoAnne Linnerooth-Bayer, Loss and Damage from Climate Change: Concepts, Methods and Policy Options, Springer International Publishing, 2019
- UNEP, About loss and damage, website.
- UNFCCC, Loss and damage. Online guide. 2024.
LULU – Locally Unwanted Land Use
Si rimanda a voce del glossario “NIMBY – Not In My Back Yard”
MAPA – Most Affected People and Areas
a cura di Marica Di Pierri – giornalista e ricercatrice, A Sud
MAPA è l’acronimo di Most Affected People and Areas, e sta indicare le regioni del pianeta o le popolazioni maggiormente colpite dagli impatti climatici. Il termine MAPa estende la concezione secondo cui sono soltanto i paesi del Sud globale ad essere i più colpiti dalla crisi climatica, aggiungendo alla lista anche zone e comunità vulnerabili che si trovano in paesi del Nord globale, ad esempio le comunità indigene o afrodiscendenti del nord America o le periferie a basso reddito dei paesi industrializzati. Il termine MAPA include quindi sia tutti i territori del Sud globale (Africa, Asia, America Latina, Isole del Pacifico, ecc.) che tutte le comunità emarginate (afrodiscendenti, indigeni, donne, anziani, minori, comunità a basso reddito, persone LGBTQIA, ecc.) ovunque insediate.
La definizione di MAPA ha come caratteristica principale l’intersezionalità (si veda la voce del glossario dedicata) che pone l’attenzione su come diverse caratteristiche – identità culturale, genere, razza, nazionalità, condizione socio-economica etc. – si sommano nel produrre discriminazione. Il riconoscimento di tale caratteristica è ritenuto fondamentale per articolare azioni climatiche eque e a sostegno delle comunità MAPA.
Nell’ultimo decennio, con l’ascesa dei movimenti giovanili climatici, in particolare Friday for Future, l’acronimo MAPA si è imposto come alternativa preferibile all’espressione Sud Globale in quanto maggiormente connessa con la dimensione della giustizia climatica.
L’espressione è oggi riconosciuta e utilizzata da diverse istituzioni, tra cui la UNEP, l’IPCC e il WEC ed è ampiamente usata sia in ambiti istituzionali, come nelle COP delle Nazioni Unite sul clima, che nel dibattito pubblico e a livello mediatico.
Per approfondire:
- Fortgang A., Countries and Territories Most Affected by Climate Change Also More Likely to Believe it to Be Personally Harmful, Yale Programme on Climate Change, 2021.
- Friday for future, What is MAPA and why should we pay attention to it?, 2021.
- World Economic Forum, MAPA voices: Climate Week messages from Most Affected People and Areas, 2023.
Matrice ambientale
A cura di Lorenzo Manni – geologo
Per matrice ambientale si intende uno degli elementi fisici che compongono quell’insieme complesso definito ambiente. Sono matrici ambientali l’aria e l’atmosfera, le acque superficiali e sotterranee, il suolo, il sottosuolo, la vegetazione, la fauna, ma anche il paesaggio, il clima o fattori fisici, come le vibrazioni, il rumore, i campi elettromagnetici, la radioattività. Il concetto di matrice ambientale si applica prevalentemente nell’ambito del monitoraggio dello stato dell’ambiente, nello studio, nell’analisi e nella valutazione degli effetti e dei potenziali impatti delle attività umane e nel campo della caratterizzazione e della bonifica dei siti inquinati.
Per ogni matrice ambientale esistono tecniche di campionamento e rigidi protocolli analitici, definiti in specifiche normative o linee guida cui è obbligatorio attenersi nelle valutazioni ambientali o nei piani di caratterizzazione e controllo ai fini della bonifica dei siti inquinati.
Per approfondire:
Migrazioni ambientali
A cura di Maria Marano – esperta di Diritto Ambientale
Comunità o persone costrette a migrare, in modo temporaneo o definitivo, fuori o più comunemente entro i confini del Paese, perché a causa di disastri ambientali non sono in grado di garantirsi i mezzi di sostentamento nelle terre di origine (ecologicamente fragili e con sistemi di governance poco stabili). Questi spostamenti non sono indotti solo dal collasso climatico, riguardano anche (falsi) progetti di sviluppo (dighe, infrastrutture di trasporto, industria mineraria, pratiche agricole non sostenibili o pratiche di land e water grabbing, ossia sottrazione di terre o acqua alle popolazioni locali). Tali progetti, principalmente nelle realtà in via di sviluppo, minacciano ecosistemi vitali per le comunità che dipendono dai loro servizi ecosistemi (pesca, agricoltura, legname) sia per i bisogni primari che per tutelare la loro cultura e identità. Le persone in fuga per cause ambientali restano nel limbo giuridico o più comunemente sono rimandate nella categoria migranti economici.
Per approfondire
- A Sud, Crisi ambientale e migrazioni forzate. L’ondata silenziosa oltre la fortezza Europa, I Edizione, 2016.
- Oxfam, Climate equality: a planet for the 99%, 2023.
- UNHCR, Climate change impacts and cross-border displacement: International refugee law and UNHCR’s mandate, 2023.
Migrazioni climatiche
A cura di Maria Marano – esperta di Diritto Ambientale
Persone o comunità costrette ad abbandonare le proprie terre a causa di eventi climatici estremi (alluvioni, siccità, desertificazione, innalzamento del livello del mare). Si tratta principalmente di spostamenti entro i confini nazionali quindi di sfollati interni, spesso in aree altrettanto esposte a rischi climatici. I cambiamenti climatici sono moltiplicatori di minacce, colpiscono maggiormente le popolazioni che affrontano altre sfide strutturali (instabilità sociale, economica, politica), inasprendo o provocando a cascata ulteriori effetti avversi (carestie, conflitti armati, violenza). È quindi semplicistico e complesso isolare un solo driver della mobilità umana. Parlare di migrazioni climatiche aiuta però a spiegare le cause umane e le responsabilità politiche che caratterizzano questi fenomeni. Chi migra per disastri climatici e degrado ambientale non può godere dello status di rifugiato perché non riconducibile alla Convenzione ONU sui rifugiati del 1951. Sono pochi i quadri internazionali e i regimi giuridici regionali e nazionali che rimandano a una protezione adeguata. Nel valutare le richieste di protezione la comunità internazionale deve muoversi anche sulla base della rilettura del concetto di violenza derivata dal collasso climatico e sfruttamento di risorse naturali. I disastri climatici minacciano i diritti fondamentali, incluso il diritto alla vita, attivando l’obbligo per gli Stati di non respingimento anche in caso di catastrofi climatiche, a condizione che si provi il rischio reale e personale per la vita (rif. sentenza – non vincolante – del Comitato dei diritti umani dell’ONU sul caso Teitiota). Al 2050 le stime prevedono 250 milioni-1 miliardo di profughi del clima. Tuttavia, la migrazione, soprattutto internazionale che ha costi alti, può diventare impraticabile per le comunità indigenti proprio a causa del clima. Migliaia di persone rischiano di restare intrappolate in luoghi inospitali, vulnerabili a successivi shock climatici e povertà.
Per approfondire
- A Sud, Crisi ambientale e migrazioni forzate. Persecuzioni climatiche, III Edizione, 2023.
- H. Benveniste, M. Oppenheimer, M. Fleurbaey, Climate Change, increases resource-constrained international immobility, Nature Climate Change, 2022.
- IDMC, Global Report on Internal Displacement (GRID), 2023.
- IPCC, Sesto Rapporto di Valutazione sui Cambiamenti Climatici (AR6), 2023.
- UN Human Rights Committee, Ioane Teitiota v. New Zealand, CPR/C/127/D/2728/2016, 2020.
Miniere urbane
a cura di Raffaele Lupoli – Direttore Economiacircolare.com
L’eccessivo sfruttamento di risorse naturali diventa un elemento di criticità ancora maggiore quando queste risorse fanno parte delle cosiddette materie prime critiche, quelle cioè difficili da reperire a causa della loro distribuzione non uniforme sul pianeta, oppure a causa di situazioni di conflitto o di mancato rispetto dei diritti umani e ambientali nelle zone dove sono presenti. Dunque queste materie, quasi sempre indispensabili per realizzare i prodotti hi-tech e le cosiddette tecnologie per la transizione ecologica, risultano carenti e spesso sono al centro di guerre commerciali per il loro accaparramento. Ciononostante, parallelamente, enormi quantità di oggetti non più in uso che contengono questi materiali vengono gettati via senza che ci si curi di recuperare risorse ancora preziose per realizzare nuovi prodotti. Insomma, oltre a ricorrere alle miniere per estrarre nuovi materiali abbiamo a disposizione vere e proprie “miniere urbane” che ci possono consentire di ricavare dai rifiuti elettrici ed elettronici, i cosiddetti RAEE (vedi voce dedicata), metalli e altri materiali preziosi che diventano materie prime secondarie.
La produzione mondiale di RAEE sta aumentando cinque volte più velocemente rispetto al loro riciclo. Si stima che nel 2030 arriveremo a circa 75 milioni di tonnellate di rifiuti elettronici prodotti nel mondo, ossia 9 chilogrammi pro capite in un anno, e nel 2050 le tonnellate di e-waste potrebbero essere addirittura 120 milioni. A livello globale, degli oltre 40 milioni di tonnellate di rifiuti elettronici che oggi finiscono annualmente in discarica, viene riciclato solo il 20%. L’Europa, anche in virtù della consapevolezza di essere povera di molte di materie prime critiche, arriva a riciclare il 42,8% di questi materiali, ma molto ancora si può e si deve fare.
Coerentemente con la gerarchia europea dei rifiuti (vedi lemma dedicato) e con le più recenti norme di attuazione del Green Deal, le linee d’azione prioritarie riguardano la progettazione di beni che sempre più dovranno essere durevoli, facilmente smontabili e riparabili: ciò significa prevenire la produzione di rifiuti elettronici, facilitando sia la riparazione sia il successivo riciclo a fine vita. Piuttosto che estrarre i materiali per realizzare smartphone, batterie e processori dalle profondità della terra o degli oceani, ricorrere alle miniere urbane significa salvaguardare la natura e la biodiversità e ridurre il peso di queste tecnologie sull’emergenza climatica e ambientale.
Per approfondire:
- Unitar, United Nations Intitute for Training and Research, Global e-waste monitor, 2024.
Mitigazione
a cura di Marica Di Pierri – giornalista e ricercatrice, A Sud
L’azione climatica si divide in due macro ambiti di azione: la rimozione delle cause della crisi climatica (mitigazione, vedi voce di glossario dedicata) e l’attenuazione degli impatti (adattamento). Rientrano nelle politiche di mitigazione tutti gli interventi volti all’eliminazione o quanto meno alla riduzione delle cause dei cambiamenti climatici; ovvero la riduzione delle emissioni di gas serra attraverso l’imposizione di limiti ai processi che li generano (ad esempio la produzione di energia da combustione), nonché attraverso politiche di recupero e stoccaggio dei gas prodotti per evitarne la dispersione in atmosfera. Le misure di mitigazione sono dotate di efficacia solo se raggiungono l’obiettivo di incidere in misura sensibile sul totale delle emissioni globali prodotte e solo se la riduzione è continuativa nel tempo. Ciò è possibile solo attraverso un consenso internazionale il più ampio possibile, che parta dal diretto coinvolgimento nelle azioni di riduzione dei maggiori Paesi emettitori di gas serra.
Come le politiche di adattamento, anche le politiche di mitigazione, per essere orientate ai diritti umani, devono prevedere anzitutto obiettivi che salvaguardino i diritti delle persone più vulnerabili.
Imprescindibile è dunque il ruolo che i Paesi industrializzati sono chiamati a svolgere in base al principio delle responsabilità comuni ma differenziate (vedi voce di glossario dedicata), compiendo sforzi maggiori rispetto ai Paesi in via di sviluppo e fornendo finanziamenti e tecnologie necessari a questi ultimi per tutelare i diritti della popolazione e sostenere le politiche di riduzione delle emissioni.
Per approfondire:
- IPCC Focal Point for Italy, Mitigazione dei cambiamenti climatici, 2022.
- Fant S. Cos’è la mitigazione del cambiamento climatico, Materia Rinnovabile, 2023.
Monitoraggio Ambientale Partecipato
a cura di Laura Greco – antropologa, presidente A Sud
Il monitoraggio ambientale, secondo l’Agenzia Europea dell’Ambiente – EEA, consiste in misurazioni, valutazioni e determinazioni periodiche e/o continuative di parametri ambientali e/o livelli di inquinamento, al fine di prevenire effetti negativi e dannosi sull’ambiente.
Nell’ambito del lavoro sul campo svolto da esperti del settore, il monitoraggio ambientale è un processo complesso che integra osservazione, misurazione e raccolta di dati bio-fisici di un ambiente specifico. Questo processo si estende per un periodo di tempo sufficiente a ottenere una quantità di dati statisticamente significativa. La raccolta e la gestione dei dati sono aspetti fondamentali in tutto il processo e sono generalmente affidate a dispositivi tecnologici avanzati, noti come sistemi di monitoraggio ambientale, di cui dispongono le Agenzie Ambientali. Questi dispositivi non solo raccolgono tutte le misurazioni relative ai parametri dell’ambiente monitorato, ma si occupano anche del trasferimento e dell’elaborazione di tali dati.
Il monitoraggio ambientale partecipato comprende tutte le attività relative alla raccolta di dati ambientali da parte di cittadini che, coadiuvati da tecnici ed esperti, contribuiscono a rendere il controllo delle matrici ambientali più capillare e duraturo. È uno strumento utile nella scienza civica aperta, volto a promuovere la partecipazione attiva dei non addetti ai lavori alla ricerca scientifica. Questo approccio promuove trasparenza, responsabilizzazione e empowerment delle comunità, permettendo loro di contribuire alla gestione e alla protezione del loro territorio attraverso la collaborazione con istituzioni pubbliche e organizzazioni non governative.
Per approfondire:
- Berti Suman A., The Policy Uptake of Citizen Sensing (Cheltenham, Edward Elgar 2021)
- Berti Suman A., Peca M., Greyl L., Greco L., Carsetti P., Il “Paradigma del Cittadino Sentinella” per favorire una transizione urbana. Cosa ci insegna il monitoraggio civico ambientale a Roma. Rivista Quadrimestrale di Diritto dell’Ambiente Numero 1- 2023, 2023.
Negazionismo climatico
A cura di Lorenzo Fargnoli ― giornalista freelance
Il complottismo ambientale, un fenomeno culturale e sociale, si manifesta attraverso la diffusione e l’adesione a teorie del complotto riguardanti questioni legate all’ambiente, alla conservazione della natura e ai cambiamenti climatici. Queste teorie sostengono l’esistenza di manipolazioni orchestrate da poteri occulti o gruppi di interesse dietro eventi o fenomeni ambientali, agendo per ragioni politiche, economiche o di controllo sociale. Tale fenomeno assume molteplici forme, ma si può distinguere principalmente in due grandi filoni:
Il primo filone suggerisce che ogni fenomeno climatico né abbia basi naturali né a sia dovuto a una conseguenza dell’antropizzazione umana. Questo approccio sostiene che dietro tali eventi vi sia la volontà di un’élite occulta, che utilizzando tecnologie tenute nascoste, controlli e crei disastri ambientali per il proprio tornaconto. Fra quelle che hanno avuto più successo nel mondo complottista troviamo le scie chimiche, dove si afferma che sostanze chimiche vengano rilasciate da aerei governativi o di altre organizzazioni segrete con lo scopo di modificare il clima, manipolare la mente umana, diffondere malattie o controllare la popolazione. Alcuni sostenitori della teoria credono che queste scie siano parte di un piano per la geoingegneria, ovvero la manipolazione intenzionale del clima terrestre per mitigare i cambiamenti climatici, mentre altri credono che siano utilizzate per scopi più sinistri e nefasti. La seconda, per ordine di importanza, è la teoria complottista del programma HAARP (High-Frequency Active Auroral Research Program), la quale suggerisce che questo progetto di ricerca, gestito dall’U.S. Air Force, la Marina degli Stati Uniti e l’Università dell’Alaska, sia in realtà un’arma segreta per il controllo del clima e la manipolazione delle onde cerebrali umane. Secondo questa teoria, il programma HAARP utilizza un campo di antenne a radiofrequenza ad alta potenza per inviare segnali nella ionosfera, la parte superiore dell’atmosfera terrestre. Tra le affermazioni più diffuse associate alla teoria del complotto HAARP ci sono:
Controllo del clima: Si sostiene che HAARP possa alterare il clima manipolando i modelli di nuvole e causando fenomeni meteorologici estremi come uragani, tempeste o siccità. Questa manipolazione del clima sarebbe utilizzata per fini militari o geopolitici, come ad esempio indebolire nemici o influenzare le condizioni climatiche su scala globale, e modifiche geofisiche: Alcuni teorici del complotto credono che HAARP possa causare terremoti o altre catastrofi geofisiche attraverso la manipolazione delle onde elettromagnetiche nella ionosfera, anche se non ci sono prove scientifiche a supporto di tali affermazioni.
Il secondo filone è rappresentato dal negazionismo climatico, che va oltre la semplice negazione delle evidenze scientifiche del riscaldamento globale. Questo approccio mina la fiducia nella ricerca scientifica e nelle tecnologie rinnovabili, che rappresentano soluzioni concrete e mature per affrontare la crisi climatica. Per coloro che aderiscono a questa visione, la transizione verso una produzione più sostenibile viene interpretata come un complotto esterno o interno per colpire la ricchezza di un paese, minandone il progresso attraverso finti e allarmistici catastrofismi escatologici.
Spesso finanziato e concepito da grandi gruppi finanziari e industriali ideologicamente affini ad una cultura politica conservatrice, il complottismo ambientale utilizza la cosiddetta «strategia del tabacco» come mezzo di diffusione. Questa strategia, che può essere descritta come un’operazione volta a distorcere la percezione pubblica sui danni ambientali, è analoga alle tattiche utilizzate per negare i danni per la salute causati dal fumo di tabacco fin dagli anni ’40. Essa sfrutta la disinformazione, il lobbying e la manipolazione dell’opinione pubblica per proteggere gli interessi dell’industria a discapito dell’ambiente e della salute globale. Un esempio di strategia utilizzata nel complottismo ambientale consiste nell’impiegare una fonte non qualificata o non competente come fonte attendibile. Un caso emblematico è rappresentato dalla diffusione di una lettera firmata da 1200 individui (Dichiarazione mondiale sul clima WCD) che negano l’esistenza del cambiamento climatico. Tuttavia, un’analisi più approfondita rivela che la maggior parte di coloro che hanno firmato la lettera non possiede competenze specifiche in climatologia o discipline correlate. Questo è un esempio del tentativo di minare la credibilità della scienza climatologica, utilizzando fonti di informazione non autoritarie o competenti nel campo, sfruttando l’illusione di una vasta base di supporto.
Per approfondire:
- Levantesi S., I bugiardi del clima – Potere, politica, psicologia di chi nega la crisi del secolo, Ed. La Terza, 2021.
- Mengarelli J., I negazionisti climatici cambiano tattica, ma sono sempre loro. Scienza in rete, 2024.
Neocolonialismo
A cura di Rahma Nur – scrittrice e insegnante
Termine con cui viene indicato polemicamente l’atteggiamento di alcune potenze ex coloniali (in partic. Belgio, Francia e Gran Bretagna) accusate di voler mantenere, nel momento stesso in cui formalmente concedevano o riconoscevano l’indipendenza politica ai territorî già soggetti, il controllo dell’economia locale per tutelare i già esistenti propri interessi e poterli estendere in altre forme. Per estensione ogni forma di politica attraverso la quale paesi capitalistici e industrializzati tendono a imporre la propria determinante influenza nella vita economica e politica delle ex colonie e in genere dei paesi in via di sviluppo, per assoggettarli a un nuovo tipo di sfruttamento. Il primo ad aver analizzato il Neocolonialismo è stato Sukarno, il primo ministro indonesiano nel 1955 alla conferenza di Bandung. In seguito, è stato ripreso da Nkrumah, primo presidente ghanese alla Terza conferenza dei popoli panafricani nel 1961. Secondo lui il Neocolonialismo condizionava l’economia e la politica dei paesi africani, e, in alcuni casi, il potere è passato dai colonizzatori, alle classi dominanti, creando così un colonialismo interno. Con neocolonialismo si intende un rapporto di scambio ineguale, con il quale gli stati indipendenti favoriscono l’esportazione delle loro merci invece di proteggere il mercato interno cosicché i paesi occidentali vengono avvantaggiati. Quindi, questo concetto, sembra modellare non solo le culture individuali, ma anche quella globale, nonché le economie dei paesi che subiscono una sottomissione capitalistica: pensiamo anche alle istituzioni finanziarie mondiali che con i loro prestiti attuano un neocolonialismo fatto di debiti che non sempre possono essere ripagati dai paesi in via di sviluppo.
Per approfondire:
- Haplerin S., Neocolonialism, Voce enciclopedica, Britannica Encyclopaedia.
- Conferenza di Bandung, Dizionario di Storia, Treccani, 2010.
NIMBY – Not In My Back Yard
a cura di A Sud
Il termine NIMBY, acronimo di Not In My Back Yard, è utilizzato in chiave dispregiativa per definire l’atteggiamento di opposizione da parte delle comunità locali a progetti di sviluppo o infrastrutture sul loro territorio. Questo acronimo viene utilizzato per suggerire che l’opposizione è motivata esclusivamente dalla vicinanza delle installazioni alle proprie abitazioni. L’utilizzo del termine è spesso mosso dalla volontà di delegittimare i fenomeni di attivazione popolare tacciandoli di campanilismo ed egoismo. In verità, in gran parte dei conflitti ambientali (si veda voce di glossario dedicata) le comunità locali sviluppano una lettura critica dei progetti che si tenta di imporre indipendentemente dalla loro ubicazione. Ne sono esempio i movimenti di opposizione a discariche e inceneritori (che rimandano alla corretta gerarchia di gestione dei rifiuti) o progetti estrattivi di fonti energetiche fossili (incompatibili con l’azione climatica); opposizioni che dunque vanno ben oltre l’ubicazione dei progetti invisi.
Oltre al termine NIMBY esistono altri acronimi che riflettono vari gradi di opposizione locale a progetti di sviluppo che sono percepiti come dannosi o indesiderabili, utilizzati per descrivere i diversi livelli di resistenza da parte delle comunità interessate, tra essi LULU, BANANA e NOPE.
- LULU (Locally Unwanted Land Use) descrive un tipo di utilizzo del territorio considerato indesiderabile da una comunità locale, spesso a causa di impatti negativi dal punto di vista ambientale e socio-economico.
- BANANA (Build Absolutely Nothing Anywhere Near Anyone) si riferisce all’opposizione degli attori locali a qualsiasi tipo di progetto sviluppo o cambiamento, indipendentemente dalla sua natura o ubicazione. Questo atteggiamento riflette una resistenza generalizzata a progetti impattanti vicino a qualsiasi comunità.
- NOPE (Not On Planet Earth) è una formula che rappresenta una resistenza senza eccezioni a qualsiasi cambiamento percepito come negativo per l’ambiente o la qualità della vita, ad esempio l’opposizione a progetti di sviluppo energetico come impianti di estrazione di combustibili fossili o grandi centrali elettriche, indipendentemente dalla loro ubicazione.
Sono tutti termini che riflettono vari gradi di opposizione locale a progetti di sviluppo che sono percepiti come dannosi o indesiderabili, e sono utilizzati per descrivere i diversi livelli di resistenza da parte delle comunità interessate.
Per approfondire:
- Spina F., Sociologia dei Nimby. I conflitti di localizzazione tra movimenti e istituzioni, Besa, Lecce, 2009.
- Hager C, Haddad M.A., Nimby is beautiful, Cases of Local Activism and Environmental Innovation around the World, Berghan books 2015.
- Charles D., NIMBYs and the Necessity of Community Involvement in Land Use Decision Making, in Environmental Law, Vol. 25, No. 3, 1995.
NOPE – Not On Planet Earth
Si rimanda a voce del glossario “NIMBY – Not In My Back Yard”
Obsolescenza programmata
A cura di Vittoria Moccagatta ― giornalista, EconomiaCircolare.com
L’obsolescenza programmata consiste nel precoce declassamento della merce attraverso l’introduzione intenzionale di difetti che fanno precipitare le sue prestazioni e rendono indispensabile una sostituzione prematura. Facendo sistema con la necessità di mantenere l’economia in uno stato di crescita, l’obsolescenza programmata accelera il normale decorso dei prodotti assottigliando il confine che divide vecchio e nuovo, logoro e funzionante, scarto e merce, sicché non si fa in tempo a comprare un prodotto che questo presenta presto malfunzionamenti e dunque va scartato e comprato nuovamente. Nello stadio più avanzato, l’obsolescenza programmata prende il nome di “obsolescenza psicologica” perché capace di degradare non tanto la funzionalità dei prodotti, ma la psicologia di chi li acquista: grazie all’avvento delle nuove mode, ciò che viene reso obsoleto è ora anche ciò che risulta intonso e ancora utilizzabile, ma che non brilla, all’interno delle vetrine, come fa la sua versione 2.0 o che non viene acclamato dalle voci pubblicitarie come avviene per la sua controparte à la page.
Per approfondire:
- Anders G., L’uomo è antiquato, Bollati Boringhieri, 2007.
- Baudrillard J., Il sogno della merce. Antologia di scritti sulla pubblicità, Lupetti, 2011.
- Latouche S., Decolonizzare l’immaginario. Il pensiero creativo contro l’economia dell’assurdo, Editrice Missionaria Italiana, 2004.L
- Latouche S., Usa e getta. Le follie dell’obsolescenza programmata, Bollati Boringhieri, 2015.
Open Science
A cura di Cristina Mangia ― ricercatrice CNR
La scienza aperta o “open science” è un insieme di principi e pratiche che mirano a rendere la ricerca scientifica più accessibile, trasparente e collaborativa, a beneficio sia delle comunità scientifiche sia della società nel suo complesso. Sebbene gli ideali propugnati dalla scienza fin dalla sua nascita siano stati il comunitarismo, l’universalismo, l’assenza di interessi personali e lo scetticismo organizzato, nella pratica sono spesso prevalse azioni di “chiusura”, a partire da quella più eclatante nei confronti delle donne. Alcuni esempi di “scienza chiusa” sono: le pubblicazioni su riviste a pagamento a cui non tutti possono accedere; i finanziamenti poco trasparenti che indirizzano ricerche a vantaggio di alcuni gruppi di interesse, come nel caso degli studi ambigui sugli effetti del fumo sulla salute finanziati dall’industria del tabacco; la poca chiarezza nel mondo dell’intelligenza artificiale dove nell’addestramento delle reti non sono noti né i database utilizzati né gli algoritmi di elaborazione dei dati; l’inaccessabilità a dati e informazioni, da parte di comunità locali, su studi ambientali e sanitari che le riguardano direttamente, il non riconoscimento di altre forme di conoscenza come quelle locali o indigene. L’idea alla base del movimento della scienza aperta è quella, invece, di una conoscenza come bene comune per tutta l’umanità che oggi si trova ad affrontare crisi socio/ecologiche insostenibili in un intreccio sempre più stretto tra economia, politica e scienza. La scienza aperta ha radici profonde nella storia della scienza, ma il suo sviluppo come movimento organizzato è avvenuto principalmente negli ultimi decenni grazie a due fenomeni. Il primo è l’aumentata consapevolezza di un mondo complesso ed interconnesso. Il secondo è la rivoluzione digitale che ha cambiato radicalmente la pratica scientifica con la possibilità di archiviare, condividere e analizzare grandi quantità di dati.
I processi di “apertura della scienza” investono diversi piani: quello all’interno delle comunità scientifiche e quello nella relazione con altri sistemi di conoscenza e la società in generale. Sebbene i piani si intersechino, le finalità, l’applicabilità, le pratiche restano differenti e non necessariamente la trasparenza e la condivisione a livello di mondo accademico si traducono in una condizione di accessibilità e inclusione a livello di pubblico più ampio.
Per approfondire:
- Biggieri F., Gli epidemiologi e la scienza degli altri, Epidemiologia e Prevenzione, 2014.
- European environment agency, The case for public participation in sustainability transitions, 2023.
- MANGIA C. (a cura di), Scienza, politica e società: l’approccio post-normale in teoria e nelle pratiche, CNR Edizioni, 2021.
- UNESCO, Recommendation on Open Science, 2021.
Outdoor Education
A cura di Jessica Ferretti ― educatrice e formatrice, A Sud
La traduzione letterale di Outdoor Education è “educazione fuori”, questa espressione si riferisce a una pratica educativa basata sull’apprendimento esperienziale in un ambiente esterno. Più corretto riportare la riflessione di Christian Bisson, ricercatore statunitense, che nel 1996 ha definito l’Outdoor Education come un termine ombrello, ovvero un concetto che intende raggruppare diverse pratiche educative accomunate dalla valorizzazione di esperienze vissuta all’aperto, fuori da uno spazio chiuso. Negli ultimi 3 decenni l’Outdoor Education è diventata la risposta ad un fenomeno sociale ed educativo conosciuto come iperprotezione dell’infanzia ( si parla di Bubble Wrap Generation), limitando il gioco, la socialità e il movimento al di fuori degli spazi chiusi, e questo significa anche non offrire l’opportunità di vivere esplorazioni e avventure nell’ambiente esterno. L’Outdoor Education valorizza l’esperienza del rischio, come condizione di crescita e di autoconoscenza e riconosce l’importanza di un spazio all’aperto non strutturato, dove non ci sono oggetti con un uso definito e finalizzato, e imprevedibile, ovvero non controllabile come le variazioni delle condizioni atmosferiche. “L’Outdoor Education diventa significativa se la persona adulta scopre (ha scoperto) il valore e il benessere del proprio stare in ambiente, vivendo in prima persona un luogo attraverso le esperienze sensibili che esso sollecita, la curiosità di esplorare, osservare, interrogarsi.” La figura educatrice si trasforma in quella di accompagnatrice dell’esperienza, facilitatrice dell’apprendimento. La relazione diretta con lo spazio all’aperto consente lo sviluppo di competenze non per materie separate, bensì il soggetto apprende a costruire percorsi di conoscenza interdisciplinari. Per ambiente esterno si intendono contesti naturali, rurali e urbani (sia aree verdi urbane che piazze e strade). Il giornalista ed educatore statunitense Richard Louv nel 2005 ha coniato l’espressione deficit di natura per riferirsi a quei danni nello sviluppo psico-fisico di coloro che hanno vissuto un’infanzia senza o con ridotto contatto con la natura. Ricerche scientifiche sull’Outdoor Education dimostrano che il contatto con ambienti naturali rigenera l’attenzione e riduce lo stress, effetti positivi che si riflettono nelle dimensioni affettivo-emotiva, relazionale, cognitiva e fisica dell’individuo. L’Outdoor education esalta la relazione con l’ambiente esterno e ciò non significa entrare in contraddizione con gli spazi chiusi, bensì invita a vedere connessioni in maniera propositiva tra fuori e dentro.
Per appronfondire:
- Farnè A., Bortolotti, Terrusi M., Outdoor Education: prospettive teoriche e buone pratiche, Carocci editore, 2018.
Patti Educativi di Comunità
a cura di Nicole Marcellini – educatrice e formatrice A Sud
I patti educativi di comunità sono uno strumento per costruire alleanze territoriali tra scuola, amministrazione pubblica e terzo settore in grado di trasformare le istituzioni scolastiche e le comunità educanti (si veda lemma dedicato) in agenti di conoscenza e rinnovamento che si aprono al territorio attivando processi di co-progettazione del cambiamento.
Alleanze tra scuola e comunità educante sono largamente diffuse da diverso tempo mentre i patti educativi di comunità sono stati introdotti nel Piano Scuola 2020/21 sulla scia dell’emergenza pandemica e con la necessità di reperire spazi alternativi a quelli scolastici dove svolgere la didattica. Ben presto è emerso con chiarezza il potenziale trasformativo di questo strumento in cui le istituzioni scolastiche diventano protagoniste insieme al resto della comunità di un processo di co-progettazione del cambiamento che ha diversi obiettivi: lotta alla dispersione scolastica, contrasto alla povertà educativa, consolidamento dell’identità del territorio, sperimentazione di forme alternative di didattica, rigenerazione dei saperi e degli spazi. Il potenziale trasformativo dei patti educativi territoriali è particolarmente importante nei territori a rischio esclusione e marginalità.
I patti educativi di comunità sono in grado di favorire l’accesso alle opportunità offerte dal territorio facendosi promotori di iniziative sociali e culturali. La cittadinanza non si limita a partecipare ma può recuperare un ruolo centrale nei processi di cambiamento sociale.
Il territorio si trasforma divenendo spazio educativo condiviso, dove l’educazione può, uscendo dalle mura scolastiche, recuperare la sua dimensione collettiva. Il territorio attraversato dal mondo della scuola e dall’agire dei più giovani è così investito da una grande possibilità di cambiamento restituendo la sensazione di poter compiere azioni efficaci per il raggiungimento di un obiettivo e la capacità di percepire l’influenza delle proprie azioni sugli eventi.
I patti educativi di comunità rappresentano uno strumento centrale per lavorare sulla multifattorialità della povertà educativa che è connessa alla povertà energetica, alla vulnerabilità ambientale dei territori e delle persone che li abitano, alla salute e al diritto al lavoro.
Le conseguenze dell’emergenza ambientale e climatica sul mondo dell’infanzia e dei giovani sono diverse: problemi di salute, ritardi e/o disturbi dell’apprendimento, fragilità dei territori, sicurezza degli edifici scolastici, accessibilità al verde, nuove povertà. Attraverso i patti educativi di comunità la scuola può divenire presidio culturale e sociale ma anche ecologista, in grado di realizzare e diffondere nuove pratiche, nuovi stili di vita, nuovi modelli esistenziali, abitativi, di consumo e di mobilità che sappiano rispondere alle sfide poste dalla realtà. Sono molteplici le azioni che concretamente si possono implementare. Ad esempio: ridurre l’impatto degli edifici scolastici; mettere le scuole al centro di comunità energetiche e altre soluzioni innovative; introdurre aree pedonalizzate per una mobilità sostenibile; recuperare spazi verdi abbandonati; promuovere progetti di rigenerazione urbana e territoriale in grado di fermare il consumo di suolo e stimolare processi di riforestazione urbana e di risanamento ambientale, praticare Scienza Aperta e monitoraggi civici partecipati, dialogando con il mondo della ricerca per sostenere forme di attivazione dal basso su vertenze ambientali sul territorio.
Con i patti educativi di comunità non ci si vuole sostituire al pubblico ma proporre sistemi solidaristici e cooperativi dal basso, necessari alla costruzione di un futuro più giusto per tutte e tutti, sia da un punto di vista sociale che ambientale.
Per approfondire:
- Forum Diseguaglianze e Diversità “Patti educativi territoriali e percorsi abilitanti. RAPPORTO DI RICERCA Un’indagine esplorativa , 2021
Post-estrattivismo
a cura di A Sud
Il post-estrattivismo è un paradigma economico e sociale che si propone come alternativa all’estrattivismo (vedi voce di glossario dedicata), concentrandosi sulla riduzione della dipendenza dalle attività estrattive e sull’adozione di modelli di sviluppo sostenibili ed equi. Questo approccio cerca di superare le problematiche legate all’estrazione intensiva di risorse naturali, promuovendo una gestione equa e rispettosa dell’ambiente e delle comunità locali.
Il post-estrattivismo si basa su diversi principi chiave:
- Diversificazione Economica: Ridurre la dipendenza economica dalle esportazioni di risorse naturali attraverso la promozione di altri settori produttivi, come l’agricoltura sostenibile, il turismo ecologico, l’industria manifatturiera e i servizi.
- Sostenibilità Ambientale: Adottare pratiche che minimizzino l’impatto ambientale e preservino gli ecosistemi, promuovendo l’uso responsabile delle risorse naturali e il ripristino dei territori danneggiati dalle attività estrattive.
- Giustizia Sociale: Garantire che i benefici economici derivanti dallo sfruttamento delle risorse naturali siano equamente distribuiti, migliorando le condizioni di vita delle comunità locali e rispettando i loro diritti.
- Partecipazione Comunitaria: Coinvolgere attivamente le comunità locali nei processi decisionali riguardanti l’uso delle risorse naturali, assicurando che le loro voci e preoccupazioni siano ascoltate e rispettate.
- Sovranità Alimentare ed Energetica: Promuovere l’autosufficienza e la resilienza delle comunità attraverso la produzione locale di cibo e energia, riducendo la dipendenza dalle importazioni.
Il post-estrattivismo non è solo una critica al modello estrattivista, ma anche una proposta concreta per la costruzione di modelli economici sostenibili e inclusivi. Esso implica un cambiamento radicale nei modelli di produzione e consumo, nonché nelle politiche economiche e sociali, mettendo al centro il benessere umano e la tutela dell’ambiente. Questo paradigma si è affermato in varie parti del mondo, specialmente in America Latina, dove movimenti sociali e organizzazioni non governative stanno cercando di implementare politiche post-estrattiviste.
Per approfondire:
- Houtart F.J., From Extractivism to a Post-Extractivist Economy, 2012.
- Acosta A., Post-Extractivism: From Discourse to Practice—Reflections for Action, Open Edition 2017.
- Honty G., Post-extractivist proposals in Latin America, 2014.
Povertà educativa
A cura di Andrea Morniroli ― co-coordinatore del Forum Disuguaglianze Diversità
Uno dei problemi più gravi della scuola continua a essere il numero troppo grande di ragazze e ragazzi che perde. Nonostante l’impegno personale di tanti/e maestri e maestre, insegnanti, educatori, la scuola da un lato molte volte non riesce ad accogliere chi fa più fatica, d’altro lato, soprattutto nei territori più deboli e marginali, sembra non riuscire a rompere quella sorta di profezia che si auto-avvera che porta molte ragazze e molti ragazzi a non immaginarsi in un ruolo diverso da quello al quale il proprio destino sociale sembra averli inchiodati. Perché la povertà educativa , come la dispersione scolastica e il fallimento formativo, sono fenomeni che sono prodotti da una molteplicità di fattori e che spesso si legano in modo stretto alla povertà materiale. E sappiamo, ancora, che è proprio tale intreccio di determinanti economiche, culturali e sociali che incide in negativo e in modo permanente sui percorsi di studio e di vita di molti/e giovani del nostro paese, soprattutto nei territori in cui maggiori è il peso delle disuguaglianze geografiche, sociali e di opportunità.
Si tratta non solo di non aver accesso alle competenze chiave per l’apprendimento, per trovare lavoro, per l’esercizio della cittadinanza, ma di una deprivazione che investe la persona nella sua interezza, mettendo a repentaglio la fiducia in se stessi e di conseguenza la stessa capacità di immaginare e aspirare a un futuro diverso.
In Italia, la povertà materiale coem quella educativa stanno aumentando. L’ultima rilevazione Istat del 2021 ci dice che i minori in condizione di povertà assoluta sono circa un milione e duecentomila, quattro volte di più del 2008. Sempre secondo tale fonte quelli in povertà relativa (bambine e bambini, ragazze e ragazzi, che anche se hanno possibilità di accesso ai servizi essenziali non possono comunque soddisfare il livello medio di benessere del paese) sono 2.300.000. Per quel che attiene i dati di quella educativa il dato ci dice che la media nazionale di dispersione implicita e esplicita si attesta intorno al 12% ma tale media si attesta tra il 16 e il 22% nelle regioni del Sud. Pesano inoltre le disuguaglianze di genere e quelle di “classe” perché a 50anni da Don Milani sono ancora le figlie e i figli dei poveri a comporre la stragrande maggioranza delle alunne e alunni che fanno più fatica, abbandonano, non raggiungono i risultati sperati.
Uno strumento di contrasto alla Povertà educativa è sicuramente l’acquisizione di competenze da parte dei ragazzi/e di nuove tecnologie e metodologie d’indagine, che li vedono protagonisti in prima persona del processo di rigenerazione sociale e ambientale: video partecipativi che aiutino i minori stessi a raccontare il loro contesto di vita, laboratori di conoscenza del territorio utili a rafforzare competenze STEM, con lo scopo di costruire mappature territoriali, promozione di mappe di comunità e tanto altro.
Per approfondire:
- ISTAT 2023, Stime preliminari poverta’ assoluta e spese per consumi, 2023.
Preparedness (preparazione ai disastri)
A cura di Sara Vegni – Advocacy Officer, A Sud
La disaster preparedness (preparazione ai disastri) coinvolge un insieme di misure e strategie progettate per ridurre al minimo l’impatto di disastri, proteggere vite umane e beni e garantire una rapida ripresa post-evento. Queste misure includono la pianificazione, l’educazione, la formazione, e lo sviluppo di capacità operative e infrastrutturali. La preparedness si inserisce nel ciclo di gestione del rischio come uno dei suoi elementi chiave. Questo ciclo comprende diverse fasi interconnesse: prevenzione, mitigazione, preparedness, risposta, recupero e adattamento. La preparedness rappresenta un tassello cruciale che si trova in continuità con le fasi di prevenzione e mitigazione. Mentre la prevenzione si concentra sull’eliminazione o riduzione delle minacce e la mitigazione cerca di ridurre l’impatto dei disastri, la preparedness si occupa di garantire che individui e comunità siano pronti ad affrontare eventuali emergenze.
L’ONU, attraverso l’Ufficio per la Riduzione del Rischio di Disastri (UNDRR), ha sviluppato il Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030, un accordo globale che mira a ridurre i rischi e le perdite causate dai disastri. Il Sendai Framework enfatizza l’importanza di comprendere il rischio di disastro, rafforzare la governance del rischio di disastro, investire nella riduzione del rischio per la resilienza, e migliorare la preparazione per rispondere efficacemente ai disastri.
Diverse organizzazioni della società civile sono attivamente coinvolte nel rafforzamento delle capacità delle comunità locali per affrontare i disastri. Queste organizzazioni promuovono la community-based resilience (resilienza basata sulla comunità), che si concentra sull’empowerment delle comunità per gestire i rischi e che coinvolge la partecipazione attiva delle persone nella pianificazione e nell’implementazione di strategie di preparedness, assicurando che le soluzioni siano adatte alle specificità locali. Le istituzioni internazionali e le ONG stanno adattando le loro strategie di preparedness per tenere conto degli impatti della crisi climatica. La combinazione di preparedness e adattamento ai cambiamenti climatici è essenziale per ridurre le vulnerabilità e migliorare la resilienza delle comunità globali.
In Italia, la Protezione Civile ha il compito di attuare misure e politiche di previsione, prevenzione, mitigazione dei rischi e superamento dell’emergenza così come definito dalla legge n. 225 del 1992, istitutiva del Servizio Nazionale di Protezione civile e richiamate dall’art. 2 del Codice della Protezione Civile del 2018. Il Sistema si configura come una funzione che mette in rete strutture pubbliche e private, centrali e territoriali. Questa rete di competenze trova il suo punto di raccordo nelle funzioni di indirizzo e coordinamento affidate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che le esercita avvalendosi del Dipartimento di Protezione Civile. La “capacità”, così come definita dalla Protezione Civile Italiana, si riferisce alla combinazione di risorse, competenze, strutture e procedure necessarie per gestire efficacemente le emergenze.
Uno dei principali strumenti per rafforzare la capacità sulla reazione ai disastri è identificata nella pianificazione di protezione civile, attività di prevenzione volta alla predisposizione del Piano di Protezione Civile dove sono indicate le attività di previsione e identificati i possibili scenari di rischio presenti nel territorio, le strategie operative e i modelli di intervento per ogni rischio considerato e individuate le strutture operative e le risorse a disposizione per fronteggiare i possibili eventi. Come stabilito dal d. lgs. n. 1/2018 che ha ampiamente riformato il quadro normativo in materia di protezione civile, l’attività di pianificazione a livello comunale nell’ambito del Servizio nazionale di protezione civile è definita come funzione fondamentale dei Comuni.
Un aspetto innovativo della pianificazione in Italia è la pianificazione partecipata, promossa dall’articolo 18 del nuovo codice di protezione civile. Questo approccio prevede il coinvolgimento attivo dei cittadini nella stesura dei piani di emergenza, garantendo che le soluzioni proposte siano condivise e sostenute dalla comunità. Nonostante ciò, la reale implementazione della pianificazione partecipata varia significativamente tra le diverse regioni e comuni, con alcune aree che mostrano un maggiore impegno rispetto ad altre.
Per approfondire:
- UNDRRR – Ufficio per la Riduzione del Rischio di Disastri, Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030, 2019.
Principio delle responsabilità comuni ma differenziate
a cura di Marica Di Pierri – giornalista e ricercatrice, A Sud
Il principio delle responsabilità comuni ma differenziate è uno dei pilastri del diritto internazionale ambientale. Oltre che in numerose fonti normative internazionali è codificato, tra l’altro, nel principio numero 7 della dichiarazione su Ambiente e Sviluppo di Rio, formulata durante la Conferenza delle Nazioni Unite sull’ambiente tenutasi nel 1992 a Rio de Janeiro: “In considerazione del differente contributo al degrado ambientale globale, gli Stati hanno responsabilità comuni ma differenziate. I paesi sviluppati riconoscono la responsabilità che incombe loro nel perseguimento internazionale dello sviluppo sostenibile date le pressioni che le loro società esercitano sull’ambiente globale e le tecnologie e risorse finanziarie di cui dispongono”.
Assieme al principio di equità e di rispettive capacità, il principio di responsabilità comuni ma differenziate costituisce principio cardine del diritto climatico: assieme si traducono nella previsione di impegni differenziati in capo a ciascun paese, in considerazione tanto delle responsabilità storiche che delle capacità tecnologiche e finanziarie attuali. Il riferimento in tal senso è l’articolo 3 dell’UNFCCC (per approfondire si veda la voce di glossario dedicata), dedicata ai principi, che al comma 1 prescrive:
“Le parti devono proteggere il sistema climatico, a beneficio della presente e delle future generazioni, su una base di equità e in rapporto alle loro comuni ma differenziate responsabilità e alle rispettive capacità. Pertanto i paesi sviluppati che sono parti alla convenzione, devono prendere l’iniziativa nella lotta contro i cambiamenti climatici e i relativi effetti negativi”.
Per approfondire:
- UNCED, Dichiarazione di Rio sull’ambiente e lo sviluppo, 1992. (Testo in italiano).
- UNFCCC, Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici, 1992. (Testo in italiano).
RAEE – Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche
A cura di Giorgio Arienti ― Direttore Generale di Erion WEEE
I RAEE sono i Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche: tutti i dispositivi il cui funzionamento dipende dall’energia elettrica, grandi o piccoli che siano (frigoriferi, lavatrici, TV, computer, telefoni cellulari, caricabatterie, aspirapolvere, radiosveglie, spazzolini elettrici, smartwatch …), quando giungono alla fine della loro vita utile diventano RAEE: si stima che ogni cittadino italiano generi ogni anno circa 15 kg di RAEE.
I RAEE sono allo stesso tempo un problema e un’opportunità. Sono un problema, perché contengono sostanze inquinanti – come metalli pesanti (mercurio, piombo, cadmio) o gas ozono-lesivi (CFC, HCFC) – che devono essere rimosse e smaltite in modo sicuro, mediante l’utilizzo di appositi impianti di trattamento. Ma rappresentano anche un’opportunità, perché sono costituiti da materie prime che possono essere riciclate, cioè reinserite nei cicli produttivi: ferro, rame, alluminio, plastica, nonché molte di quelle “materie prime critiche” (come litio, cobalto, tantalio, palladio, terre rare) che sono indispensabili per molti dei settori industriali più avanzati e che l’Italia oggi importa prevalentemente dalla Cina. Il tasso di riciclo dei RAEE è superiore al 90%: da 1.000 kg di Rifiuti Elettrici ed Elettronici si ottengono oltre 900 kg di Materie Prime Seconde; perciò i RAEE sono un concreto esempio di Economia Circolare. Affinché i RAEE possano essere sottoposti a un corretto processo di trattamento, questi rifiuti non devono essere gettati nella spazzatura indifferenziata né consegnati a soggetti diversi da quelli incaricati della loro raccolta, che sono solo gli Enti Locali e i Negozianti che vendono Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche.
Gli Enti Locali devono allestire le isole ecologiche (chiamate anche centri di raccolta o riciclerie), nelle quali i cittadini possono conferire i propri rifiuti, tra cui anche i RAEE: nelle isole ecologiche i RAEE sono suddivisi in cinque Raggruppamenti (per facilitare le successive operazioni di trattamento):
- R1: frigoriferi, congelatori, condizionatori, asciugatrici a pompa di calore;
- R2: lavatrici, lavastoviglie, forni e altri grandi elettrodomestici;
- R3: TV e monitor
- R4: piccoli elettrodomestici, PC, telefoni cellulari, elettronica di consumo;
- R5: sorgenti luminose.
Gli Enti Locali inoltre devono istituire sistemi di raccolta domiciliare dei RAEE più ingombranti (frigoriferi, lavatrici, TV …).
I Negozianti devono invece garantire ai propri Clienti due servizi gratuiti di ritiro dei RAEE:
- il ritiro “uno contro uno”, cioè il ritiro del RAEE quando il Cliente acquista un’Apparecchiatura equivalente; questo ritiro gratuito deve avvenire nel luogo in cui è effettuata la consegna della nuova Apparecchiatura, riguarda qualunque tipologia di RAEE ed è obbligatorio per tutti i Negozianti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (anche per quelli che effettuano vendite on-line);
- il ritiro “uno contro zero”, cioè il ritiro del RAEE anche quando il Cliente non compra una nuova Apparecchiatura; questo ritiro gratuito deve avvenire in negozio, riguarda solo i “piccoli RAEE” (cioè RAEE la cui dimensione massima è inferiore a 25 cm) ed è obbligatorio solo per i “grandi negozi” (cioè negozi in cui la superfice di vendita dedicata alle Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche è superiore a 400 mq).
I Negozianti che non rispettano tali obblighi di ritiro possono essere sanzionati, sulla base di quanto disposto dal D.Lgs. 49/2014.
Per approfondire:
RAEE, Perché e importante smaltirli, Erion Wee, webinar settembre 2022.
Laboratorio REF Ricerche, Gestione e sostenibilità dei RAEE, EconomiaCircolare.com, 2023.
Redd+ – Reduction of Emissions from Deforestation and Degradation
A cura di Carlotta Indiano ― giornalista ambientale
REDD+, acronimo di “riduzione delle emissioni di gas serra dovute alla deforestazione e al degrado forestale” (dall’ inglese reduction Reduction of Emissions from Deforestation and Forest Degradation) è un programma internazionale sviluppato dalla Convenzione dell’ONU sul clima che crea incentivi per ridurre le emissioni di CO2 causate dalla distruzione delle foreste nei Paesi del Sud del mondo. Il simbolo “+” indica le attività addizionali legate alle foreste che proteggono il clima, in particolare la gestione sostenibile delle foreste, la conservazione e il miglioramento degli stock di carbonio nelle foreste. L’obiettivo del progetto è incoraggiare la gestione sostenibile delle foreste nei Paesi del Sud del mondo. Le azioni REDD+ possono anche essere collegate alle opportunità di finanziamento dei mercati dei crediti di carbonio inquadrate dall’Articolo 6 dell’Accordo di Parigi. Nell’ambito delle attività REDD+, definite “soluzioni basate sulla natura”, i Paesi del Sud del mondo possono ricevere finanziamenti in base ai risultati di riduzione e compensazione delle emissioni ma l’attività presenta numerosi rischi nei paesi in cui viene sviluppata.
Per approfondire:
- FAO, Food and Agriculture Organization of the United Nation, The State of World Forest 2022, 2023.
- Morita, K., Matsumoto, K. Challenges and lessons learned for REDD+ finance and its governance. Carbon Balance Manage, 2023.
Reverse logistic
A cura di Silvia Santucci ― giornalista ambientale, EconomiaCircolare.com
Con la definizione reverse logistic, traducibile in italiano con l’espressione logistica di ritorno o logistica inversa, si intende il processo opposto a quello della catena di distribuzione, in cui i consumatori rendono i prodotti ricevuti al produttore o al rivenditore attraverso lo stesso percorso della catena di fornitura. Il caso più comune di logistica di ritorno riguarda la gestione dei resi ma stanno registrando una crescita anche altri segmenti di mercato come il re-commerce, cioè il commercio online di beni usati e ricondizionati, e la gestione del fine vita: condizioni in cui il produttore, o chi per lui, accetta di prendere in carico il prodotto al termine del suo ciclo di vita, occupandosi della rivendita o del riciclo. Anche il noleggio online implica un’accurata gestione della logistica inversa, così come tutti quei servizi di restituzione del packaging che prevedono l’uso di imballaggi riutilizzabili che tornano al venditore. L’obiettivo è massimizzare il valore dei prodotti restituiti e ridurre al minimo i costi associati alla loro gestione e trattamento: permette di far guadagnare nuovo valore a prodotti che hanno esaurito il loro ciclo di vita.
Per approfondire:
- Data Bridge Market Research, Global Reverse Logistic Market – Industry Trends and Forecast to 2029, 2022.
Riciclo
Si rimanda alla voce del Glossario “Gerarchia dei rifiuti”
Riduzione
Si rimanda alla voce del Glossario “Gerarchia dei rifiuti”
Riuso
Si rimanda a voce del glossario “Gerarchia dei rifiuti”
SAD – Sussidi Ambientalmente Dannosi
a cura di Marica Di Pierri – giornalista e ricercatrice, A Sud
La categoria dei sussidi ambientalmente dannosi, da cui l’acronimo SAD, comprende tutte le misure di sostegno dirette (on-budget) e indirette (off- budget) che incentivano attività economiche che hanno impatto negativo sull’ambiente. Tra essi si annoverano, ad esempio: finanziamenti diretti, esenzioni, agevolazioni fiscali, detassazione. Tra i SAD particolare rilevanza ricoprono i sussidi diretti a incentivare l’utilizzo di fonti energetiche fossili, come carbone, petrolio o gas, cui è dovuta gran parte delle emissioni climalteranti rilasciate in atmosfera.
Secondo Legambiente, che monitora il flusso di finanziamenti nazionali e pubblica annualmente un report dedicato ai SAD, nel 2022 l’Italia ha speso 94,8 miliardi di euro in attività, opere e progetti connessi direttamente e indirettamente alle fonti fossili. A livello globale, secondo le stime del Fondo Monetario Internazionale, nel 2022 si è registrato un nuovo record con almeno 7mila miliardi di dollari destinati a sussidiare le fonti fossili, una spesa che equivale a più del 7% del Pil globale.
Lo stanziamento di tali cifre a favore di fonti climalteranti è in netto contrasto con la necessità di disincentivare l’utilizzo di fonti fossili e promuovere la transizione energetica verso fonti rinnovabili. Per tale ragione l’eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi è oggetto di numerose campagne di denuncia e pressione istituzionale a livello nazionale e internazionale.
Per approfondire:
- Legambiente, Stop Sussidi ambientalmente dannosi, Report 2023.
- Fondo Monetario Internazionale – FMI, Imf fossil fuel subsidies data: 2023 update, Report 2023.
- Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli (2017), Legge 28 dicembre 2015 n.221.
Sicurezza Alimentare
a cura di A Sud
Con il termine Sicurezza alimentare si fa riferimento alla necessità di garantire l’accesso a cibo e acqua sicuri e sani per tutte e tutti. Secondo la FAO, la definizione di riferimento è quella fornita nell’ambito del World Food Summit del 1996 secondo cui in una situazione di sicurezza alimentare “tutte le persone, in ogni momento, hanno accesso fisico, sociale ed economico ad alimenti sufficienti, sicuri e nutrienti che garantiscano le loro necessità e preferenze alimentari per condurre una vita attiva e sana”.
L’accesso a quantità sufficienti di cibo sicuro e nutriente è fondamentale per sostenere la vita e promuovere la salute. Gli alimenti non sicuri che contengono batteri, virus, parassiti o sostanze chimiche nocive possono essere alla base dell’insorgenza di piu di 200 diverse patologie, croniche o acute, dalla diarrea al cancro. Inoltre, crea un circolo vizioso di malattie e malnutrizione, che colpisce in particolare neonati, bambini piccoli, anziani e malati.
Ancora oggi, secondo l’ONU, ogni anno una persona su dieci nel mondo, circa 600 milioni di persone, si ammala a causa di alimenti contaminati, soprattutto nei paesi poveri e nelle comunità già vulnerabili. Il 40% delle malattie di origine alimentare colpisce bambini di età inferiore ai 5 anni, con 125.000 decessi l’anno. In totale, le malattie di origine alimentare sono responsabili di 420.000 morti evitabili ogni anno.
Il concetto di sicurezza alimentare è strettamente legato a quello di sovranità alimentare (si rimanda alla voce di glossario “Sovranità alimentare”).
Lavorare per la sicurezza alimentare vuol dire riconoscere le connessioni tra salute umana e salute del pianeta, e promuovere azioni locali basate su soluzioni eque e sostenibili. È necessaria una buona collaborazione tra governi, produttori e consumatori per contribuire a garantire la sicurezza alimentare e sistemi alimentari più forti.
Per approfondire:
- WHO – World Health Organization, Factsheet on food safety, 2024.
- FAO – Food and Agriculture Organization, FAO’s Strategy for Improving Food Safety Globally, 2014.
Simbiosi industriale
A cura di Chiara Iannacone giornalista ― Economiacircolare.com
Tra gli anni ‘30 e ‘40 si sviluppa l‘idea di simbiosi industriale a opera dei geografi Charles Langdon White e George T. Rennerche che la definiscono come un accordo di due o più industrie appartenenti alla stessa area. Con questa definizione la simbiosi può assumere una concezione disgiuntiva e congiuntiva, ovvero nel primo caso non creando interdipendenza tra le imprese, nel secondo implicando una dipendenza reciproca soprattutto sulla base di uno scambio di sottoprodotti.
All’inizio degli anni ‘90 il concetto di Simbiosi industriale viene inteso sia come relazione economica tra sistemi industriali sia come interazione tra impresa e ambiente circostante. Il concetto viene rivisto alla luce di quello di Ecologia Industriale, termine coniato dal fisico Robert Frosch nel 1992, assimilando il funzionamento degli organismi industriali a quello degli ecosistemi naturali. Con l’Ecologia industriale nasce dunque una disciplina scientifica che si interessa dei sistemi industriali, dalla progettazione dei loro flussi di produzione alla loro gestione, trasformandoli in analogia con i sistemi naturali, quindi massimizzando l‘efficienza delle risorse e minimizzando i materiali di scarto e dei prodotti a fine vita. Per ottenere questi risultati viene introdotto il concetto di ciclo chiuso, che in tempi più recenti ha portato alla nascita del modello strategico dell’Economia Circolare, basato sull‘idea di restituire valore (economico) ai residui in uscita dal processo produttivo.
Secondo una delle concettualizzazioni più recenti, la Simbiosi Industriale può essere definita come: un approccio collaborativo che prevede l‘interazione tra diversi stabilimenti industriali, più comunemente appartenenti a industrie dissimili, attraverso lo scambio fisico di materiali, energia, acqua di scarto da un’impresa, a un’altra impresa che può utilizzarli come input. A questo si aggiunge la possibilità di condividere competenze, servizi e infrastrutture
Per approfondire:
- Fraccascia L., Magno M., Albino V., Business models for industrial symbiosis: A guide for firms, Procedia Environmental Science, Engineering Management, 3, 2016.
- Beltrani T., La Monica M., La simbiosi industriale per la strategia Nazionale di Economia Circolare, ENEA, 2022.
- Simbiosi industriale: normativa ed esempi, Sito web, Circularity Start up.
SIN – Siti d’Interesse Nazionale
A cura di Alessandro Coltré – giornalista, A Sud
I Siti d’Interesse Nazionale (SIN) sono porzioni estese di territorio italiano in cui è stata accertata una contaminazione delle matrici ambientali talmente elevata da rappresentare un serio rischio sanitario per la popolazione e un danno socio-ambientale per interi comprensori. Questi luoghi che fanno i conti con gli scarti di produzione dell’industria chimica, con sversamenti di sostanze tossiche nel suolo e nelle acque di zone che hanno ospitato il miracolo industriale del nostro Paese. Le aree SIN sono individuate dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, d’intesa con le Regioni interessate, secondo i principi e i criteri direttivi definiti all’art. 252 (Siti di interesse nazionale), comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). In questa geografia della contaminazione troviamo, per esempio, Casal Monferrato e altre 47 cittadine in provincia di Alessandria dove la produzione di cemento-amianto nello stabilimento Eternit ha lasciato un’eredità tossica fatta di sostanze cancerogene presenti nelle polveri di amianto e in tanti prodotti lasciati nell’ambiente. Sono aree Sin zone come Taranto, dove c’è l’insediamento siderurgico dell’ex Ilva e il petrolchimico Eni, città come Brescia, alle prese con gli scarti industriali dell’azienda Caffaro, responsabile di aver rilasciato sostanze tossiche nelle falde idriche del territorio. In Italia ci sono 42 siti da bonificare per una superfice di circa 170 mila ettari a terra e 78 mila ettari di mare. Attraverso degli specifici decreti del Ministero dell’ambiente vengono stabilite le procedure di perimetrazione, di monitoraggio e di bonifica dei Sin.
Le operazioni di bonifica vengono definite con accordi di programma, in sinergia con le istituzioni regionali, coinvolgendo le amministrazioni locali e le imprese private scelte per seguire i lavori. A sostenere le bonifiche dovrebbero essere i proprietari delle aziende che hanno inquinato, ma molti gruppi industriali della contaminazione ambientale non esistono più. Le risorse per mettere in sicurezza e per bonificare questi territori arrivano dal ministero e da programmazioni europee. Nei Sin è attivo uno specifico programma di monitoraggio della popolazione. Si tratta di un piano di sorveglianza epidemiologica che analizza l’insorgenza di patologie legate al rischio di esposizione a fonti inquinanti. Questo programma si chiama Sentieri – Studio epidemiologico nazionale dei territori e degli insediamenti esposti a rischio da inquinamento.
Oltre ai Sin esistono anche i Siti orfani: si tratta di fabbriche abbandonate, ex stabilimenti, ex fonderie, discariche. Tutti luoghi ad alto rischio di contaminazione in cui però non è rintracciabile il responsabile dell’inquinamento o comunque non provvede agli adempimenti previsti dalle normative ambientali. I siti orfani sono 260 tra nord e sud d’Italia. Per mettere in sicurezza e bonificare queste zone è stato scelto di utilizzare fondi del Pnrr (ambito dell’investimento 3.4, Missione 2, Componente 4).
Per approfondire:
- Inquadramento generale dei Sin, sito web.
- Bonifica dei siti orfani, sito web.
- Sprovieri M., Cori L., Bianchi F, Ambiente e salute nei siti contaminati. Dalla ricerca scientifica alle decisioni, Ets Edizioni, 2021.
- Studio Sentieri, sito web.
SNPA — Sistema nazionale per la protezione ambientale
A cura di Alessandro Coltré — giornalista, A Sud
Questa sigla indica il sistema nazionale di protezione ambientale, ossia una rete che mette insieme le agenzie regionali per la protezione ambientale (Arpa) e l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca sull’ambiente ambientale (Ispra). Le Arpa di ogni regione monitorano la qualità dell’aria, analizzano le acque destinate a uso agricolo e al consumo umano, registrano ogni tipo di impatto ambientale nei territori di competenza. E ancora: le agenzie regionali raccolgono e diffondono dati sul rischio idrogeologico, forniscono supporto tecnico-scientifico alle amministrazioni locali quando c’è da discutere di qualsiasi progetto possa avere un impatto ambientale. A coordinare le attività del sistema nazionale di protezione ambientale è l’Ispra, un ente pubblico indipendente che fa ricerca e monitoraggio sul territorio.
Questa rete è stata costituita tramite la legge 28 giugno 2016, n. 132 “Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente e disciplina dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale”. Attraverso il Consiglio del SNPA, il Sistema esprime il proprio parere vincolante sui provvedimenti del Governo di natura tecnica in materia ambientale e segnala al Ministero dell’ambiente e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, l’opportunità di interventi, anche legislativi, per sostenere lo sviluppo sostenibile, la riduzione del consumo di suolo e la salvaguardia delle risorse naturali.
Per rendere efficaci le azioni di difesa ambientale sono stati istituiti i LEPTA, ossia i livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali, che costituiscono il livello minimo omogeneo su tutto il territorio nazionale delle attività che il Sistema nazionale è tenuto a garantire, anche per perseguire gli obiettivi di prevenzione collettiva previsti dai livelli essenziali di assistenza sanitaria.
Per approfondire:
Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione ambientale, Gazzetta Ufficiale.
Snpa.it, sito web.
Report ambientali Snpa, raccolta delle pubblicazioni ambientali.
Sovranità alimentare
A cura di Associazione Terra!
La sovranità alimentare è un concetto che racconta un preciso approccio politico ai sistemi di produzione del cibo e alla società. Un approccio che si oppone alla visione neoliberale su cui poggia il modello dell’agribusiness. La s.a. pone al centro del dibattito pubblico il cibo come diritto collettivo e non come merce. Un cibo che viene garantito alle comunità locali dal lavoro di piccoli produttori e dalla loro possibilità di determinare collettivamente i sistemi alimentari locali. Un cibo prodotto in sicurezza, nel rispetto della terra, degli ecosistemi e della cultura locale, uno strumento con cui si promuove la giustizia sociale e ambientale. Il concetto è stato coniato nel 1996 da La Via Campesina, in occasione del Vertice mondiale sull’alimentazione. La Via Campesina è un movimento internazionale nato nel 1993 a Mons, in Belgio, per dare voce a contadini e contadine, agricoltori e agricoltrici di piccole e medie dimensioni, a indigeni, migranti e lavoratori e lavoratrici agricoli provenienti da tutto il mondo. La Via Campesina definisce la s.a come “il diritto dei popoli ad alimenti sani, culturalmente appropriati e prodotti con metodi sostenibili e il loro diritto di definire il proprio sistema agricolo e alimentare”. Nel 2022, il Ministero italiano delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali per volere del Ministro Francesco Lollobrigida, scelto dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ha cambiato il suo nome in Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle Foreste. Una definizione che punta a recuperare il concetto coniato negli anni ‘90, svuotandolo però di senso, per declinarlo in chiave conservatrice. L’azione del dicastero presieduto dal ministro Lollobrigida, infatti, punta esclusivamente alla difesa degli interessi nazionali in agricoltura e della produttività, sacrificando i vincoli ambientali.
Per approfondire:
- Via Campesina, sito web.
- Forum for Food Soveregnty, Nyéléni 2007, Mali 2007.
- Associazione Terra!, L’agricoltura nell’era Meloni: si scrive sovranità, si legge sovranismo, 2022.
Specismo
Si rimanda a voce del glossario “Antispecismo”
Terre rare
A cura di Andrea Turco ― giornalista ambientale, EconomiaCircolare.com
Le terre rare sono un gruppo di 17 elementi chimici della tavola periodica: scandio (Sc), ittrio (Y) e i lantanidi. In particolare i lantanidi sono un gruppo di 15 elementi, che vanno dal numero 57 al 71 nella tavola periodica. Nonostante l’espressione, le terre rare non si definiscono tali perché sono introvabili. Anzi, sono più abbondanti del piombo e dell’argento. Tuttavia sono sparse in maniera difforme e il processo di estrazione è molto complesso, nonché notevole dal punto di vista dell’impatto ambientale. Le terre rare sono fondamentali per la doppia transizione ecologica e digitale: le troviamo nei chip dei pc, nei magneti permanenti delle turbine eoliche, nelle batterie dei veicoli elettrici. Ecco perché da tempo a livello globale si registra una corsa all’approvvigionamento. Che però, al momento, vede il predominio della Cina in ogni fase della catena di fornitura. La speranza è che l’aumento della domanda di terre rare venga compensata da un esponenziale ricorso al riciclo.
Per approfondire
- Consiglio Europeo, Un regolamento dell’UE sulle materie prime critiche per il futuro delle catene di approvvigionamento, 2023.
- RivistaEnergia, Cina e terre rare: l’Occidente enfatizza i timori geopolitici per nascondere quelli per la domanda, 2024.
- Camera dei Deputati, Indagine conoscitiva sui risvolti geopolitici connessi all’approvvigionamento delle cosiddette terre rare, 2023.
Tipping Points
a cura di Marica Di Pierri – giornalista e ricercatrice, A Sud
I Tipping point sono punti critici del sistema climatico individuati dall’IPCC (si veda la voce di glossario dedicata). La nozione di punto critico è definibile come soglia di allarme il superamento della quale può comportare lo stravolgimento dell’equilibrio climatico. I tipping point sono stati definiti dal AR5 dell’IPCC come “cambiamenti irreversibili” nel sistema climatico. Pur non essendo definibili con precisione i livelli di modifica del sistema climatico, sufficienti a innescare un punto di non ritorno nel processo, sono stati identificati nove tipping point sia nel sistema fisico del clima che negli ecosistemi colpiti.
I nove punti critici sono:
- l’arresto dell’AMOC (la corrente oceanica atlantica nota come Atlantic meridional overturning circulation, che ha forte influsso sul sistema climatico);
- la disintegrazione della calotta antartica occidentale e della calotta glaciale della Groenlandia;
- la morte della foresta pluviale amazzonica;
- lo spostamento del monsone dell’Africa occidentale e del monsone indiano;
- lo scioglimento del permafrost con conseguente rilascio di gas serra;
- la morte della barriera corallina;
- lo spostamento della foresta boreale.
Il rischio associato all’attraversamento di più punti critici aumenta con l’aumentare della temperatura.
Per approfondire:
- McSweeney R., Tipping Points. Explainer: Nine ‘tipping points’ that could be triggered by climate change. Carbon Brief, 2020.
- Lenton T.M., Rockstr.m J., et al., Climate tipping points – too risky to bet against. Nature, Vol.575, 2019.
Transculturalità
A cura di Rahma Nur – scrittrice e insegnante
Transculturalità: parola formata dal prefisso TRANS che deriva dal latino, nel significato di “al di là”, “attraverso” e CULTURA:” L’insieme delle cognizioni intellettuali che, acquisite attraverso lo studio, la lettura, l’esperienza, l’influenza dell’ambiente e rielaborate in modo soggettivo e autonomo diventano elemento costitutivo della personalità”. Da qui i termini transcultura, transculturalità, che richiamano qualcosa che attraversa la cultura, da non confondere con “multiculturalità”, in quanto si va oltre questo concetto: si vuole evidenziare la specificità delle singole culture cercando in esse quegli elementi universali e comuni a tutti gli esseri umani a prescindere dall’etnia, dalla lingua, dalla religione.
Quando parliamo di transculturalità non pensiamo più al singolo, ma ad una comunità che vuole creare un dialogo e una partecipazione ampia nel superare le diversità per creare una cultura nuova che superi i confini individuali. Questa parola, calata nella scuola, assume un ruolo importante affinché gli studenti “transnazionali” possano superare l’omologazione e la chiusura culturale in quanto portatori di interconnessioni che possono arricchire il sistema educativo nazionale ormai un mosaico di dimensioni, scambi e incroci. Con transculturalità si determina ciò che, come esseri umani, abbiamo in comune trascendendo le nostre alterità e avvicinandoci reciprocamente attraverso le varie forme di arte.
Per approfondire:
- Skuola.net, Interculturalità, transculturalità, multiculturalità.
UNFCCC
a cura di Marica Di Pierri – giornalista e ricercatrice, A Sud
UNFCCC è l’acronimo di United Nations Framework Convention on Climate Change (in italiano Convenzione Quadro sui Cambiamenti Climatici). La Convenzione su firmata nel 1992 nel corso della Conferenza sull’Ambiente e lo Sviluppo delle Nazioni Unite – UNCED (meglio conosciuta come Earth Summit) tenutasi a Rio de Janeiro. L’UNFCCC è il punto di riferimento per la regolamentazione giuridica sovranazionale in ambito climatico e rappresenta il primo strumento internazionale sul contrasto al riscaldamento globale. Non ha carattere vincolante non ponendo limiti obbligatori di riduzioni per i singoli Paesi e rimandando tale compito alla negoziazione di accordi attuativi. La Convenzione è stata ratificata ad oggi da 197 parti. Nel fissare gli obblighi per ciascuna Parte, la Convenzione distingue quelli che ricadono su tutte le Parti da quelli esigibili dai soli Paesi sviluppati inclusi nell’Allegato I.
L’organo supremo del trattato è la COP, la Conferenza delle Parti che l’hanno ratificata, che si riunisce annualmente con il compito di esaminare l’attuazione della Convenzione e degli strumenti giuridici adottati per implementarne gli obiettivi. Oltre alle Parti che hanno ratificato l’UNFCCC possono parteciparvi, in qualità di osservatori, anche altre agenzie delle Nazioni Unite, rappresentanti di organizzazioni internazionali, enti, agenzie e organizzazioni non governative. È in seno alle sessioni della COP che si celebrano dunque, anno dopo anno, le negoziazioni climatiche internazionali. Tra esse spicca per rilevanza la COP21 tenutasi a Parigi nel 2015, nell’ambito della quale è stato adottato l’Accordo di Parigi, strumento applicativo della Convenzione attualmente in vigore.
Per approfondire:
Upcycling
A cura di Letizia Palmisano ― giornalista ambientale
L’upcycling, noto anche come “riuso creativo” (o, impropriamente, “riciclo creativo”), è l’arte di trasformare i prodotti di scarto, gli oggetti in disuso e i materiali inutilizzati in nuovi elementi o in prodotti percepiti come qualitativamente migliori e ai quali viene attribuito un valore artistico o funzionale aggiunto.
Approfondendo l’etimologia della parola, il termine upcycling – il cui primo utilizzo risale al 1994 – deriva dall’unione delle parole inglesi “up” (che significa “verso l’alto”) e “cycling” (che fa riferimento al riciclo). L’espressione venne coniata per essere contrapposta al downcycling. Se, attraverso il riciclaggio, si ottiene «la conversione o l’estrazione di materiali utili da un prodotto e la creazione di un prodotto o materiale diverso», si parla di downcycling quando il valore del prodotto o materiale ottenuto risulta diminuito al termine del processo.
L’upcycling consente di ridurre gli sprechi e prolungare il ciclo di vita dei materiali che, altrimenti, verrebbero gettati via, ma non solo: attraverso tale processo si assicura una nuova estetica agli oggetti, tramutandoli in qualcosa di funzionale, ma, al tempo stesso, anche bello e performante. La spinta creativa, infatti, è fondamentale nella valorizzazione delle potenzialità inespresse del bene, consentendo di trovare nuove destinazioni d’uso per materiali che hanno esaurito la loro funzione iniziale.
Per approfondire:
- Palmisano, Sette vite come i gatti. Ridare valore agli oggetti. Storie di economia circolare, Città Nuova, 2023.
- Nati L., Riciclo e riuso: cosa sono e in cosa differiscono tra loro?, EconomiaCircolare.com, 2021.
- Palmisano L., Riciclare e riutilizzare. Quando le parole fanno la differenza, Terranea, 2023.
Water grabbing
a cura di A Sud
Come il Land Grabbing, la pratica del Water Grabbing si riferisce all’appropriazione e al controllo delle risorse idriche da parte di investitori privati, multinazionali, governi stranieri o altre entità, spesso a danno delle comunità locali e degli ecosistemi.
Questo fenomeno è associato alla crescente domanda globale di acqua per l’agricoltura, l’industria, l’energia e il consumo umano. Come il land grabbing è particolarmente diffuso nei paesi in via di sviluppo. Un aspetto critico del water grabbing è l’impatto sulle popolazioni locali che dipendono dalle fonti idriche disponibili sul territorio per l’approvvigionamento quotidiano. Spesso, queste acquisizioni avvengono senza il consenso delle comunità coinvolte e senza un’adeguata compensazione, portando a una riduzione dell’accesso all’acqua potabile, insufficiente irrigazione per l’agricoltura locale e degrado delle risorse naturali. Il water grabbing può generare inoltre conflitti sociali e tensioni tra comunità che competono per le stesse risorse idriche.
Dal punto di vista ambientale, il water grabbing può avere effetti devastanti sugli ecosistemi. L’eccessivo prelievo di acqua può abbassare le falde acquifere, prosciugare fiumi e laghi, e causare una perdita di biodiversità, con conseguenze particolarmente gravi in regioni già afflitte da scarsità d’acqua e cambiamenti climatici.
Il water grabbing rappresenta una seria minaccia per la sicurezza idrica, mentre sarebbe fondamentale promuovere una gestione equa e sostenibile delle risorse idriche, basata su principi di giustizia sociale e rispetto dei diritti umani. Organizzazioni internazionali, come la FAO e l’UNESCO, hanno sviluppato linee guida e raccomandazioni per garantire una distribuzione equa e sostenibile delle risorse idriche. Cruciale rimane il coinvolgimento delle comunità locali nei processi decisionali riguardanti la gestione delle risorse idriche.
Per approfondire:
- Water Grabbing Osservatory, sito web.
- Bompan E., Geopolitical Atlas of Water, Hoepli, 2019.
- EJAltas, Environmental Justice Atlas. Conflitti legati all’acqua.
Nessun risultato provato. Prova con un’altra ricerca.
Perché un glossario
“Le parole giuste per una giusta transizione ecologica” è un glossario on line, di consultazione libera, rivolto al mondo della comunicazione e allə addettə dell’informazione, pensato per individuare e definire i concetti chiave per una radicale trasformazione in senso ecologico dell’economia e della società.
È stato realizzato nell’ambito delle iniziative a supporto dell’attuazione della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, con il sostegno del MASE.
Il glossario è diviso in quattro sezioni climatiche: crisi climatica, giustizia ambientale, educazione ecologista, economia circolare. I lemmi sono navigabili per temi, in ordine alfabetico o tramite ricerca libera.
Un lavoro collettivo
Il Glossario si configura come lavoro corale e messa a sistema di un pensiero collettivo. Nasce grazie al lavoro di tante persone che hanno messo a disposizione di A Sud e de Le parole giuste la loro professionalità e conoscenza. Il risultato è questo strumento prezioso di orientamento ed approfondimento; un invito a leggere il mondo che cambia da un punto di vista ecologista e circolare. L’elenco dellə contributors che hanno accettato questa sfida collettiva è disponibile di seguito.
Il Glossario è un work in progress. Se credi manchi un lemma importante e vuoi proporti di scriverlo, manda una mail a areacomunicazione@asud.net con oggetto “Glossario Ecologista”. Ti daremo tutte le informazioni per inviarci la tua proposta!
autori e autrici
- ACCIÓN ECOLÓGICA
- ADDAZI GIULIA
- ARIENTI GIORGIO
- ARMIERO MARCO
- ASSOCIAZIONE PER LA DECRESCITA
- BERNARDINI ALESSANDRO
- BONATO DANILO
- CARDUCCI MICHELE
- CERVINO MARCO
- COLTRÈ ALESSANDRO
- DE MARCO IRENE
- DE ROSA SALVATORE
- DI PIERRI MARICA
- DI STEFANO DANIELE
- DOCKERTY GIULIA
- FARGNOLI LORENZO
- FERRETTI JESSICA
- GAINSFORTH SARAH
- GARELLI FILIPPO
- GRECO LAURA
- GREYL LUCIE
- IANNACONE CHIARA
- INDIANO CARLOTTA
- INNOCENTI MATTEO
- PAOLA MERCOGLIANO
- MANGIA CRISTINA
- MANNI LORENZO
- MARANO MARIA
- MARCELLINI NICOLE
- MARTONE FRANCESCO
- MERCALLI LUCA
- MERCOGLIANO PAOLA
- MOCCAGATTA VITTORIA
- MORNIROLI ANDREA
- RAHMA NUR
- PALMISANO LETIZIA
- PERGOLIZZI ANTONIO
- PROSERPIO CARLO
- RENZI VALERIO
- RETE STOP BIOCIDIO
- SANDAL MASSIMO
- SANTUCCI SIVIA
- SCOSSE
- SPLASH*
- SPOSATO PAOLA
- TISCI ALESSIA
- TERRA! ONLUS
- TURCO ANDREA
- VALLAURI UGO
network
Il Glossario “Le Parole Giuste” è un’iniziativa di A Sud, in collaborazione con Fandango Libri, CDCA e Economiacircolare.com.
Il Glossario è stato realizzato nell’ambito dell’Avviso pubblico per proposte di iniziative a supporto dell’attuazione della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile – Vettore “Cultura della sostenibilità” (SNSVS3)”. Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Strumenti e tecnologie per lo sviluppo sostenibile. Direzione Generale Economia Circolare.
